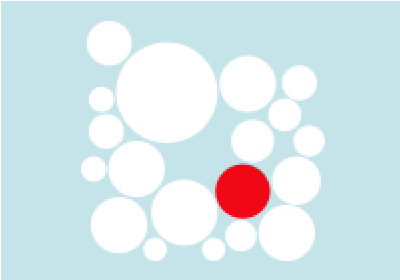INTERVISTA AD ADRIANO AGUZZI
In aumento le ricerche false
ma anche i modi per scoprirle

di Gian Pietro Pisanu
Funziona ancora il sistema di autocontrollo delle riviste scientifiche internazionali, basato su una fitta serie di verifiche incrociate e indipendenti, che per alcuni decenni ha garantito una buona qualità (e affidabilità) dei lavori pubblicati, sia pure con alcune eccezioni? Il dubbio, anzi il grido d’allarme, è stato lanciato dall’autorevole rivista Science, una delle testate al top nel mondo, che ha svelato un fortissimo aumento, negli ultimi anni, dei lavori scientifici pubblicati e poi ritirati, perché contenevano errori o, addirittura, dati falsi. Gli esempi che si possono citare sono numerosissimi. Ci limitiamo a due: in Texas si è verificato il caso di una ricercatrice sul cancro che in un lavoro legato a sovvenzioni ha utilizzato per ben 98 volte campioni del proprio sangue, facendo credere che appartenessero ad altrettante persone diverse. Sempre negli USA, Piero Anversa, cardiologo di fama mondiale che ha collaborato anche col Cardiocentro Ticino di Lugano, pubblicò sulla rivista The Lancet, quando era ancora professore alla Harvard University di Cambridge (Boston), una ricerca “rivoluzionaria” sulle cellule staminali del cuore che poi si è rivelata truccata, in alcuni punti. The Lancet ha ritirato lo studio, e fra Anversa e la Harvard University la vicenda è finita a suon di avvocati, finché la prestigiosa università non ha allontanato Anversa per cattiva condotta scientifica, chiedendone la ritrattazione di 31 articoli che contenevano dati falsificati.
L’elenco potrebbe continuare a lungo. Un’inchiesta condotta da 23 importanti testate internazionali fra cui Le Monde, svela il mondo dell’editoria scientifica priva di scrupoli: per pubblicare su riviste definite predatorie (riviste, cioè, che non possiedono un sistema serio di verifica delle fonti), basta qualche centinaio di euro, e in tempi brevissimi, a differenza di quelli richiesti dalle vere riviste scientifiche, un ricercatore vede il proprio articolo pubblicato, senza alcuna valutazione di esperti, comitato editoriale o peer review, come si dice in gergo. Alcuni vogliono promuovere un farmaco falso, altri gonfiare il proprio curriculum in vista di un concorso: quasi sempre la via della scorciatoia fraudolenta è legata a ricercatori, soprattutto precari, sotto pressione. Il fenomeno è amplificato dal fatto che le riviste considerate serie, quelle con il più alto impact factor (ovvero citate più spesso dalle altre riviste), applicano criteri molto severi nella selezione degli studi da pubblicare e sono spesso inaccessibili. In alcuni casi vengono anche accusate di privilegiare i centri di ricerca più noti e accreditati, e le élite di studiosi che fanno parte di precisi circuiti internazionali.
Per identificare le riviste predatorie, Nature ne ha per la prima volta pubblicato una definizione più precisa, redatta da un panel di 35 ricercatori provenienti da 10 Paesi diversi. Uno studio di tre finlandesi pubblicato sulla piattaforma della Cornell University ha invece evidenziato come generalmente l’impatto, e i conseguenti danni, delle pubblicazioni fake vada ridimensionato: oltre il 59% di quelle prese in esame non veniva mai citato in altri studi, e solo poco più dell’1% veniva citato più di 20 volte.
La battaglia, in realtà, non conosce tregua. Molte testate scientifiche di pessimo valore, che avevano chiuso i battenti dato che avevano perso la faccia, li hanno poi riaperti con altri nomi, quasi sempre altisonanti, pubblicando persino paper (lavori scientifici) prodotti con SCIgen, software del MIT di Boston in grado di generare automaticamente elaborati in apparenza scientifici. È un gioco scellerato che può durare all’infinito.
Per evitare sensazionalismi o banalizzazioni del fenomeno abbiamo cercato di capirne di più con il neuropatologo Adriano Aguzzi, professore all’Università di Zurigo.
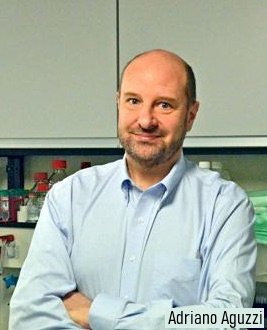
Ritiene che l’incremento numerico delle pubblicazioni fake sia dovuto a un aumento dei ricercatori disonesti, o magari al fatto che oggi è più facile scoprirne le frodi?
«Non credo che ci sia un aumento della frode nella ricerca - risponde Aguzzi. - È una questione di trasparenza: oggigiorno gli imbrogli vengono scoperti più rapidamente. Le frodi sono un problema, la ricerca di bassa qualità è anche un problema, e con Internet, con i social, vi è un livellamento, una mancanza e una perdita di rispetto verso le opinioni degli esperti. Prevale l’idea che le opinioni valgano tutte allo stesso modo. Bisogna però anche chiedersi: qual è il danno che realmente reca la ricerca di bassa qualità? Alla fine le scoperte davvero importanti vengono riprodotte da altri ricercatori nel mondo; se qualcuno pubblica che una terapia funziona, questo viene poi confermato o sconfessato, com’è avvenuto per esempio con la idrossiclorochina e il COVID. I meccanismi di autocorrezione ci sono. Penso che alla fine l’impatto negativo di queste frodi non debba essere sovrastimato. Con alcune notevoli eccezioni, di cui naturalmente quella più disastrosa è stata quella dell’autismo e dei vaccini, che ha provocato morti completamente inutili».
In effetti il caso di Andrew J. Wakefield è terribile: su The Lancet ipotizzò, utilizzando dati inattendibili, che il vaccino trivalente per morbillo, parotite e rosolia potesse causare l’autismo; questa pubblicazione (poi ritirata, dopo alcuni anni) portò a isteria collettiva contro i vaccini e a un enorme aumento dei casi di morbillo con conseguenti morti. Quindi in questo senso la ricerca sbagliata è pericolosa…
«Non c’è dubbio. Sia chiaro, non voglio per niente minimizzare il problema. Però diciamo che per un Wakefield ci sono centomila paper senza alcun impatto, che riportano anche risultati fraudolenti o di qualità infima e non vengono citati da nessuno».
Le pubblicazioni di bassa qualità possono essere arginate?
«C’è un collegamento continuo tra la frode e la ricerca di bassa qualità. Una ricerca con controlli poco convincenti, una ricerca con dei claim esagerati, sono indizi su cui soffermarsi. Ci sono tanti modi di fare ricerca pessima: alcuni sono difficili da identificare come frode, e addirittura - da un punto di vista formale - non sono frode, però possono condurre lo stesso a un "bias" (cioè alla tendenza a pubblicare solo ricerche con risultati positivi, tralasciando quelle con risultati negativi, ndr), disastroso nella percezione dei risultati. È un problema molto complesso, che non può essere trattato con una formula semplice».
Si può fare qualcosa in ambito accademico?
«L’unica cosa che possiamo fare noi docenti universitari è cercare di istituire una cultura che non incentivi la frode. Per esempio, nel mio laboratorio io cerco di premiare le persone che lavorano sodo e fanno cose intelligenti, indipendentemente dal fatto che riescano poi a produrre risultati pubblicabili o meno. Quello che conta per me è partecipare, non vincere. Questo è importante, perché nel momento in cui – e questo purtroppo succede in tantissimi laboratori – c’è una star che viene favorita dal capo perché produce risultati pubblicabili, allora è lì che si creano gli incentivi perversi. Poi naturalmente ci vuole un’energia criminale per compiere una frode, ma la cultura all’interno di un laboratorio accademico scientifico può stimolare o meno un operato scorretto».
PLoS, un insieme di riviste scientifiche di peer reviewing a cui collaborano 61 premi Nobel ha invitato a non confondere la peer review, cioè la cosiddetta revisione paritaria, con un sistema per evitare pubblicazioni fasulle. La peer review rimane a suo avviso un metodo di valutazione valido?
«Ah, non c’è dubbio. Io sono ben lieto di sottoporre a peer review tutti i miei lavori e sono molto grato alle critiche, anche feroci, dei miei revisori, perché mi permettono di evitare di pubblicare cose errate… Si cresce sul confronto. Quello che bisogna capire è che il peer reviewer non è un poliziotto. Il suo compito non è quello di identificare la frode. Il peer reviewer parte dal presupposto che il paper sia stato scritto da persone oneste. L’intero edificio della scienza si basa sul fatto che quando uno scienziato pubblica un paper, ha fatto le cose che descrive di avere fatto. La critica del peer reviewer scandaglia altro: sono le conclusioni davvero giustificate dai dati? Ci sono magari possibilità di spiegazioni alternative? La peer review non è un sistema di auditing, come fosse il controllo dei soldi in una banca».
In Svizzera? Isola felice o al pari del resto del mondo?
«Non credo che vi siano grandi differenze tra i Paesi. La natura umana è quella che è, ovunque. Fino a un certo punto la prevenzione delle frodi scientifiche è uno dei compiti più importanti dei capi di laboratorio, e questo si ottiene, come dicevo, creando una cultura che disincentivi la propensione alla frode. Ma se un dottorando o post dottorando ha la volontà e l’energia criminale di commettere una frode, io sono convinto che un capo di laboratorio non possa farci poi molto».
Le è capitato in tal senso qualche episodio spiacevole?
«Sì. Ho avuto, raramente per fortuna, casi di dottorandi che si sono inventati delle cose. Non ci sono stati grossi danni, però è una pia illusione credere che si possa esserne immuni».
Come in tutte la attività umane, le scelte etiche individuali spingono in un senso piuttosto che in un altro. La responsabilità rimane solo a livello individuale o coinvolge tutto il team?
«Esattamente come nei procedimenti penali, bisogna individuare le responsabilità personali. Solitamente in biologia i paper sono scritti da équipe anche di 10 o 20 persone diverse. Se uno si è comportato in modo fraudolento, questo non vuol dire che anche gli altri 9 o 19 siano stati disonesti. Nelle vicende che si sono verificate all’interno del mio laboratorio io considero me stesso vittima e non responsabile. Alcuni dicono: "Come capo del laboratorio non potevi non sapere…" Si arriva al paradosso che chi ha visto tradire la propria fiducia finisce sul banco degli imputati».
Diceva - aggiungiamo noi - lo scrittore irlandese Jonathan Swift che “la falsità spicca il volo e la verità la segue zoppicando”. Ci piace pensare che per il momento, almeno in ambito scientifico, sia ancora vero il contrario.
Data ultimo aggiornamento 24 maggio 2021
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco
Vedi anche: • Medici e ricercatori: decalogo per difendere la verità
Tags: fake news