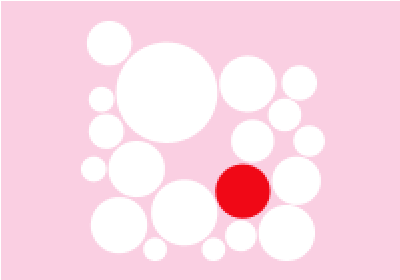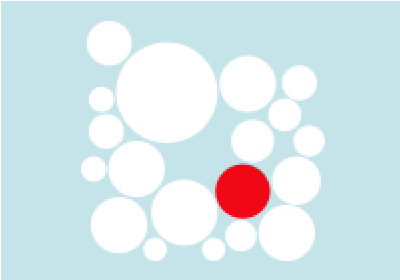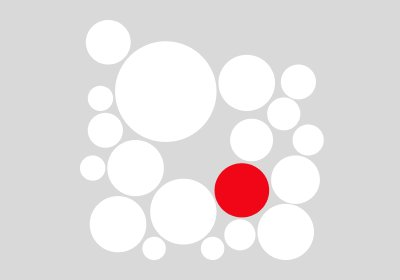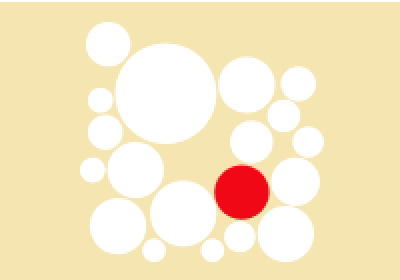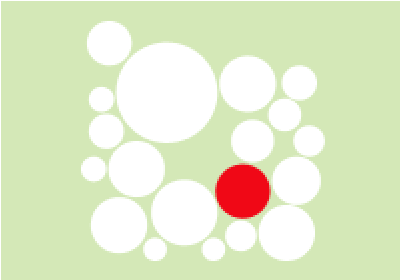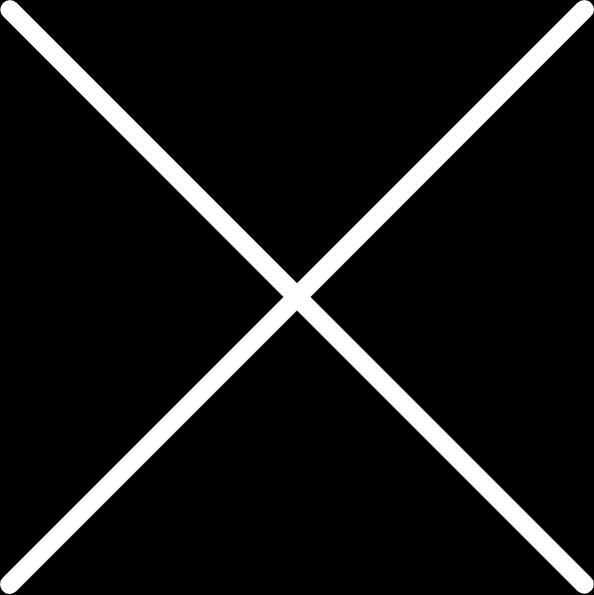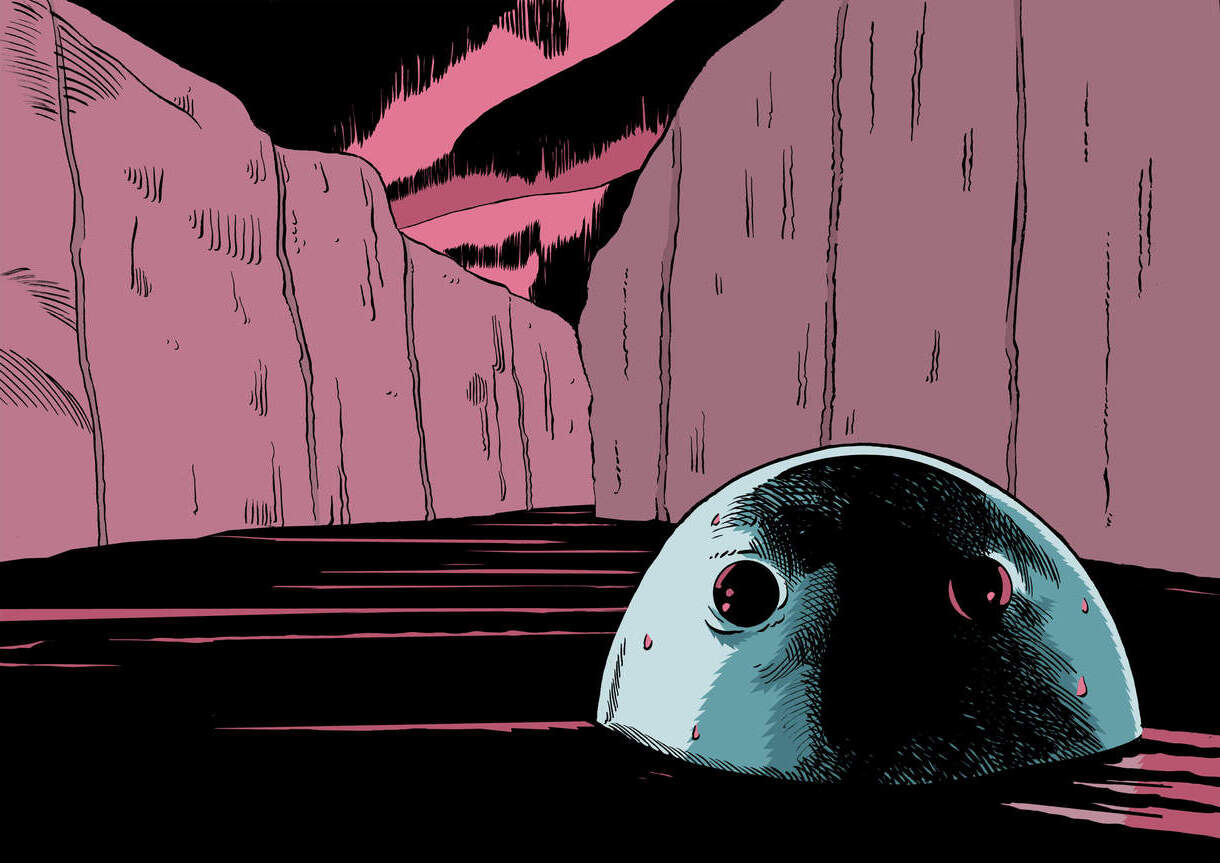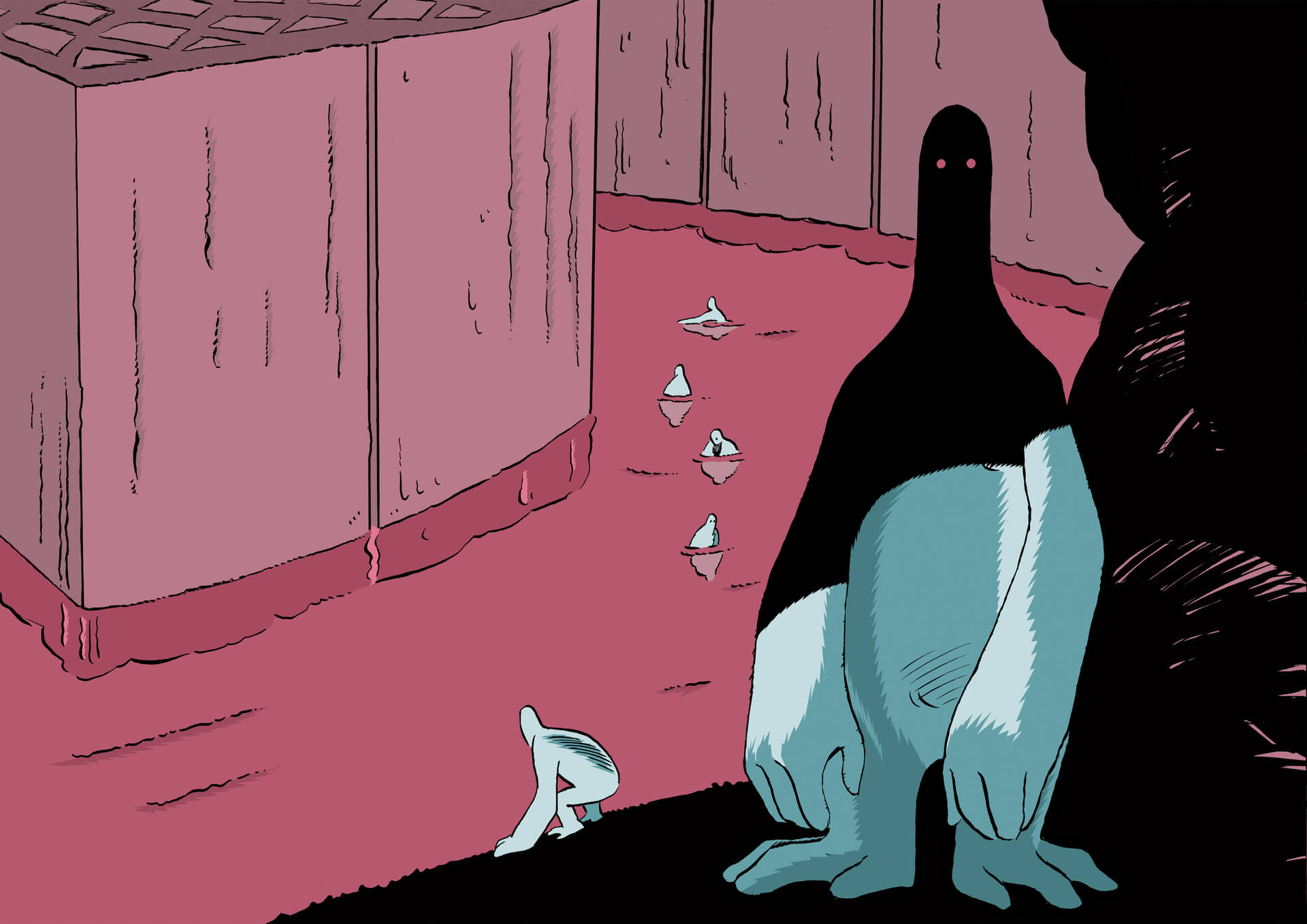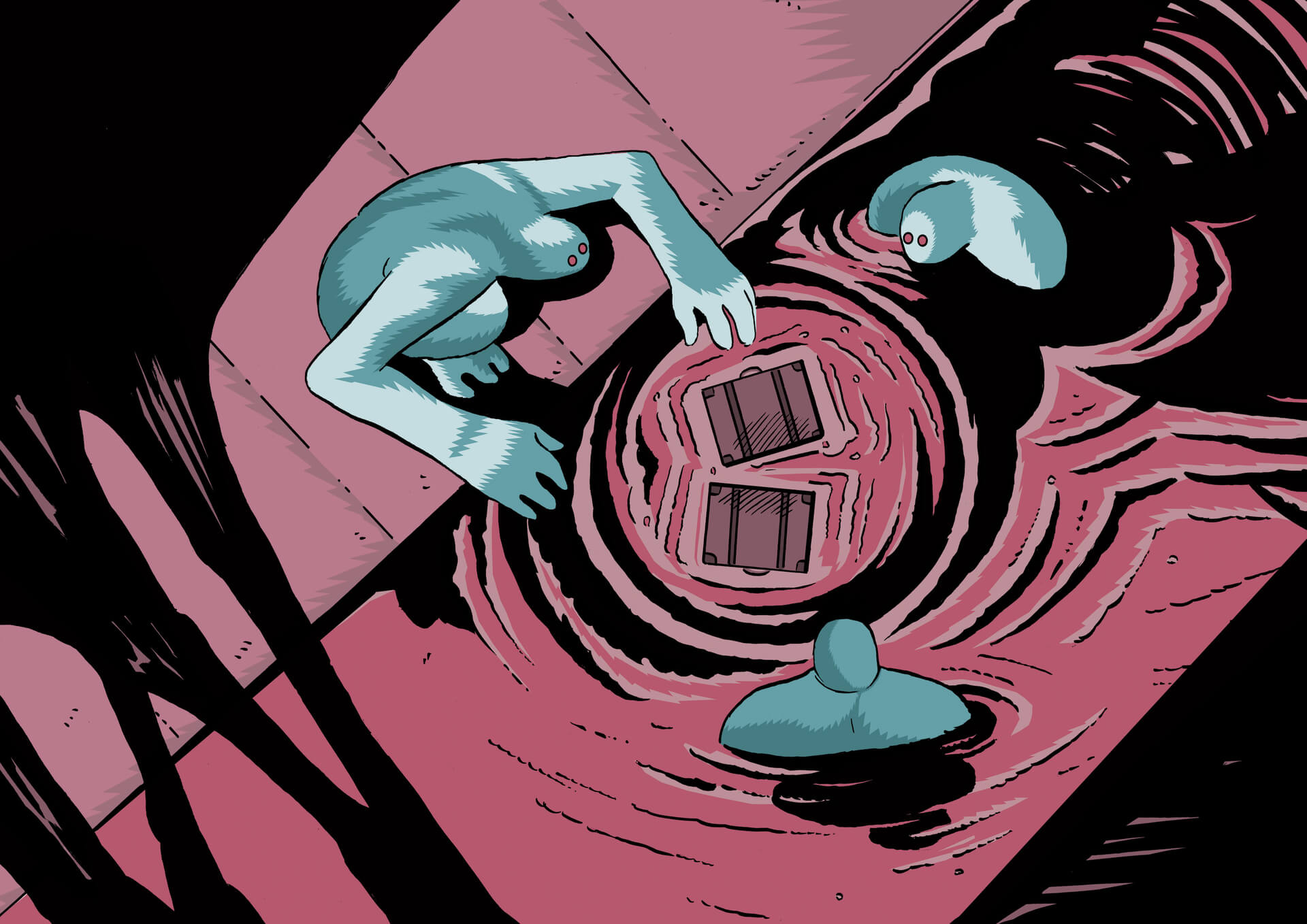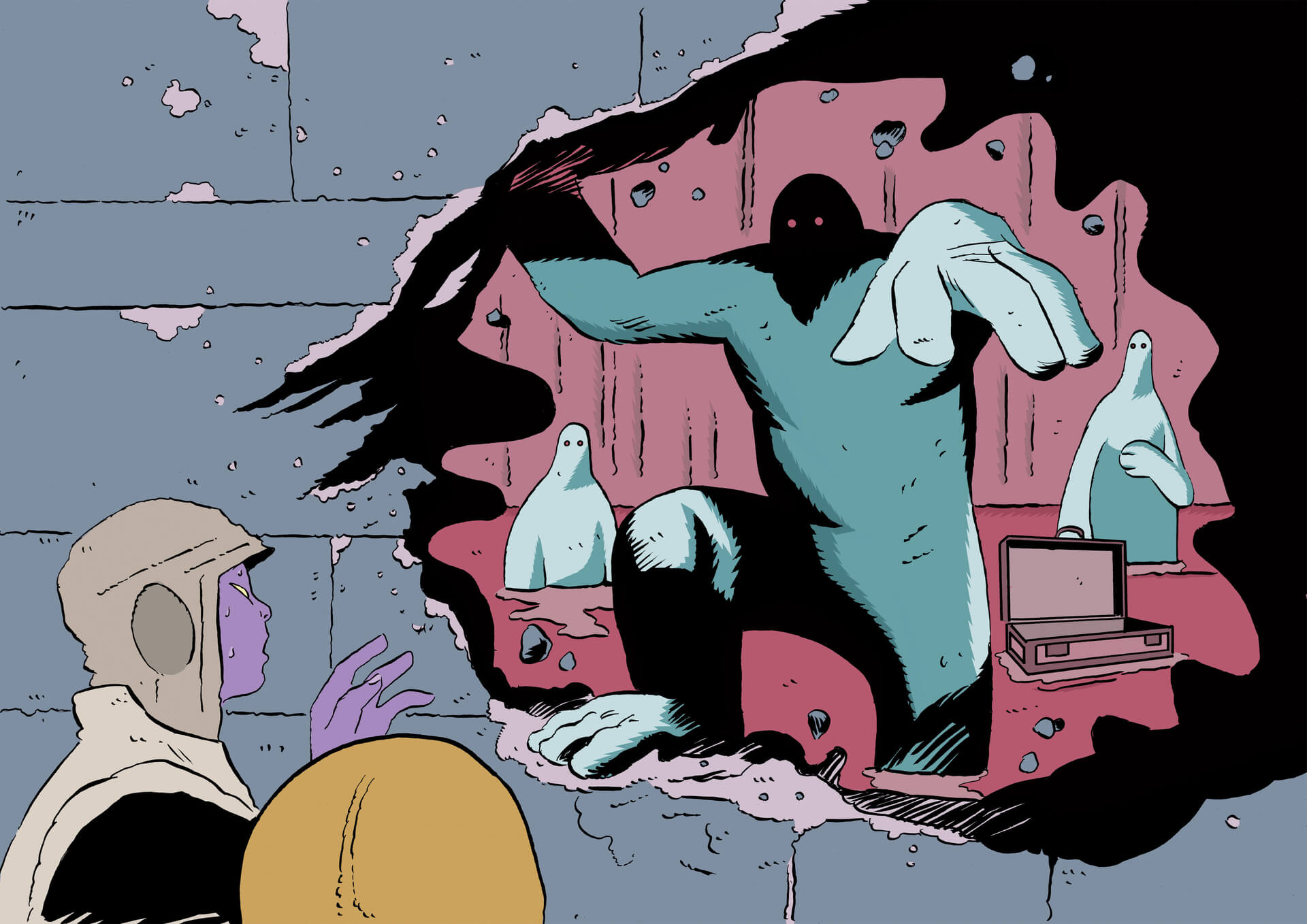STATI UNITI
SLA, dati controversi su due
nuove terapie sperimentali

di Agnese Codignola
In una piccola percentuale delle persone che si ammalano di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), attorno al 2%, la malattia è attribuibile a una mutazione specifica: quella di un gene che codifica per un enzima chiamato superossido dismutasi 1 o SOD1, fondamentale per neutralizzare le specie iper-reattive di questo enzima, che si formano in diversi processi metabolici. Quando SOD1 è mutato, le cellule nervose accumulano detriti tossici, formano neurofilamenti (considerati marcatori della malattia) e muoiono. Per i malati che presentano questa mutazione potrebbe esserci una speranza in più, grazie a un nuovo farmaco, anche se i dati oggi disponibili, enfatizzati prematuramente da alcuni organi di stampa e dalla Biogen, l’azienda che produce il farmaco stesso, in realtà, per il momento, invitano alla prudenza.
La molecola in questione è il tofersen, arrivato alla terza fase delle sperimentazioni cliniche, e messo alla prova in un trial condotto dai neurologi dell’Università di Sheffield, in Gran Bretagna, su un campione di 108 pazienti. La sua modalità di azione è genetica: in sintesi, si tratta di frammenti di RNA messaggero complementari a quelli del gene del SOD1 mutato, chiamati antisenso, che riescono ad accoppiarsi a quelli del malato, impedendo l’espressione dell’enzima sbagliato. Il tofersen va somministrato con iniezione lombare da effettuare una volta al mese, una modalità che comporta il rischio di effetti collaterali significativi.
La SLA, lo ricordiamo, è una malattia neurodegenerativa che porta a una perdita progressiva dei motoneuroni (le cellule nervose che governano i muscoli), fino alla paralisi.
Per quanto riguarda i risultati della sperimentazione, pubblicati sul New England Journal of Medicine, la situazione è in evoluzione. Inizialmente, infatti, lo studio, condotto per sei mesi, aveva fallito i suoi obbiettivi perché, pur essendoci una diminuzione dei livelli di SOD1 (del 33% quando il tofersen era stato dato precocemente, del 21% nei malati con una SLA più avanzata) e dei neurofilamenti (del 55 e del 41%, rispettivamente, nelle somministrazioni precoce e tardiva), non erano emersi miglioramenti clinici di alcun tipo. A quel punto l’azienda e i neurologi inglesi hanno analizzato i dati dei 95 pazienti che avevano prolungato il trattamento di ulteriori sei mesi, con una modalità chiamata studio di estensione in aperto (OLE), e hanno visto un rallentamento della progressione della neurodegenerazione (misurata attraverso alcuni marcatori), accompagnata da qualche beneficio nei sintomi misurato con la scala di valutazione specifica, chiamata ALS Functional Rating Scale–Revised o ALSFRS-R (che va da 0 a 48, dove il punteggio più alto corrisponde a una condizione migliore). Dopo 52 settimane, i pazienti che avevano ricevuto il tofersen in uno stadio precoce avevano perso meno punti rispetto a quelli che lo avevano ricevuto in stadio più avanzato, e mostravano una funzionalità muscolare leggermente migliore. Ma i dati, per ammissione stessa degli autori, necessitano di ulteriori analisi, e sono viziati dall’assenza di controlli adeguati (nella fase OLE tutti i 95 partecipanti avevano ricevuto il farmaco). Il trattamento prolungato, inoltre, aveva portato a effetti collaterali gravi quali meningiti e mieliti nel 7% dei casi. Gli autori concludono che l’unica cosa che si può dire con certezza è che sarebbe meglio somministrare il tofersen in uno stadio precoce (al momento è in corso uno studio su persone con mutazione di SOD1, senza alcuna manifestazione della malattia) perché in questo modo si rallenta la formazione dei neurofilamenti e, di conseguenza, la progressione della malattia (un nesso ancora da dimostrare in modo definitivo). Ciononostante, l’azienda ha già chiesto le prime approvazioni alla FDA (Food and Drug Administration, l’agenzia statunitense del farmaco), che ha assicurato una valutazione accelerata.
Questa vicenda ne ricorda un’altra, altrettanto discussa, relativa a una forma diversa di SLA, non causata da una mutazione del gene SOD1. Negli Stati Uniti è stato infatti approvato un nuovo trattamento, oltre ai due principali usati oggi, il riluzolo e l’edavarone, entrambi scarsamente efficaci: l’AMX0035 dell’azienda statunitense Amylyx.
Il farmaco, inizialmente respinto dalla stessa agenzia, ma fortemente voluto dalle associazioni dei pazienti tra le quali la principale, l’americana ALS Association (che ha contribuito a finanziare gli studi anche con i fondi dell’#IceBucketChallenge, è somministrabile per via orale o attraverso gli strumenti per la nutrizione attraverso la gastrostomia o PEG (di cui i malati hanno bisogno, da una certa fase della malattia in poi), ed è una miscela di una molecola già utilizzata per alcune rare patologie epatiche, il fenilbutirrato di sodio, e di alcuni supplementi che dovrebbero servire a preservare i neuroni.
Il diniego della FDA, giunto nello scorso mese di marzo, era stato motivato principalmente dalla scarsità dei dati. Di solito, infatti, l’agenzia richiede almeno due studi clinici, mentre in questo caso ne era stato presentato uno solo, coordinato dall’italiana Sabrina Paganoni, alla guida del gruppo di neurologi specializzati in SLA del Massachussetts General Hospital di Boston, effettuato su pochissimi pazienti: appena 137. I risultati, anche se sembravano suggerire un rallentamento della progressione del 25% e un allungamento della vita di sei mesi rispetto ai controlli, erano stati giudicati insufficienti. La prima votazione si era quindi conclusa, anche in questo caso, con un 6 a 4 per il no, mentre il farmaco veniva inviato per una valutazione anche all’agenzia regolatoria canadese e all’EMA (l’agenzia europea del farmaco). Ora la svolta, con un 7 a 2 per il sì, motivato da una rivalutazione di quei dati, che porterebbe a dieci mesi il vantaggio della sopravvivenza. La FDA ha quindi deciso di accordare il suo via libera, in attesa di un pronunciamento più completo, e in attesa dei dati della fase successiva della sperimentazione, provenienti da uno studio chiamato PHOENIX, al momento ancora in fase di reclutamento con l’obbiettivo di giungere a 600 pazienti. Il Canada ha approvato la molecola in giugno, l’Europa non si è ancora espressa. Intanto, non pochi neurologi hanno manifestato più di un dubbio su un’approvazione che a molti è sembrata prematura, e non supportata da dati del tutto convincenti.
Intanto, i neurologi del Cedar Sinai Hospital di New York propongono un approccio completamente diverso alla SLA, e rendono noti, sulla rivista scientifica Nature Medicine, i primi, incoraggianti risultati, relativi alla fase 1-2a della sperimentazione clinica, quella che viene eseguita per verificare la sicurezza di una terapia su pochi malati e per avere qualche primo dato sull’efficacia.
La terapia messa a punto dai ricercatori e medici newyorkesi è il risultato di anni di studi, e combina due delle strategie più promettenti nell’ambito delle patologie neurodegenerative e non solo: quella che punta sulle cellule staminali, e quella che si basa sulla somministrazione di geni che possono produrre proteine di interesse. In questo caso, le prime sono cellule staminali degli stessi pazienti, capaci, nei modelli animali, di differenziarsi in cellule di supporto a quelle nervose, gli astrociti. Il gene, invece, è quello di un fattore di crescita per le stesse cellule dendritiche, chiamato glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF). Poiché nella SLA ciò che alimenta la degenerazione è, anche, la perdita di attività delle cellule di supporto, l’idea è stata quella di provare a veicolare nel midollo spinale, in prossimità delle cellule che muoiono (i motoneuroni), le cellule staminali modificate affinché esprimano il gene del GDNF. Una volta giunte in sede, le staminali maturano in astrociti che, in più, secernono il fattore di crescita. In questo modo, dovrebbero continuare a supportare i motoneuroni, frenando o arrestando la progressione della malattia.
Per verificare l’innocuità della somministrazione delle staminali nel midollo spinale, e dopo aver messo a punto uno strumento ad hoc (chiamato CNS10-NPC-GDNF), gli autori hanno trattato i primi 18 pazienti, tutti con una SLA in fase avanzata. E per iniziare a studiarne anche l’efficacia, hanno iniettato le staminali solo da un lato del midollo spinale, prevedendo quindi un eventuale effetto solo da una parte, e lasciando l’altra, non trattata, come controllo.
Dopo un anno, i neurologi hanno potuto dimostrare che non ci sono stati effetti collaterali gravi. Si è infatti solo osservata una crescita di cellule staminali anche al di sopra della sede prevista, in una zona dove ci sono soprattutto cellule che reagiscono agli stimoli, e, in questo caso, i pazienti hanno avuto qualche sintomo doloroso. Per tale motivo, si è deciso che ai prossimi malati l’iniezione sarà fatta una zona più bassa del midollo, per confinare la crescita delle staminali alle aree responsabili del movimento. Inoltre, si è notata la formazione di qualche cellula benigna, probabilmente conseguenza dell’intervento, ma si pensa che si tratti di problemi affrontabili facilmente, dal punto di vista chirurgico.
Per quanto riguarda l’efficacia, invece, si è visto, nelle autopsie dei 13 pazienti che sono deceduti in 42 mesi di osservazione a causa della progressione della malattia, che le staminali erano effettivamente diventate astrociti, e che esprimevano il DNA del fattore di crescita, assente nella parte del midollo non trattata: tecnicamente, dunque, il sistema funziona. Quanto agli effetti sulla malattia, sarà necessario attendere le fasi successive, per valutarli su un campione più ampio di malati che abbiano una SLA non terminale, anche se i dati sui modelli animali (anch’essi contenuti nello studio) e le prime indicazioni dei malati autorizzano a un cauto ottimismo.
Data ultimo aggiornamento 13 novembre 2022
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco