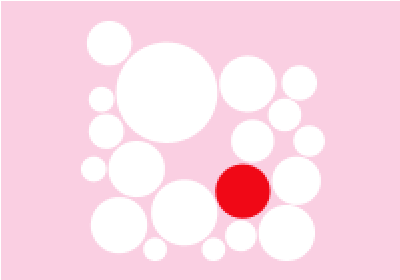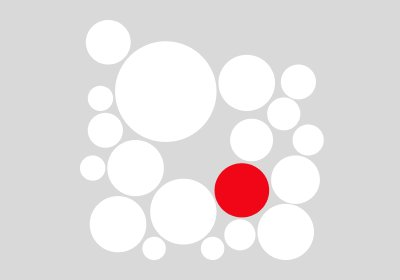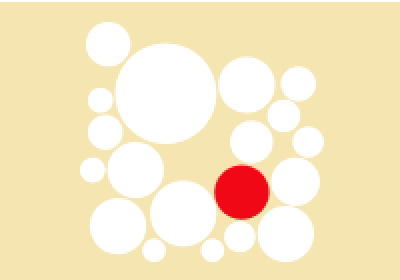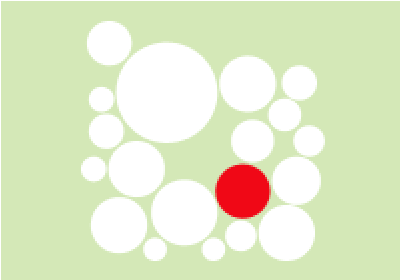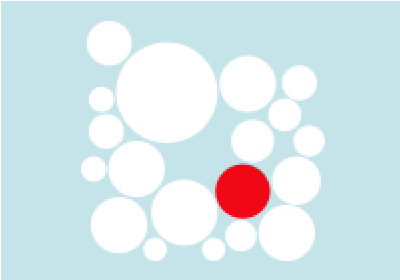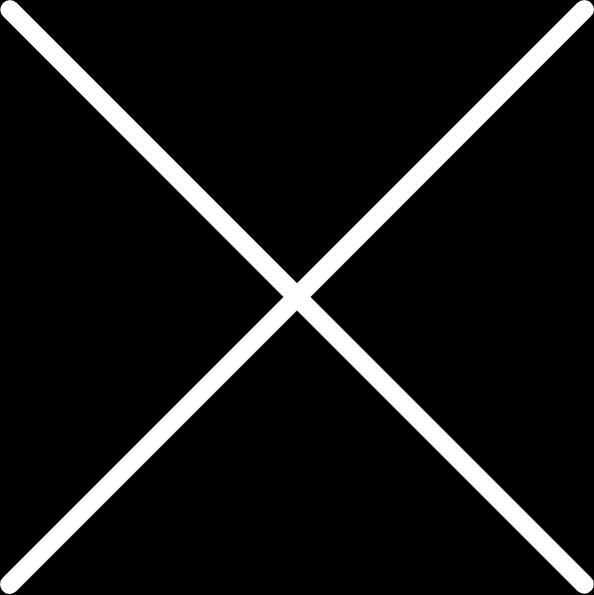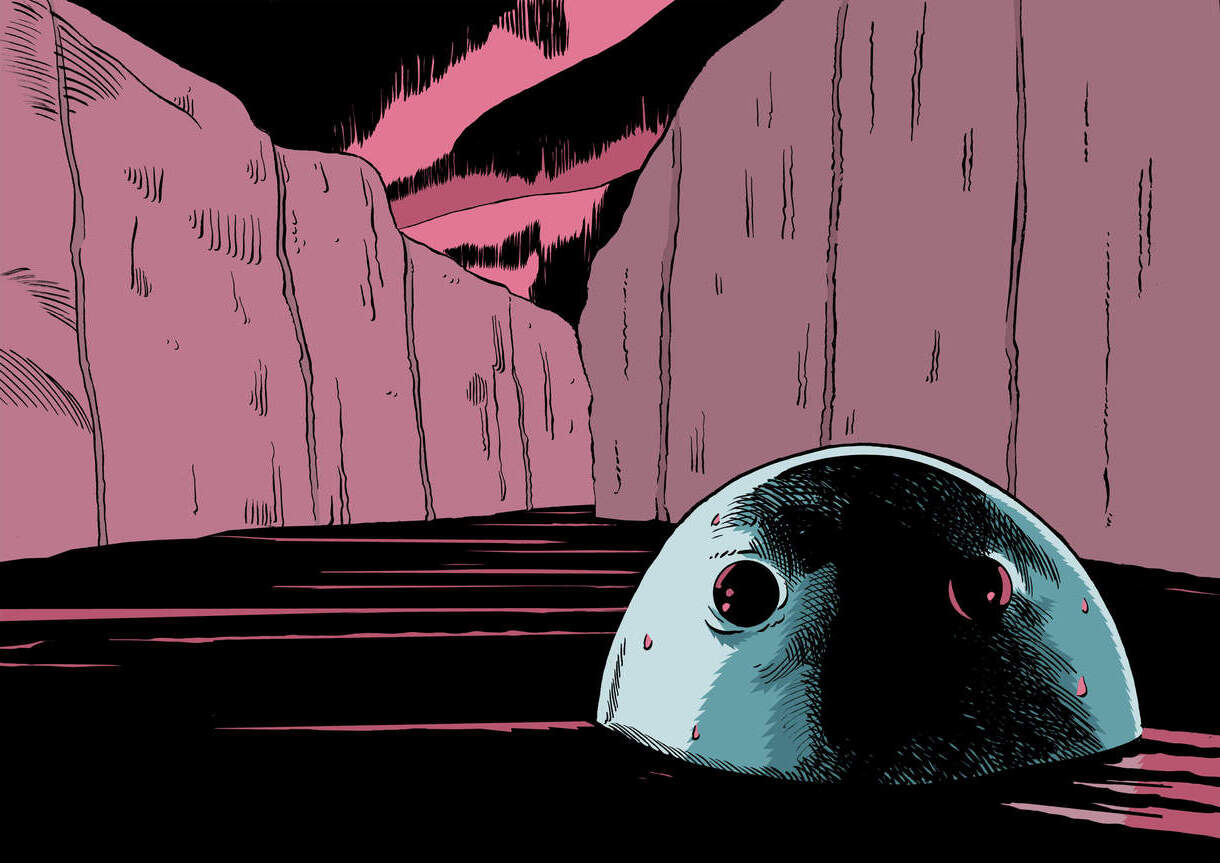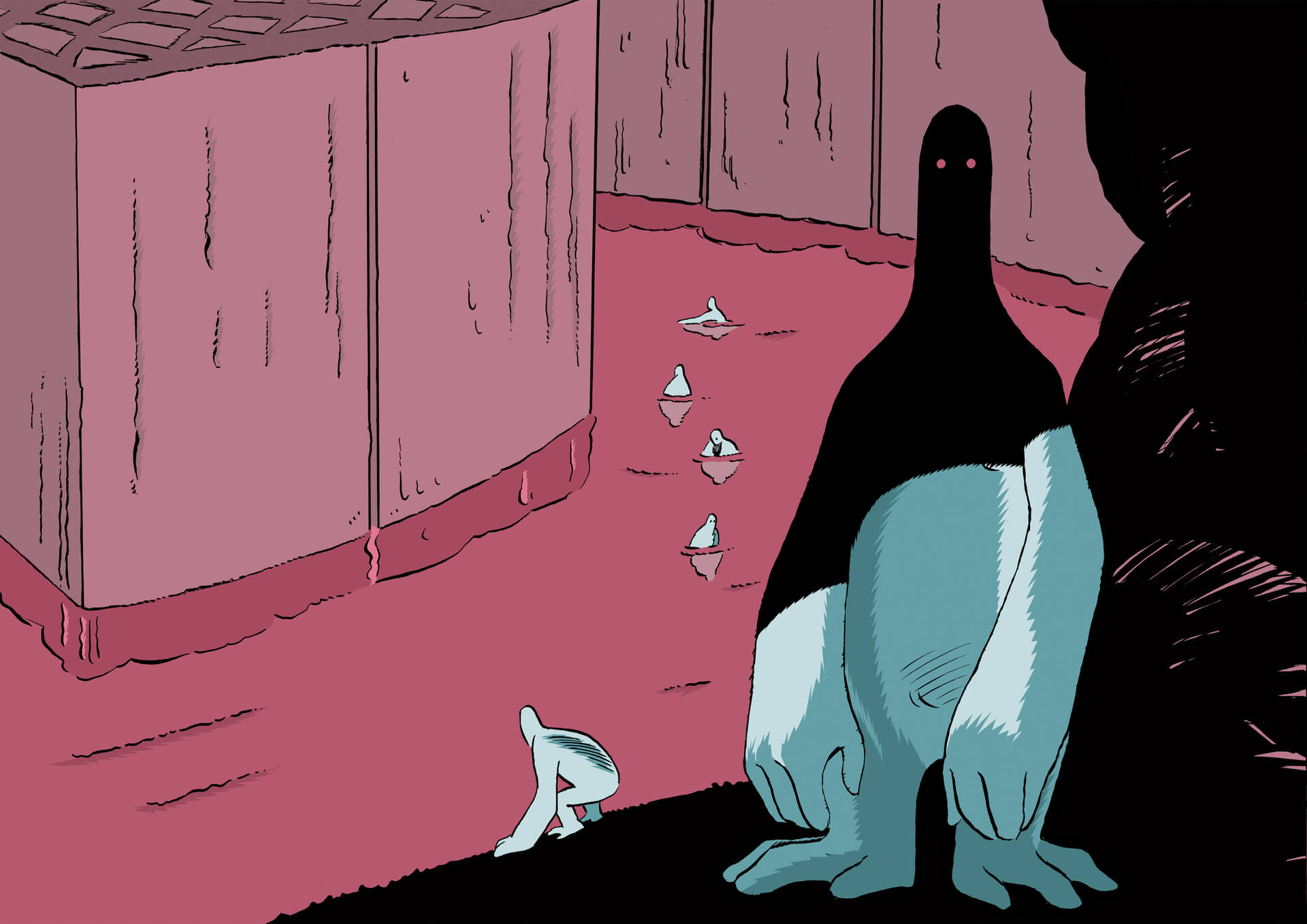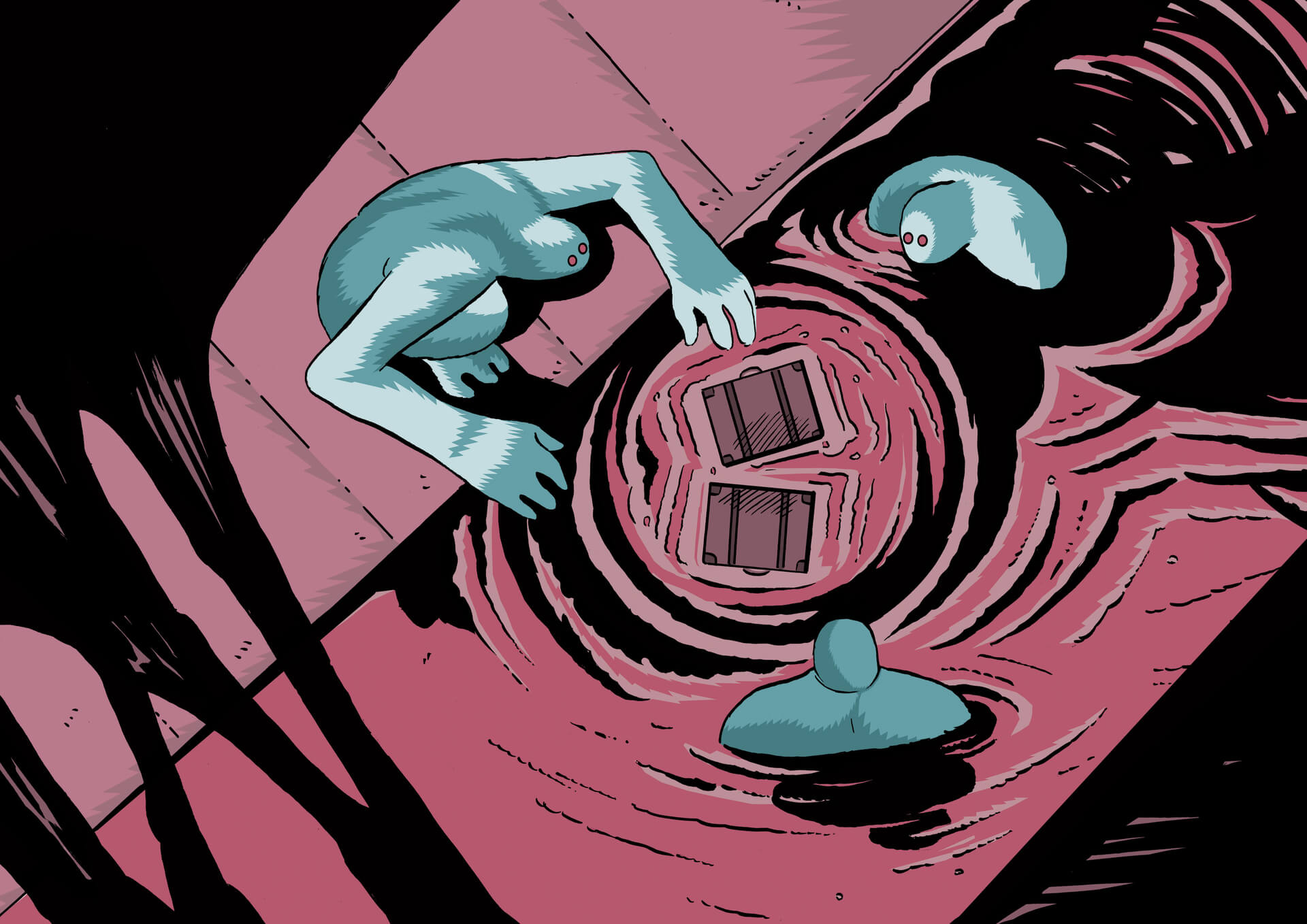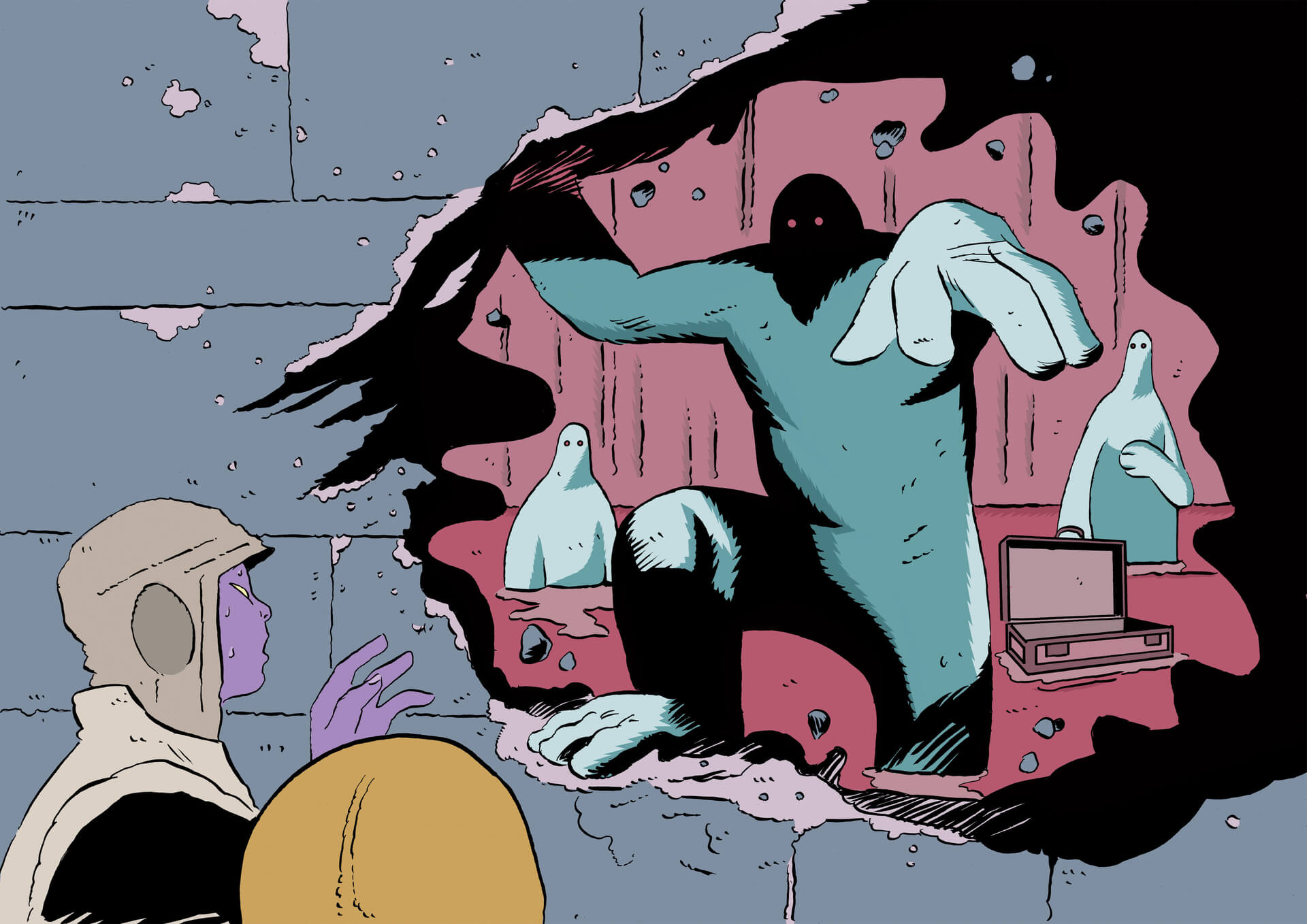AIDS
Ricerca GB conferma: ottimi risultati
dalla terapia preventiva contro l’HIV

di Agnese Codignola
Sono passati trent’anni da quando, per la prima volta, uno studio ha dimostrato che una terapia antivirale assunta durante la gravidanza poteva abbassare del 67% il rischio che il virus dell’HIV si trasmettesse dalla madre sieropositiva al feto. Da allora si stima che 5,5 milioni di bambini siano nati sani grazie a quella terapia preventiva. Ma, soprattutto, quello studio, incentrato su un farmaco chiamato zidovudina, ha segnato un punto di svolta, perché ha dimostrato, per la prima volta, che prevenire il contagio era possibile. E questo ha motivato i centri accademici e le aziende a insistere nella ricerca, e i governi e le grandi organizzazioni a incentivare la prevenzione farmacologica, al punto che oggi diversi Paesi parlano di fine della pandemia di HIV entro il 2030: un orizzonte mai indicato prima, che invece sembra ormai raggiungibile, proprio grazie all’esistenza delle terapie preventive.
Queste ultime si sono evolute fino a giungere a un assortimento dato da due farmaci, tenofovir disoproxil ed emtricitabina, un mix chiamato anche PrEP, cioè terapia pre-esposizione, che ha mostrato di riuscire a prevenire il contagio in una percentuale di persone che varia dall’86% dei primi studi al 99% di quelli più recenti. E ora uno studio di grandi dimensioni, chiamato PrEP Impact Trial, pubblicato sulla rivista scientifica Lancet HIV, consacra ufficialmente la PrEP a ruolo di terapia capace di ridurre il numero di contagi, e quindi da sostenere e proporre alle persone a rischio.
Nell’ambito di questa ricerca, infatti, la UK Health Security Agency (UKHSA) ha reso noti i risultati ottenuti in 24.000 persone alle quali è stata somministrata la PrEP da 157 centri pubblici, che mostrano che, anche nella vita reale, e cioè su un campione estremamente eterogeneo per condizioni, età, altre patologie, gruppo etnico e così via, la PrEP è stata capace di prevenire l’86% dei contagi.
In Gran Bretagna la PrEP, che va assunta una volta al giorno, dal giorno prima a due giorni dopo il rapporto sessuale a rischio, ma che può essere utiizzata anche come terapia di emergenza, dopo il rapporto, è somministrata gratuitamente attraverso i centri specializzati. Le politiche di contenimento dei contagi messe in atto negli ultimi anni in quel Paese sembrano aver funzionato: se nel 2014 i malati erano 5.780, nel 2021 erano scesi a 2.023. Per questo si parla di scomparsa dei nuovi contagi entro il 2030. Ma molto resta da fare, soprattutto per convincere le persone più fragili, spesso appartenenti alle minoranze che ancora soffrono di stigma ed emarginazioni di vario tipo, a rivolgersi agli specialisti e a fidarsi della cura proposta.
Un altro studio, pubblicato negli stessi giorni sul Journal of Prevention and Health Promotion, aiuta a capire che cosa si debba fare per rendere il Paese HIV-free. In esso, infatti, dieci ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni, tutti statunitensi, tutti omosessuali sessualmente attivi (categoria che ha un rischio di contagio che è 28 volte quello dei pari età), sono stati invitati a rispondere a un questionario qualitativo molto dettagliato, finalizzato a comprendere che cosa li trattenesse dal ricorso alla PrEP, considerando anche che, sempre secondo le statistiche, i ragazzi non utilizzano alcuna protezione in almeno un quarto dei rapporti sessuali. Il quadro che ne è emerso conferma che resiste, anche tra i più giovani, una serie di pregiudizi e di convinzioni errate, che li tengono lontani dalla PrEP, a cominciare dal fatto che spesso non identificano correttamente i partner a rischio, e non sanno che la terapia può aiutare.
In generale, molti non conoscono i dettagli della cura, la sua durata, i possibili effetti collaterali e, non di rado, ne ignorano perfino l’esistenza: è quindi improbabile che, chi ne sa così poco, pensi di assumerla. Altri ritengono, spesso sbagliando, di adottare misure preventive sufficienti, o che effettuare test periodici sia una garanzia, e in qualche modo protegga (ovviamente, non è così).
È pur vero che molti hanno anche detto di non aver mai visto poster, dépliant o altro materiale informativo che, quindi, evidentemente, non è distribuito in misura soddisfacente; altri hanno sottolineato di sentirsi in imbarazzo a chiedere la PrEP, anche perché i medici non li hanno mai invitati a farlo. C’è quindi un ampio spazio di intervento a più livelli, che secondo gli esperti dovrebbe prevedere anche un accesso ancora più facilitato alla PrEP, per esempio attraverso la rete, o senza prescrizione.
Ci sono poi realtà molto diverse, dove la malattia ha colpito duramente per decenni, ma dove oggi, grazie ai programmi come quello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la fine della pandemia sembra più vicina.
Per ridurre i contagi fino a livelli minimi, secondo l’OMS è necessario rispettare la regola dei tre 95: il 95% dei sieropositivi deve sapere di esserlo; il 95% di essi deve essere in terapie con antivirali; il 95% dei malati deve avere una carica virale al di sotto dei limiti dei normali test e, quindi, una proliferazione bassissima o nulla. Alcuni programmi, come quello lanciato dagli Stati Uniti una ventina di anni fa, all’epoca del presidente George Bush, chiamato US President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), hanno già permesso l’accesso alle cure a circa venti milioni di persone di 50 Paesi. Inizialmente, la maggior parte di queste iniziative è stata focalizzata sul supporto alle strutture sanitarie e sulla formazione del personale. I piani hanno funzionato, e il risultato è che oggi le necessarie competenze sono presenti un po’ ovunque. Per questo, ora ci si concentra di più sulle terapie e, in modo particolare, sulla prevenzione con la PrEP. Un esempio virtuoso è, in questo senso, quello del Botswana, illustrato in un articolo pubblicato da Nature in occasione della giornata mondiale dell’AIDS, il primo dicembre. Nel Paese, durante il 2008, era infetta una donna incinta su tre. Nel 2022, il tasso era sceso al 24% e un anno prima, nel 2021, l’OMS aveva eletto il Paese a primo, tra quelli a reddito alto e quelli in cui l’incidenza dell’infezione tra le donne incinte è superiore al 2%, ad avere l’obbiettivo di eliminare la presenza del virus tra i bambini, grazie a un articolato programma di prevenzione che non trascura nessuno degli strumenti a disposizione, dalla PrEP alla circoncisione, dai farmaci antiretrovirali ai condom gratuiti, dalle informazioni al personale medico a quelle alla popolazione.
In generale, la situazione è in miglioramento un po’ ovunque, anche se è ancora necessario fare di più, soprattutto in alcuni ambiti specifici. Come riporta sempre Nature, resta lo stigma, e permangono difficoltà logistiche per le campagne preventive. Inoltre è necessario prestare attenzione alle fasce di età più a rischio: secondo le stime, le ragazze tra i 15 e i 24 anni e i ragazzi tra i 25 e i 35 anni. Appartiene alla fascia 15-24 quasi un terzo dei nuovi contagi, ed è quindi sui più giovani che vanno concentrati gli sforzi, sfruttando anche gli strumenti più congeniali ai giovani, a cominciare dai social media, che secondo una metanalisi di una cinquantina di studi possono fare la differenza. Infine, nuovi antivirali potrebbero presto sostituire la PrEP classica, come il cabotegravir, molecola unica capace di proteggere per oltre due mesi dopo una sola iniezione.
I numeri, comunque, sono ancora impressionanti. Secondo UNAIDS (la sessione dell’OMS che si occupa di AIDS); nel 2022, 39 milioni di persone vivevano con la malattia, in due terzi dei casi in Africa. Sempre in quell’anno, i decessi sono stati 630.000, le nuove diagnosi 1,3 milioni (contro 1,5 milioni del’anno prima), e le percentuali di raggiungimento dei tre 95 erano, rispettivamente, 86% (per la conoscenza della propria sieropositività), 89% (per l’assunzione di una terapia) e 93% (per l’azzeramento della carica virale): ancora lontane dalla meta, ma non troppo.
L’obbiettivo dell’eliminazione della pandemia entro il 2030 è quindi indubbiamente ambizioso. Ma, secondo molti esperti, realistico. Sempre che ci sia la volontà politica di raggiungerlo.
Data ultimo aggiornamento 10 dicembre 2023
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco