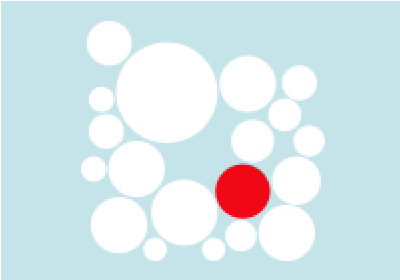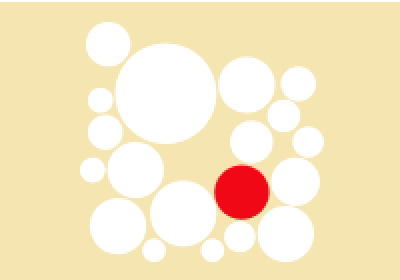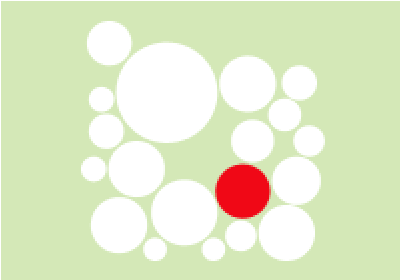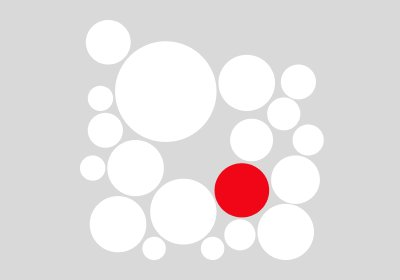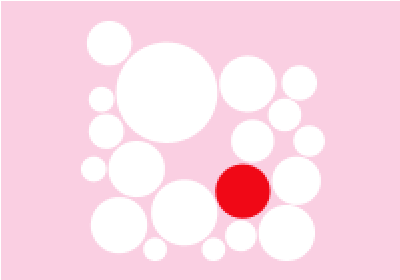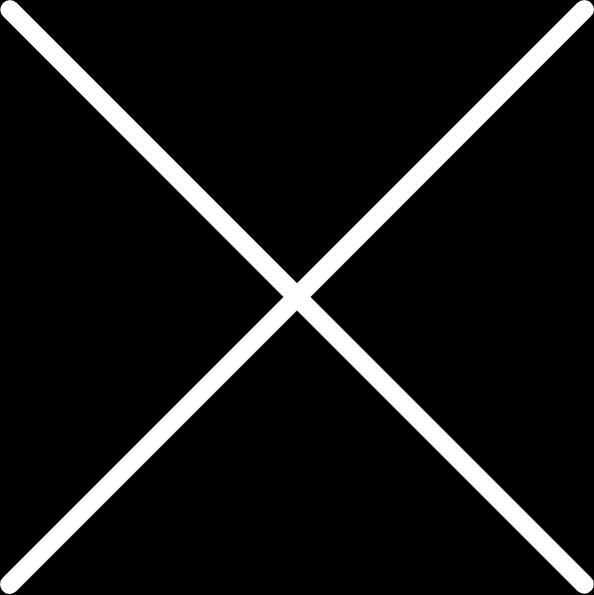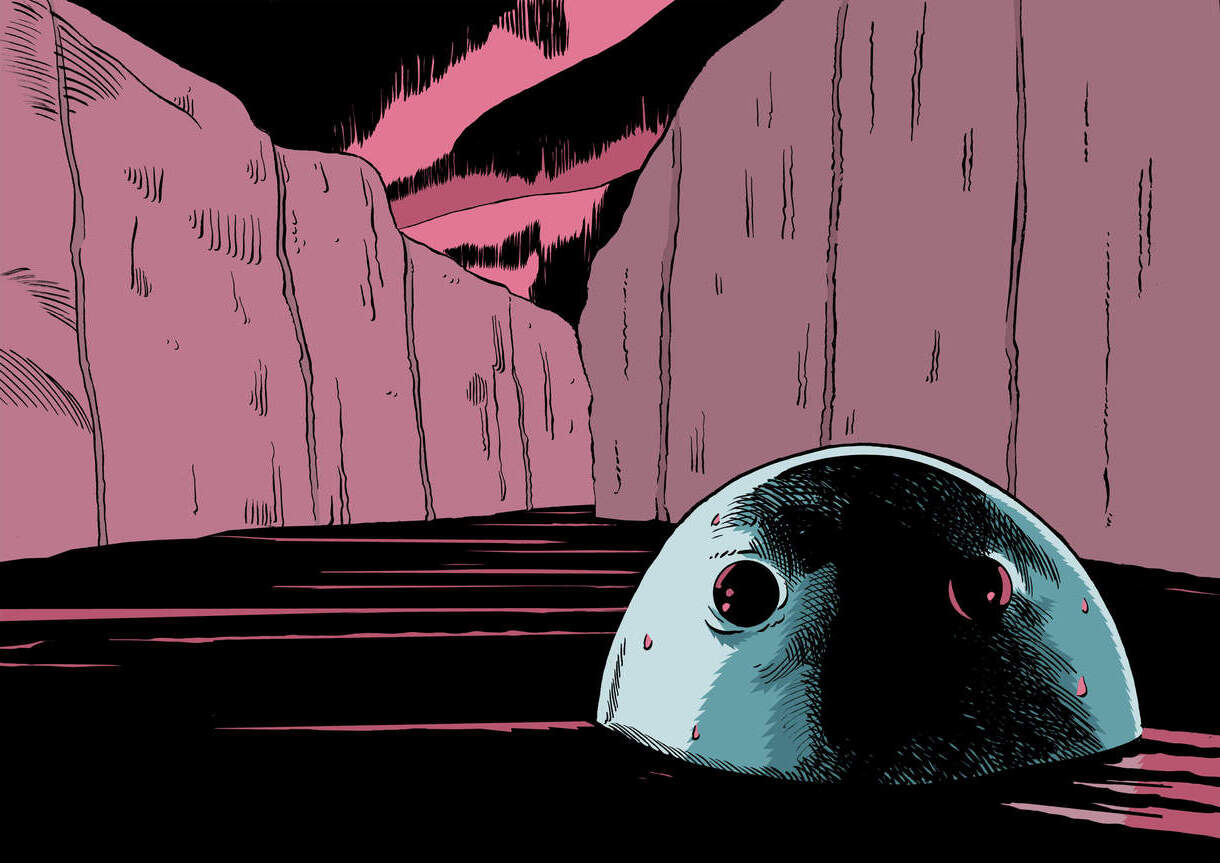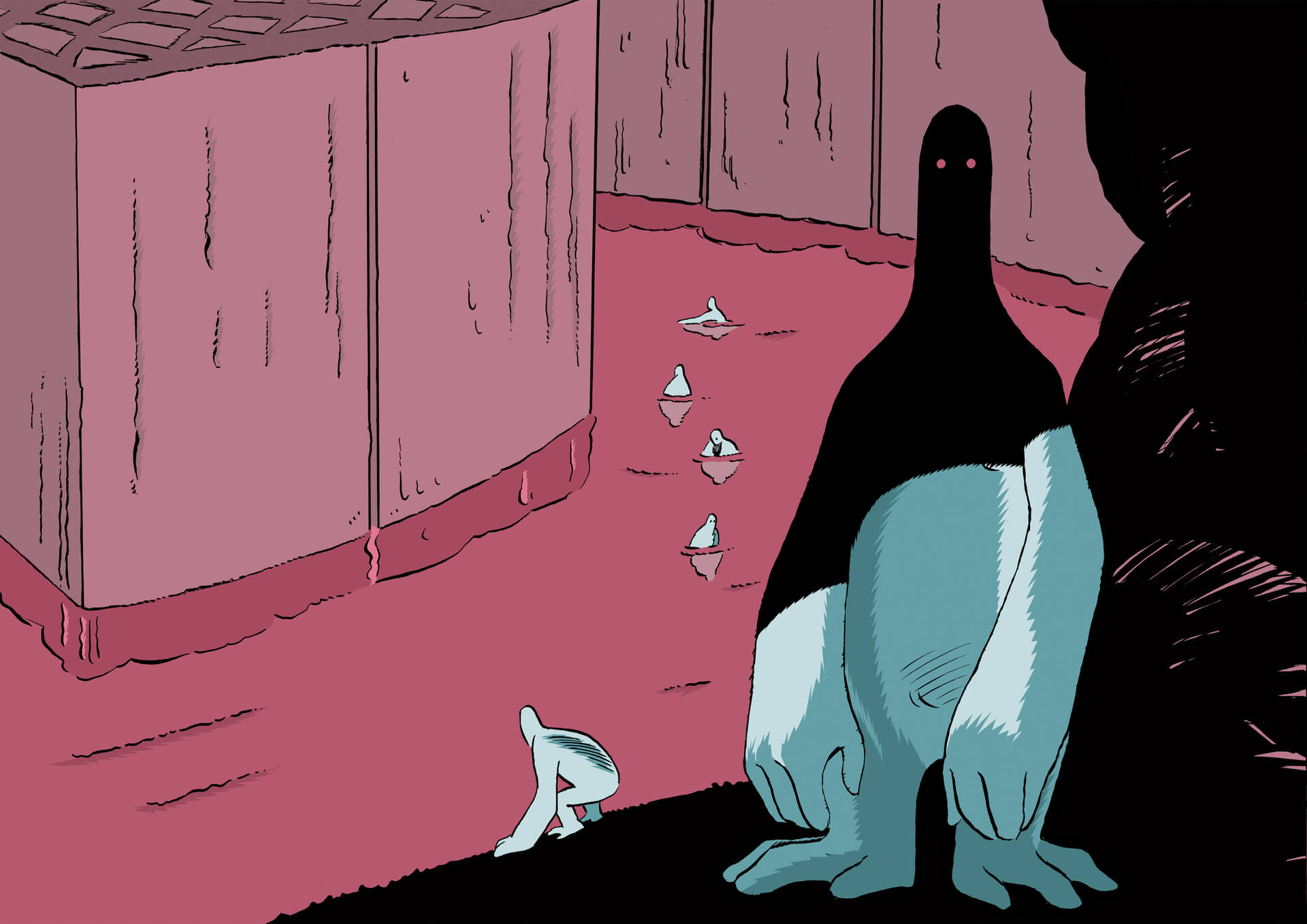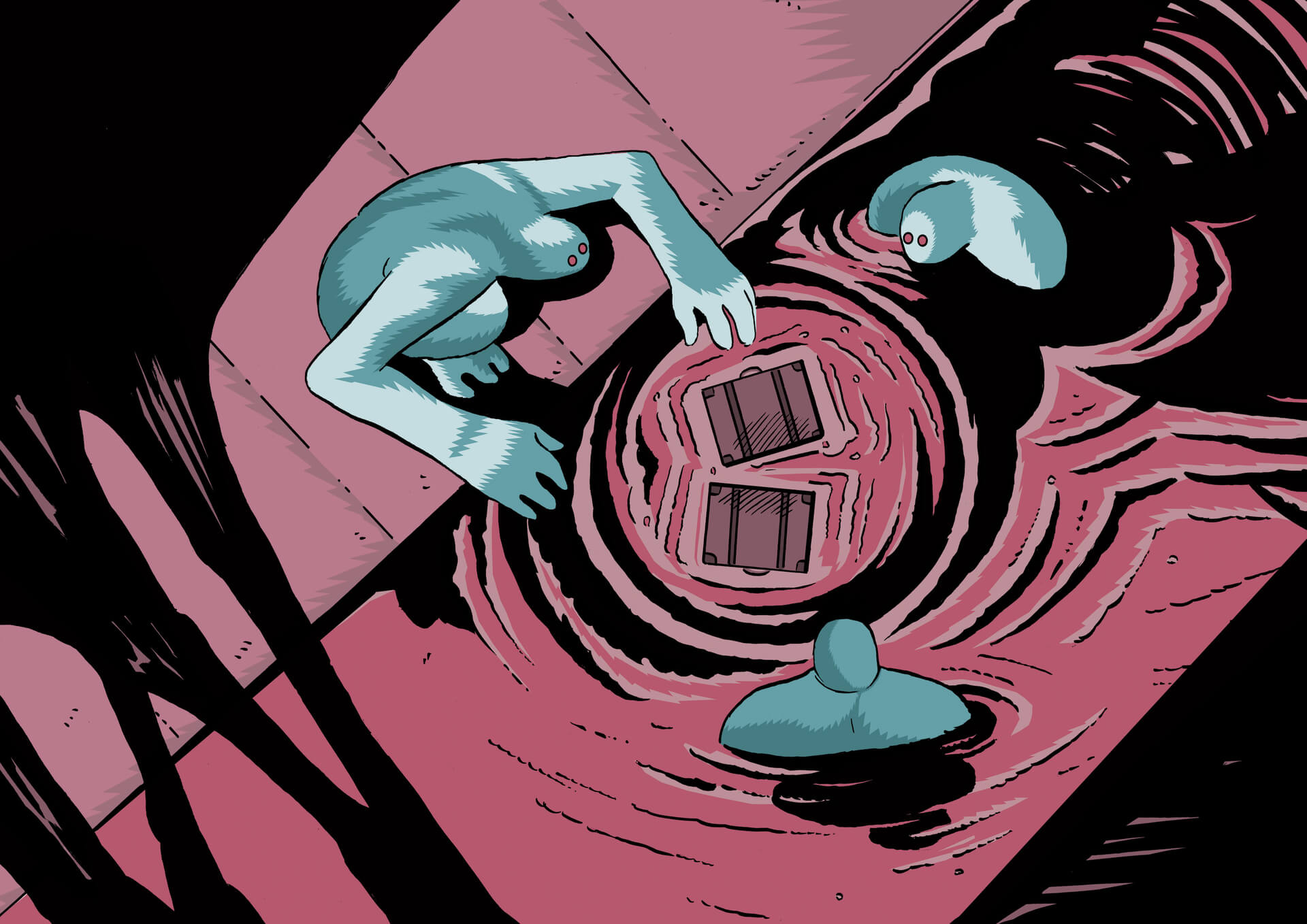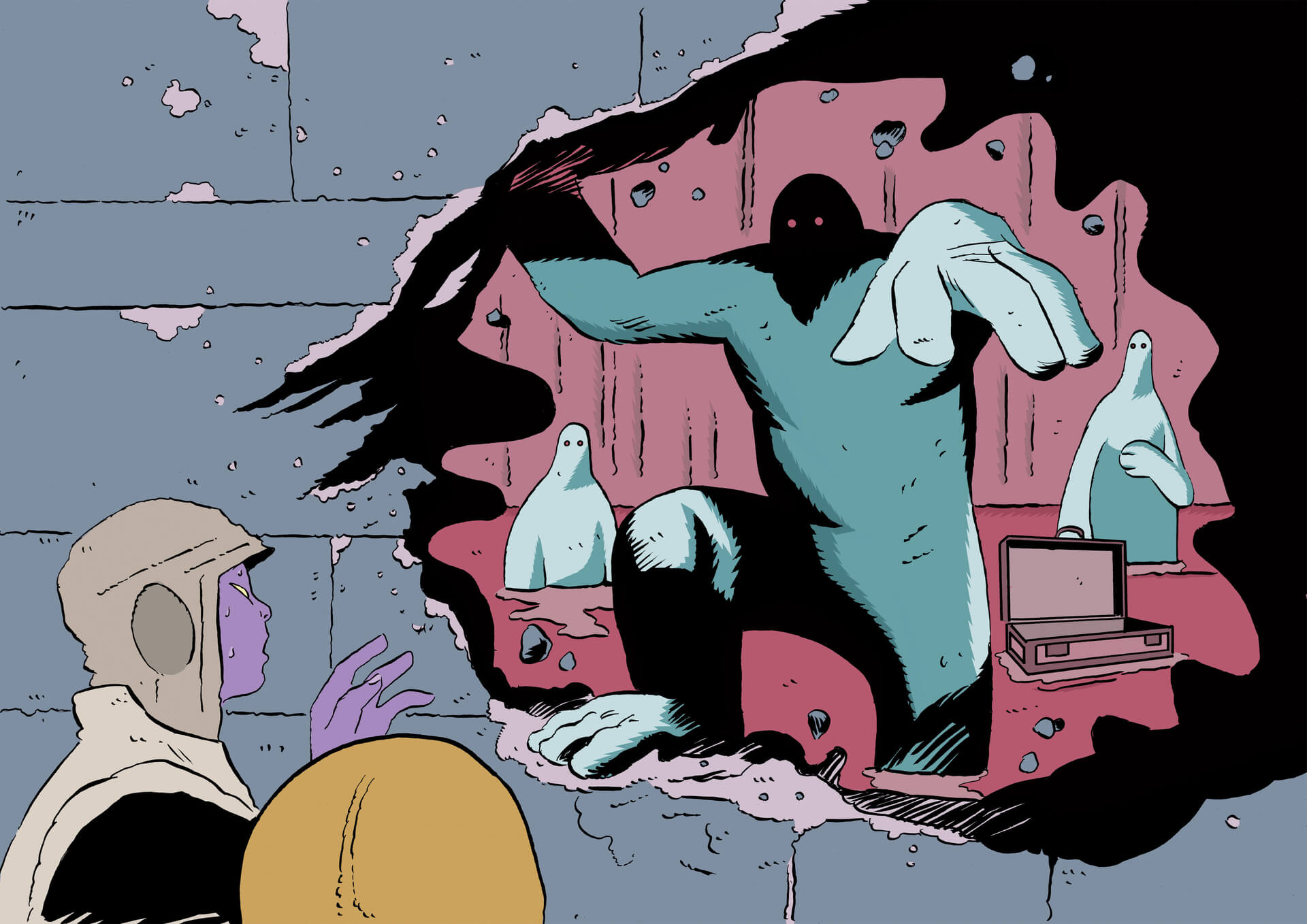OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO
La depressione è lo “strascico”
più frequente nei malati Covid

di Valeria Tuberosi
Esiste una correlazione tra lo stato infiammatorio provocato dal Covid-19 e la sindrome depressiva, nei pazienti che in modo più intenso hanno avuto a che fare con questo virus. Lo dimostra uno studio dei ricercatori dell’ospedale San Raffaele di Milano, guidati da Francesco Benedetti, psichiatra e group leader dell’Unità di ricerca in Psichiatria e psicobiologia. Questo lavoro, in realtà, rappresenta la seconda parte di uno studio iniziato un anno fa, ed è apparso sulla rivista scientifica Brain, Behavior and Immunity. Questa volta i ricercatori hanno analizzato l’impatto psichiatrico, tre mesi dopo la dimissione dall’ospedale, sui pazienti che avevano avuto il coronavirus. Nella prima parte, invece, erano state descritte le conseguenze psichiatriche a un mese dalle dimissioni. Lo studio è stato condotto su 402 pazienti (265 uomini e 137 donne) presi in carico dall’ambulatorio di follow-up dell’ospedale San Raffaele, tramite questionari e interviste cliniche. I controlli periodici, che continuano tuttora (per sei mesi in totale), vengono gestiti da un team multidisciplinare di medici internisti, infettivologi, neurologi, psichiatri, nefrologi e cardiologi.
A tre mesi dalla guarigione, su 226 persone studiate (149 uomini, età media di 58 anni), circa un terzo continuava a soffrire di disturbi psicopatologici come depressione, ansia, insonnia e sindrome da stress post-traumatico. La depressione, in particolare, è quella che ha mostrato di persistere maggiormente nel tempo e la sua gravità è apparsa strettamente legata all’intensità dello stato infiammatorio sistemico che segue le forme gravi di Covid-19, anche per mesi dopo la guarigione.
«Abbiamo avviato questa ricerca – spiega il professor Benedetti – poiché già da un decennio studiamo il ruolo dell’infiammazione nella patogenesi della depressione. Ciò che abbiamo riscontrato è che i pazienti con depressione endogena (che emerge, cioè, senza che si riesca a ricondurla a una causa nota) hanno in realtà, nel sangue, livelli di citochine infiammatorie circolanti molto più elevati rispetto a chi non soffre di depressione (le citochine sono molecole prodotte dal sistema immunitario, ndr). Uno dei meccanismi studiati è stata l’attivazione da parte delle citochine infiammatorie di processi che riducono l’attività di alcuni neurotrasmettitori come la serotonina. Come sappiamo bene, la serotonina è uno dei marcatori più strettamente legati al controllo dell’umore. Quindi – continua il professor Benedetti - queste ricerche post-Covid non sono in contraddizione con quanto già si sapeva sui meccanismi patogenetici della depressione endogena: infiammazione e depressione sono legate. Quando il Covid-19 ha iniziato a diffondersi, è stato evidente che l’infezione, se si trasforma in malattia diffusa, comporta un aumento dell’infiammazione. Questo meccanismo era esattamente ciò che avevamo osservato in precedenza, cioè lo svilupparsi della depressione di tipo endogena».
La prima parte dello studio prevedeva una serie di visite a un mese dalle dimissioni, che hanno evidenziato la comparsa di reazioni di tipo post-traumatico, come ansia e paura, sintomi comprensibili dal punto di vista psicologico, insieme a una sindrome depressiva che risultava più difficile da analizzare, relativa a persone che in qualche modo erano sopravvissute. A tre mesi di distanza, la reazione post-traumatica andava a spegnersi, mentre persisteva la depressione. Si sono verificati, in particolare, due fenomeni: la comparsa di depressione persistente, meritevole di trattamento farmacologico, in una proporzione di pazienti che non avevano mai avuto sintomi depressivi o contatti con la psichiatria, nel 6% dei casi (1 paziente su 20). In chi aveva una precedente storia di contatti con la psichiatria, invece, la proporzione saliva al 30% dei casi. Il secondo aspetto è che, attraverso l’utilizzo di appositi test (studio della memoria, "flusso" delle parole) è stato documentato un imponente calo della capacità di utilizzo delle funzioni cognitive superiori nella quasi totalità dei pazienti (3 su 4). Questa sindrome, chiamata dagli inglesi Covid brain fog (nebbia cognitiva), comporta perdita di memoria, minori funzioni esecutive, e minore coordinazione psicomotoria.
«Ritengo che la scoperta più significativa della nostra ricerca – ribadisce il professor Benedetti – sia che il modello infezione/infiammazione/ depressione viene confermato. I biomarcatori che abbiamo identificato si legano a uno stato infiammatorio persistente per settimane e mesi dopo la guarigione dalla fase acuta. Proprio in questi pazienti continuano a svilupparsi sintomi depressivi e neurocognitivi. L’indice di studio che abbiamo adottato (si chiama indice di infiammazione sistemica) misura l’attivazione di neutrofili e piastrine rispetto ai linfociti. I neutrofili, lo ricordiamo, appartengono alla cosiddetta immunità innata; i linfociti, all’immunità adattiva (sono le due grandi "famiglie" del sistema immunitario, ndr). Ebbene, l’indice era persistentemente alterato ancora a tre mesi dalla guarigione clinica. Quanto più vi è alterazione, tanto più persiste la depressione. Mai erano stati messi in relazione questi parametri ematochimici con sintomi psichiatrici e neurologici».
Durante lo studio sui 226 pazienti post-Covid, sono emersi fattori di gravità differenti, ovvero la predisposizione alla malattia dovuta alla precedente storia psichiatrica di alcuni di essi, e il sesso dei pazienti, che ha influito nello svilupparsi della depressione, poiché questa patologia compare maggiormente nelle donne (2 donne ogni uomo). Il terzo elemento riguarda la presenza o meno di cure: ovvero, chi è stato ospedalizzato (specialmente durante la prima fase dello studio) ha potuto usufruire di trattamenti antiinfiammatori molto potenti (Tocilizumab), e ha, quindi, sviluppato meno sintomi depressivi in un momento successivo. Questo perché i livelli infiammatori durante la dimissione erano più bassi. È avvenuto esattamente il fenomeno contrario in quelle persone che, invece, non avevano ricevuto cure in ospedale.
Anche uno studio americano pubblicato sulla rivista scientifica Lancet, e basato sulle visite prenotate dopo la dimissione ospedaliera da circa 65mila persone che avevano avuto il Covid, conferma che gli stati depressivi sono presenti anche a sei mesi dalle dimissioni dall’ospedale. Dai tre mesi in avanti le principali richieste sono di tipo psichiatrico. «Questa - commenta Benedetti - è la più consistente disabilità post-Covid in chi è sopravvissuto. I sintomi depressivi, inizialmente legati all’infiammazione, poi si prolungano in modo autonomo, e possono durare dai sei mesi ai tre anni, se non curati».
I possibili rimedi che l’équipe del San Raffaele sta studiando e, mano a mano mettendo in pratica, sono molteplici. I farmaci serotoninergici che alzano i livelli di serotonina sono tra i più efficaci, ma non gli unici. La riorganizzazione dei ritmi vitali può essere una delle soluzioni: ai pazienti viene raccomandata la terapia della luce, soprattutto nei mesi invernali, attraverso l’utilizzo di lampade al mattino e di melatonina, la sera, per stabilizzare i ritmi quotidiani. In questi periodi di lockdown, che hanno portato moltissime persone a modificare i ritmi quotidiani con molti momenti di buio, e pochi di luce, la riorganizzazione dei ritmi circadiani (di circa 24 ore) diventa fondamentale.
Un ulteriore sostegno per i pazienti è rappresentato dall’intervento psicoterapeutico di supporto attraverso quattro sedute mirate e interventi cognitivo-comportamentali, per aiutare a riprendere i ritmi normali della vita. Di notevole importanza nel cercare di contrastare le problematiche relative ai deficit cognitivi che nascono dopo infiammazione e depressione possono risultare anche alcuni esercizi sviluppati da programmi computerizzati personalizzati (working memory, allenamento della memoria), che potenziano le funzioni deficitarie.
«Questo primo studio prospettico – conclude Benedetti - dimostra che l’evoluzione temporale tra malattie broncopolmonari, stato infiammatorio e depressione, potrà diventare importante per la pratica clinica futura. Iniziare a comprendere i meccanismi alla base delle forme depressive e le terapie a disposizione può aiutare le persone che hanno affrontato una forma grave di Covid-19 e che adesso soffrono di depressione».
Data ultimo aggiornamento 8 aprile 2021
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco
Vedi anche: • Ecco quando il Covid “disturba” anche il sistema nervoso
Tags: coronavirus, Covid-19, depressione