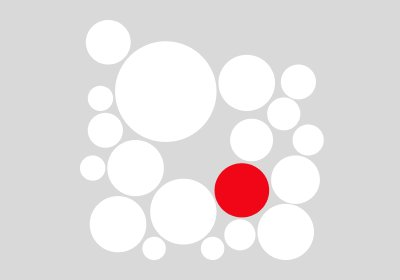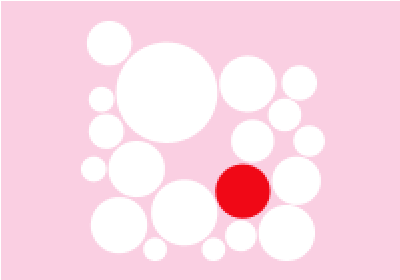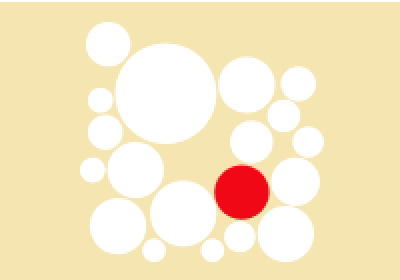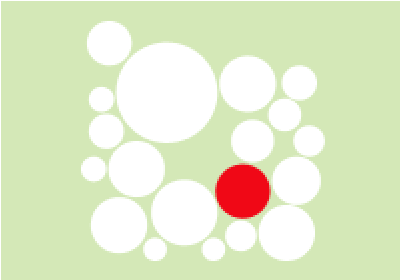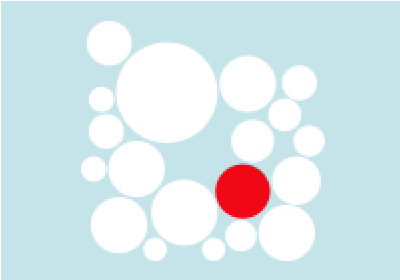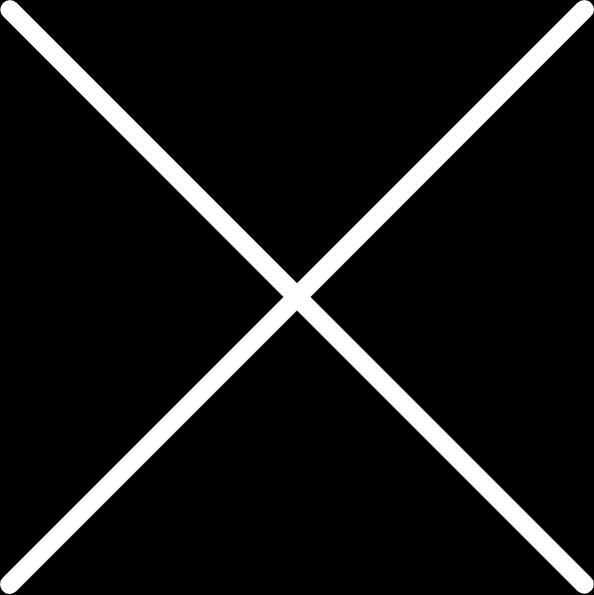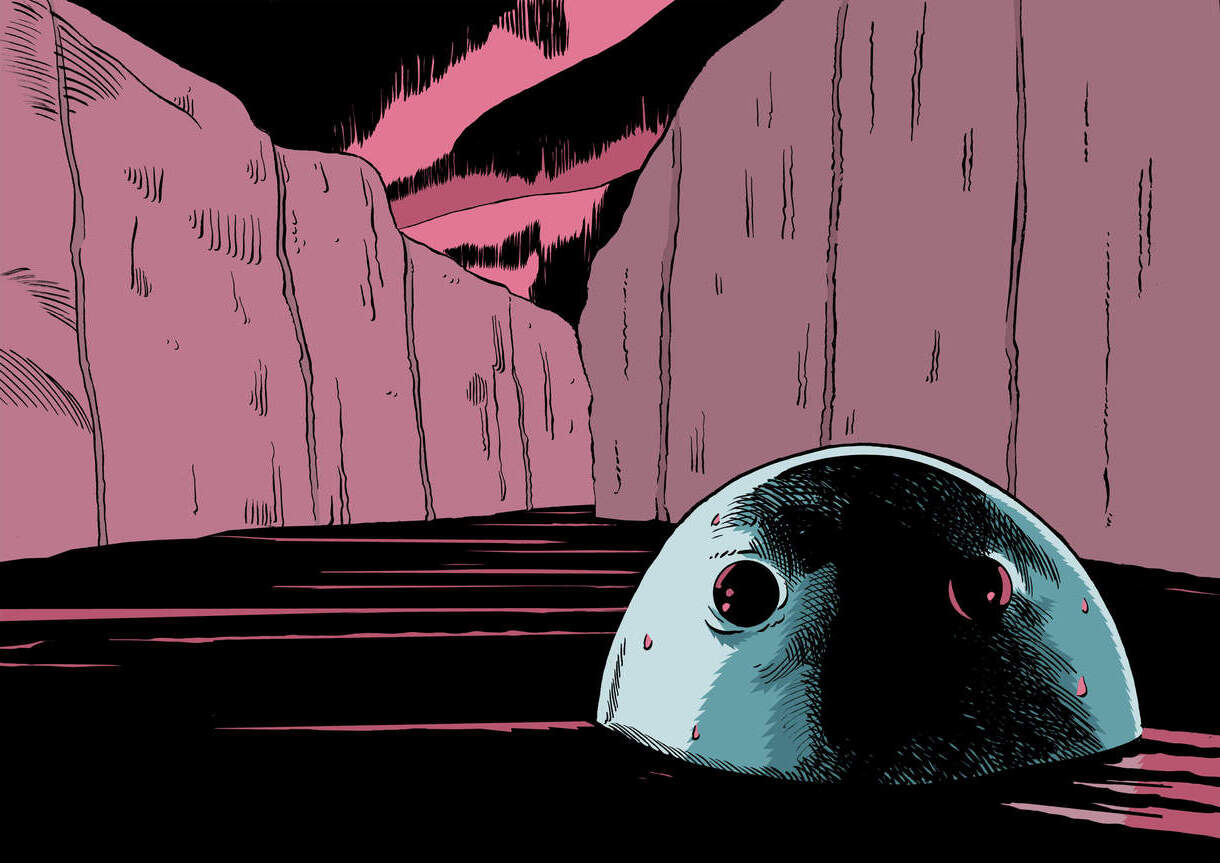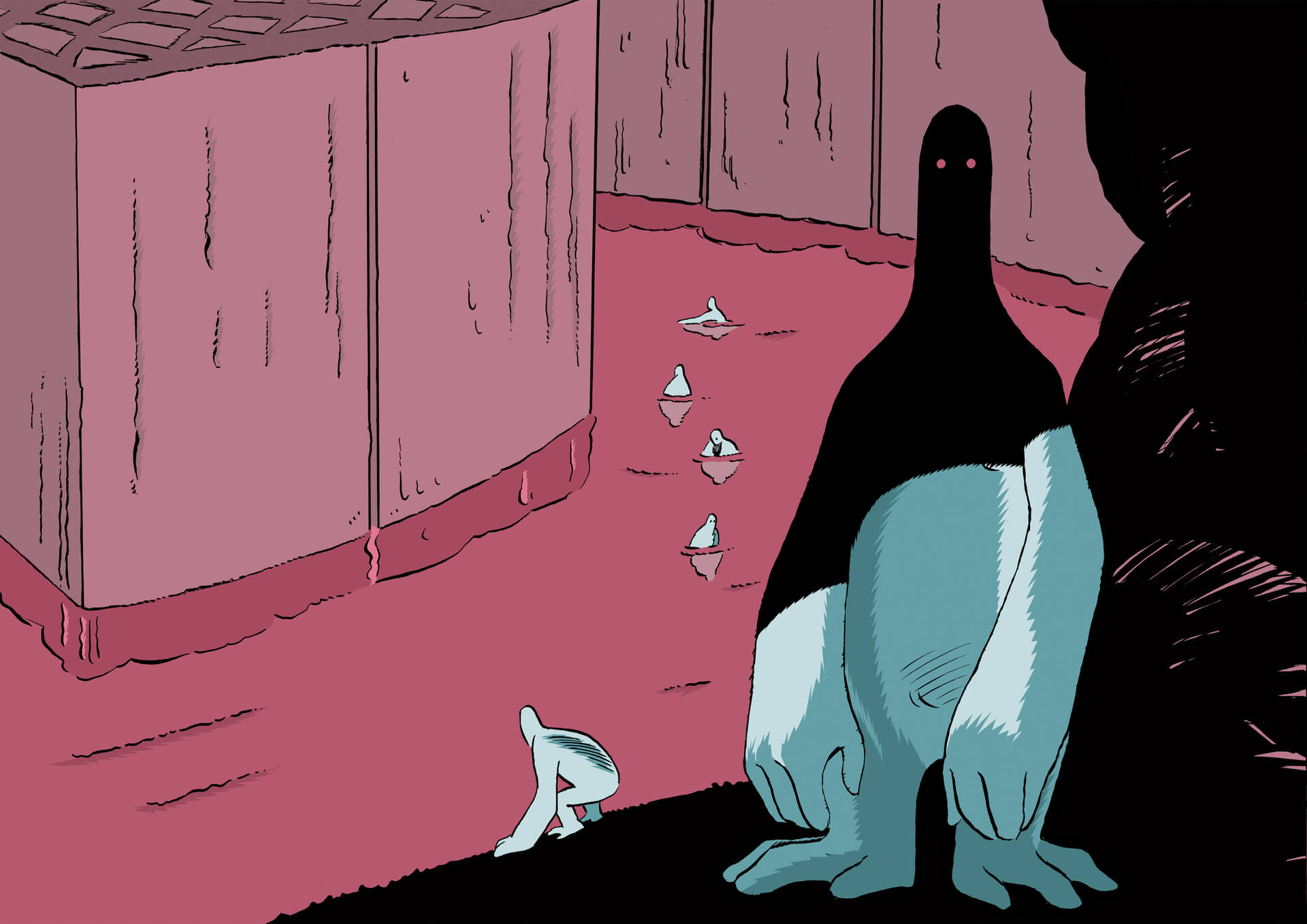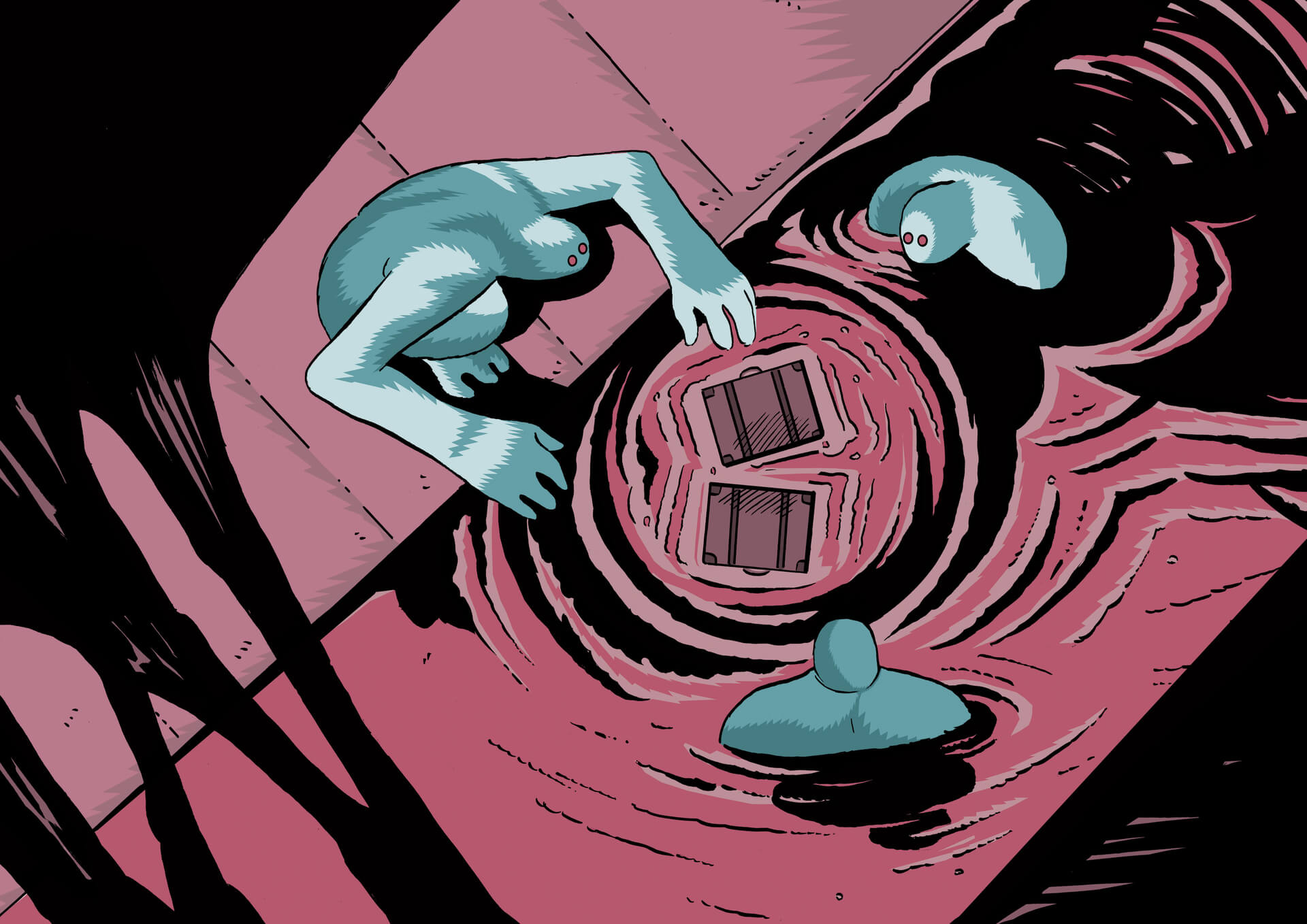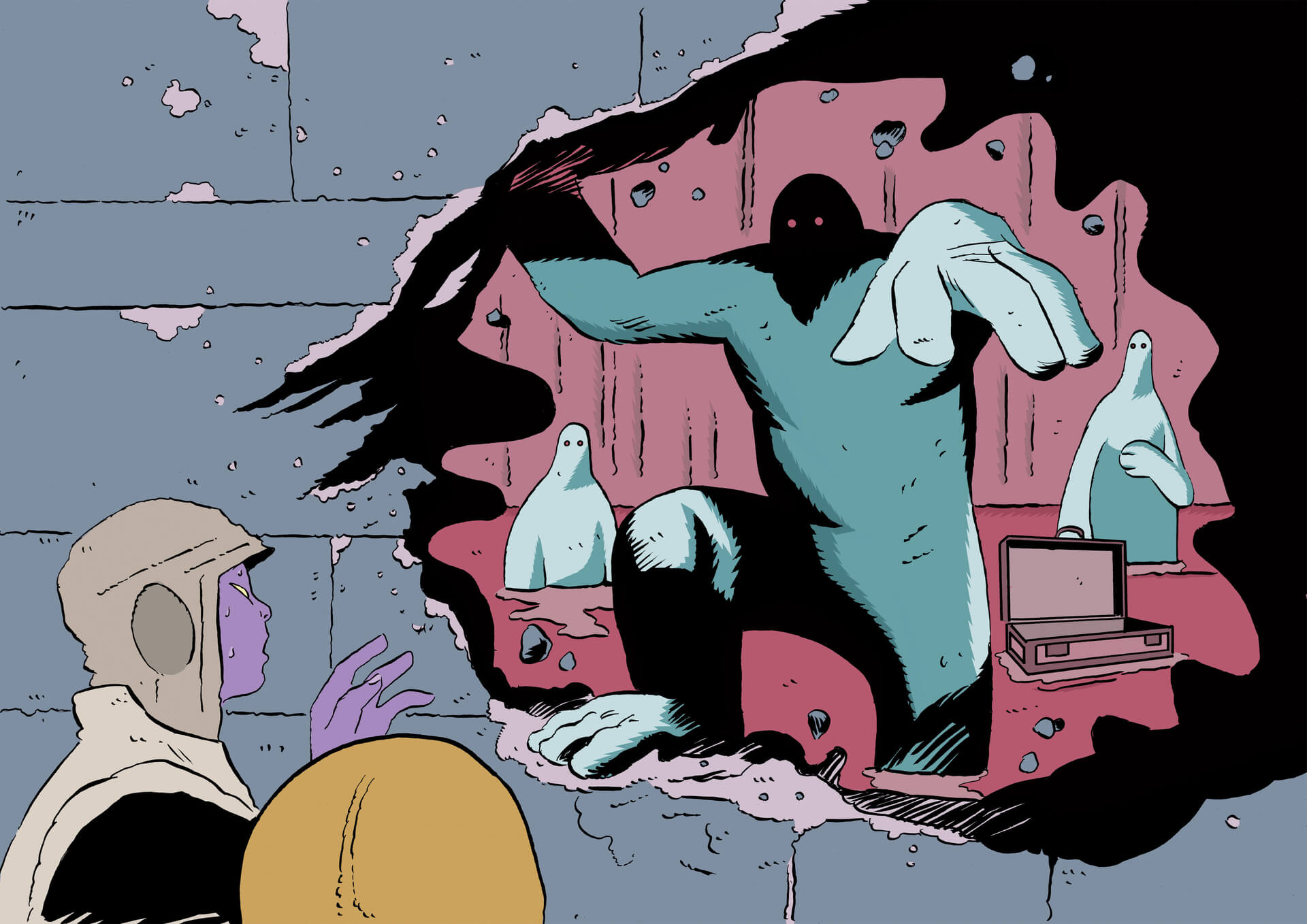AUTOIMMUNITà
L’acqua, che tanto odiavo,
mi ha permesso di rinascere

di Katia Aere
La vita non ti aspetta, devi imparare a mettere in fila una bracciata dietro l’altra per agguantare l’obiettivo. Per me, vivere.
Non importa quanta paura tu abbia dell’acqua.
Ho assimilato durante l’infanzia questa fobia dalla mamma, non mi lasciava andare oltre la battigia. Solo bagnare i piedi, a volte le caviglie. In fondo, nonostante l’atavica paura, l’acqua ha sempre esercitato in me uno strano potere attrattivo, era proibita e per questo tentatrice. Ci sono voluti parecchi anni e tanto dolore, per affondare il mio corpo intero in una piscina. Ci sono volute tante lacrime, quanto una piscina intera, per capire che dentro l’acqua potevo stare davvero bene. Non sentire il peso del mio corpo, delle mie gambe doloranti. E si, potevo finalmente fare una corsa liberatoria. Salvarmi.
L’acqua è l’epilogo, felice, della mia storia.
La mia malattia, anzi le mie malattie, hanno provato a decidere per tutta la vita cosa potevo e non potevo fare. Ma ancora, a 45 anni, difendo con orgoglio e forza, autentici desideri, che poi sono fondamentalmente due: restare a lungo con la mia famiglia e nuotare.
Il destino viene al mondo con noi, con il primo vagito. Io ho avuto fretta di nascere, pesavo appena 1500 grammi, quanto basta per essere condannata nel 1971 al destino fatale di non sopravvivere. È così che ho imparato a lottare: la prima battaglia l’ho vinta in fasce, determinata probabilmente a fare della mia storia qualcosa di speciale.
Per molto tempo ho visto il mondo soltanto dalla culla, in realtà ancora non l’ho visto, impossibile per me decidere una destinazione fare le valigie e partire. Mi accontento di immaginarlo dalla mia città, guardando le scie bianche sul cielo degli aerei che passano, delle persone che si muovono. Non ce l’ho con la vita per quello che mi ha tolto, la custodisco con tanto rispetto e con il sorriso di chi cerca ancora una piuma di felicità. Leggera leggera, piccola piccola.
L’inizio dell’avventura, già così “sfidante” per utilizzare un eufemismo, è per l’appunto solo l’inizio. Ho trascorso la mia giovinezza in pellegrinaggio tra ospedali e sale operatorie. Mi hanno sottoposta a 16 interventi per il mio dolore acuto addomimale. La diagnosi è arrivata soltanto nel 2000 al CRO (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano, dopo 9 anni di atroce sofferenza: endometriosi pelvica e addominale, e atonia intestinale. Il male ha colpito anche il giorno del mio matrimonio e la partenza per il viaggio di nozze. Chissà, forse avrò mangiato qualcosa di più e di sbagliato “per gola”, in ogni caso quel viaggio non l’ho mai fatto. Mai più. L’ultimo intervento ha cancellato anche le mie possibili velleità di concepire. Con il senno di poi, una saggia privazione, perché in pochi anni la mia esistenza si è trasformata in una terribile sfida di tiro alla fune.
Fatica a restare in piedi e fatica a non lasciare terreno al nemico, la malattia.
Ho già ricevuto tre volte l’estrema unzione. Me la somministravano ogniqualvolta pensavano davvero fossi a un passo dall’ultimo respiro, e non sono state poche le volte in cui anch’io ho creduto di lasciarmi andare.
Successivamente alla diagnosi del 2000, avevo imparato quasi a “gestire” le debolezze del mio corpo, aiutata dai farmaci con una dieta ferrea. Ancora oggi devo seguirla, sacrificando frutta e verdura, legumi e tante altre cose, compensando con sacche alimentari per via parenterale. Ma non è sempre facile dire no a tutto quel che mi piace, e capita ancora, in media due o tre volte al mese, di fare i conti con subocclusioni intestinali.
Durante la piccola breve parentesi di normalità, andavo persino a cavallo, sciavo e facevo lunghe camminate in montagna, insomma finalmente potevo condurre una vita accettabile. L’idillio si è presto interrotto e nel 2003 un’altra patologia, ancora più grave delle precedenti, è apparsa, irrompendo quasi come un ladro quando ti strappa la borsetta dal collo. Solo che, in questo caso, non erano i soldi che il ladro cercava, ma la mia stessa vita.
Il 2003 è stato davvero “l’annus horribilis”. Era maggio, era un lunedì, e come ogni settimana iniziavo a lavorare. In ospedale. Nel 1992 sono diventata infermiera: nonostante abbia trascorso la mia giovinezza proprio tra le mura di numerosi ospedali, ho sempre avuto il sogno di alleviare il dolore degli altri. Prima dell’inizio della malattia ero operativa al reparto di Medicina, in seguito sono stata trasferita al Trasfusionale. Ho sempre amato questo mestiere e ancora lo amo tremendamente, anche dietro una scrivania. Perché quel che è successo nel 2003 mi ha costretta a diventare un’infermiera “amministrativa”. Ma non si perde amore e sensibilità maneggiando carte, sono doti che si mantengono per la vita.
Quel maledetto lunedì di maggio ha cambiato tutto, in meno di 24 ore. Facevo fatica a deglutire e avevo dolori al collo, ma pensavo fossero più sintomi dell’influenza che i prodromi di una catastrofe. Scorrevano le ore e i dolori diventavano insopportabili, così i colleghi e il medico del reparto mi hanno convinta a fare subito gli esami. Normalissimi esami del sangue. L’esito non arrivava mai, non riuscivano neppure a dosare il campione, l’unica cosa certa era l’altissimo valore del Cpk a 40mila (la creatinfosfochinasi CPK, è un enzima presente in diversi tessuti, che è coinvolto nella produzione di energia nell’organismo, principalmente per cervello, cuore, muscoli striati). Perciò d’urgenza mio marito mi ha portato all’ospedale di Udine. Ricorderò per sempre la frase pronunciata dall’infermiera che all’arrivo ha preso in consegna i miei documenti: “A che ora è deceduta la paziente?”. E ricorderò per sempre la mia risposta: “Io, sarei viva”. In pratica i valori del sangue erano incompatibili con la vita, questo mi è stato detto più volte, ma io ero inspiegabilmente viva. O almeno ci provavo.
La diagnosi è arrivata presto, purtroppo: Rabdomiolisi massiva da dermatomiosite autoimmune e tiroidite autoimmune. Sono stata ricoverata da maggio a dicembre, e in questo lungo periodo mi hanno somministrato chemioterapici, immunosoppressori e cortisone. Avevo il corpo, torso escluso, ricoperto interamente di ematomi, chiazze che comparivano dal nulla, anticipate soltanto da un pizzicore.
Il dolore ai muscoli, perché questo è il bersaglio della malattia, era talmente violento e insopportabile che l’unico pensiero del giorno e della notte era spegnerlo, come si fa con la radio e con qualunque elettrodomestico rumoroso.
Se avessi potuto arrivare alla finestra sulle mie gambe, probabilmente mi sarei buttata.
Anche il cuscino, le lenzuola, il materasso mi portavano dolori. Qualunque cosa mi sfiorasse appena aveva l’effetto di uno schiaffo, di un calcio. Impossibile dormire accanto a mio marito, poiché anche il più lieve spostamento del suo corpo avrebbe avuto conseguenze negative sul mio.
Ho una malattia rara. Allora esistevano pochissimi posti al mondo specializzati, e pochissimi medici preparati. Ci siamo chiesti se fosse il caso di fare l’ultimo viaggio della speranza, in un centro a Houston, negli Stati Uniti, ma no, io volevo restare con i piedi per terra. Possibilmente in piedi. Abbiamo scelto Padova.
Ho sempre dovuto misurare la saturazione notturna di ossigeno nel sangue. Sapevo che i miei polmoni avrebbero potuto peggiorare con il trascorrere del tempo, faceva parte del bugiardino della malattia, certamente non pensavo accadesse così in fretta. E nel 2005 si materializza l’ennesimo incubo, la mia capacità respiratoria si riduce bruscamente e nel 2008 si aggrava. Avrei dovuto restare sempre attaccata alla bombola d’ossigeno. La notizia allora mi lasciò stordita. Subito ho iniziato a cercare informazioni sul mio peggioramento e ho capito che non mi sarebbe rimasto molto tempo. Per vivere. O per morire.
In effetti l’unica soluzione per frenare il tracollo, di cui gli stessi dottori avevano parlato nel 2003 e che avevo scartato, consisteva nel praticare l’idrochinesi, una particolare fisioterapia in acqua, indispensabile per rafforzare i muscoli del tronco e quelli respiratori.
La terapia quotidiana non bastava più. Come ho detto all’inizio, avevo molta paura dell’acqua, perciò prima di comporre il numero del centro che mi avrebbe seguita per rimettere a posto i polmoni (o quasi) sono trascorsi mesi.
Non un paio di giorni, mesi.
Ho cercato un posto tranquillo a casa, lontano persino dall’orecchio di mia madre, perché quello era un momento tutto mio. È entrato in gioco lo spirito di autoconservazione, credo. Ho telefonato, prenotato la visita e niente, tutto è ricominciato da qui.
Ho imparato a toccare l’acqua. Con le mani e con i piedi, seduta sul bordo della piscina, all’inizio facevo quel che fanno i bimbi quando imparano a conoscerla per la prima volta. Il fisioterapista mi ha aiutata molto, mi ha lasciato aggrappata al corrimano della piscina piccola e aspettato che fossi davvero pronta a scendere in acqua. Piano piano.
Ci sono voluti mesi, la confidenza con il terribile nemico della mia infanzia, l’acqua, iniziava a piacermi. Capivo che quell’azzurro cristallino era lo specchio nel quale potevo guardare ogni giorno i miei miglioramenti (ce ne sono stati parecchi ai polmoni), le mie paure e le piccole conquiste. Vincere sul male che voleva trascinarmi a fondo.
Galleggiare non bastava più, finito il ciclo di riabilitazione, grazie anche al fisioterapista, decido di imparare a nuotare come tutti.
Ho avuto la fortuna di incontrare un istruttore irremovibile (il suo vocabolario non comprendeva il significato della frase “no, non posso farcela”). Eravamo soli, io e lui. Forse la soggezione verso l’autorità dell’insegnante mi ha costretto a impegnarmi doppiamente, così dopo mesi di lezioni private sono riuscita a essere sufficientemente preparata per seguire un corso destinato agli adulti principianti. Normodotati.
Mi vergognavo molto della mia condizione, per arrivare in vasca dovevo muovermi con le stampelle o con la sedia a rotelle. L’autostima all’esordio era vicina allo zero, ma il gruppo mi ha accolto senza riserve.
A volte si fa zapping a caso, per noia, e così ho fatto nel 2012. L’annus mirabilis. La televisione trasmetteva le paralimpiadi e l’intervista al mitico Alex Zanardi. Fino a quel momento non conoscevo molto della sua vita dopo il terribile incidente, ma vederlo trionfante con quattro medaglie d’oro al collo mi ha lasciato proprio ammutolita. Ho pensato che se lui era stato capace di ritrovare motivazioni per ricominciare a vivere, potevo farlo anch’io. Ho preso informazioni sulle società sportive vicine alla mia città, volevo fare ancora di meglio. Nuotare e gareggiare.
A maggio 2014 (questo deve essere proprio il mese del cambiamento nella mia vita) ho disputato la prima gara, ho guadagnato una medaglia ma soprattutto la qualificazione per i campionati italiani assoluti. Ho partecipato alla competizione a Bari, lo ricordo benissimo, e sono riuscita a spuntare tre medaglie, prima a dorso, poi 50 e 100 stile libero. La gioia incontenibile di questo risultato è stata però soffocata crudelmente dalla decisione conclusiva, da parte delle autorità sportive, di sospendermi per doping.
No, non mi sono dopata, faccio solo uso di farmaci come tutte le persone malate. Farmaci salvavita, dichiarati nella mia cartellina di presentazione. Così ha avuto inizio un’altra lunga battaglia al tribunale sportivo di Roma. Avrei potuto tranquillamente risparmiare al mio corpo dolorante continui viaggi nella capitale per seguire il processo, ma volevo guardare negli occhi le persone che stavano annegando il mio piccolo grande sogno. Lo facevo per tutti quelli che sono o saranno nella mia stessa condizione. Alla fine, mi hanno prosciolto e ho potuto riprendere a gareggiare.
Una parte di me, in realtà, aveva deciso di gettare la spugna, per il disgusto e per la discriminazione a cui ero stata ingiustamente sottoposta, ma la parte più grande ha deciso di nuotare come una vera sumo anche nel “fango” della nostra società. Mi sono difesa continuando a prepararmi in vasca, e da luglio 2014 a maggio 2015 mi sono allenata senza disputare alcuna competizione. Poi a maggio (ancora) di quello stesso anno ho partecipato ai campionati italiani di Società e ottenuto i tempi per gli assoluti di giugno, durante i quali ho vinto tre medaglie d’oro, un argento e un bronzo. Quest’anno ho segnato anche il record italiano assoluto dei 50 metri stile libero e il record per farfalla. Senza la mia terapia e certi miei farmaci, per evitare di incorrere nuovamente nelle "trappole" del doping.
Mi alleno sempre, compatibilmente alla mia malattia. Né troppo né troppo poco. Nessuno potrà mai togliermi i dolori e la sofferenza con la quale devo “fare pace” ogni giorno, il rischio di sospendere la terapia per gareggiare (anche se adesso è stata approvata dalla commissione antidoping), ma certamente l’agonismo cui non pensavo proprio di arrivare, ha fermato le lancette dell’orologio che sembravano destinate a scorrere troppo velocemente verso la fine.
L’amore di mio marito, cui devo un grazie enorme, mi accompagna in questo viaggio che è la vita. Un equilibrio sopra la follia. Ogni alba e ogni tramonto, dimenticando il dolore del giorno precedente e degli anni. Rinascendo un po’, come l’araba fenice che ho tatuato sulla mia schiena. Brucia e ritorna dalla cenere più forte di prima. Come me.
(testimonianza raccolta da Maria Santoro)
Data ultimo aggiornamento 23 giugno 2017
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco