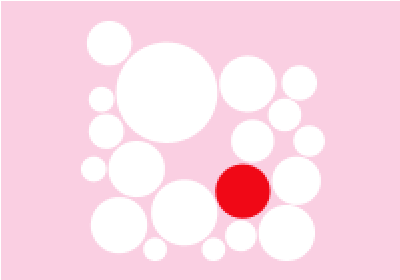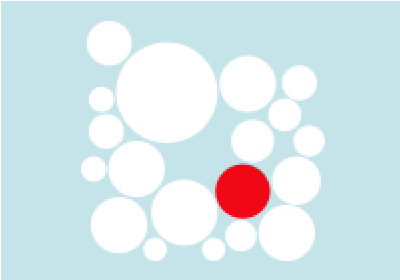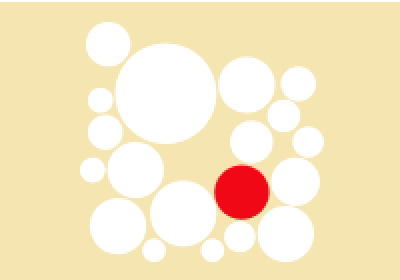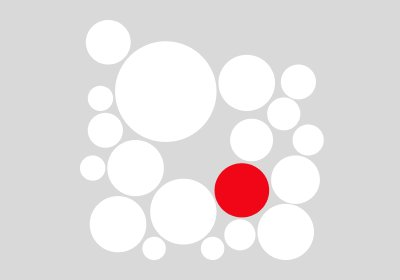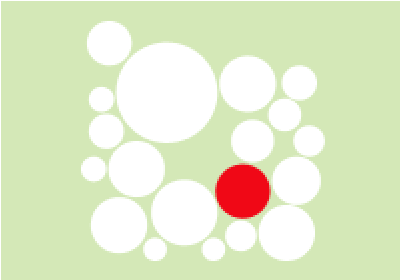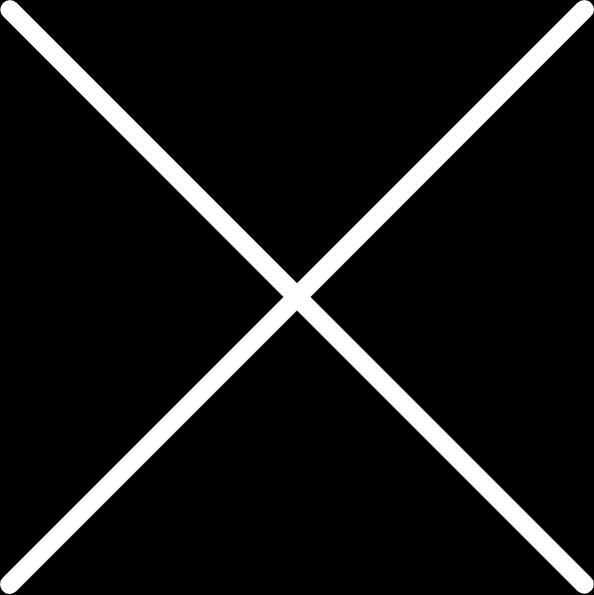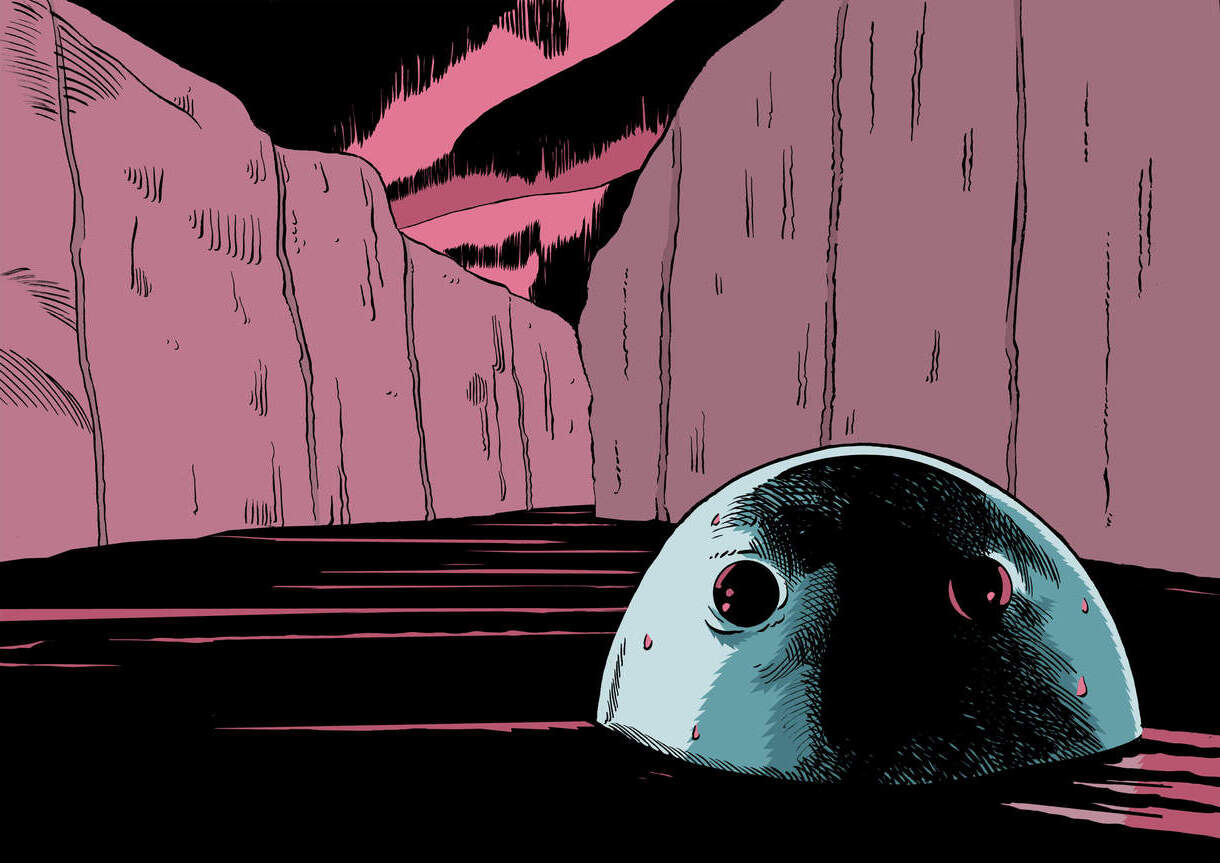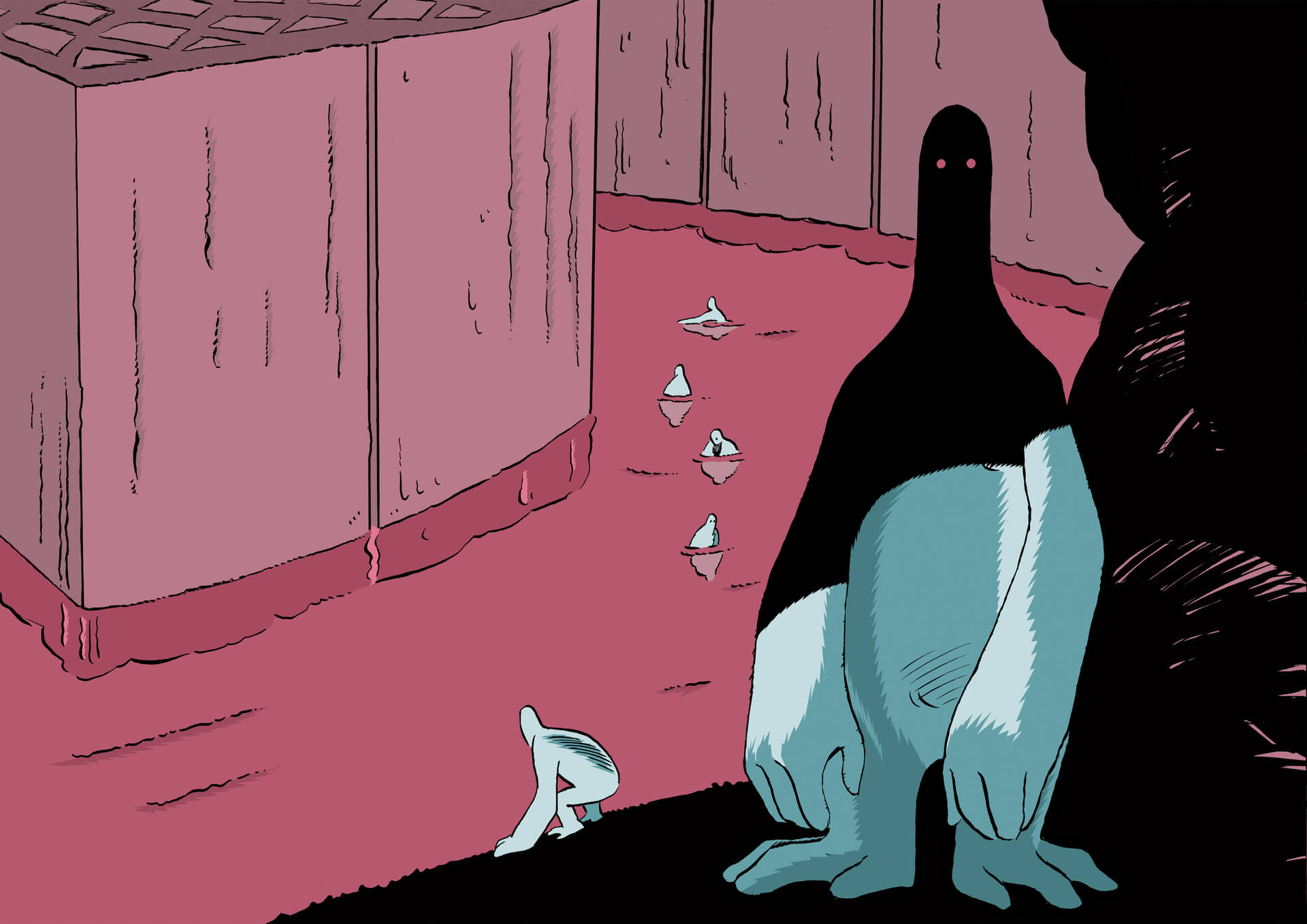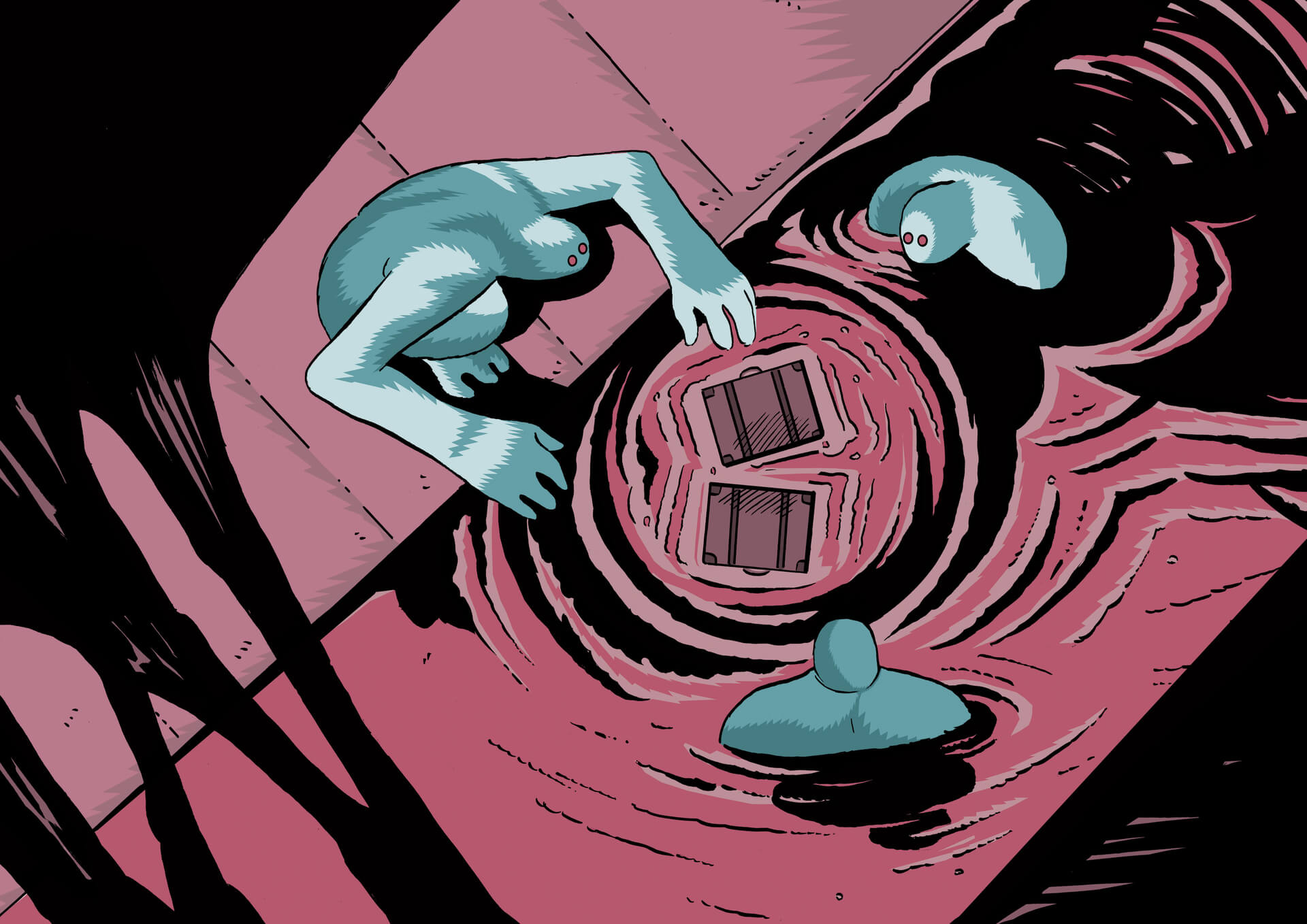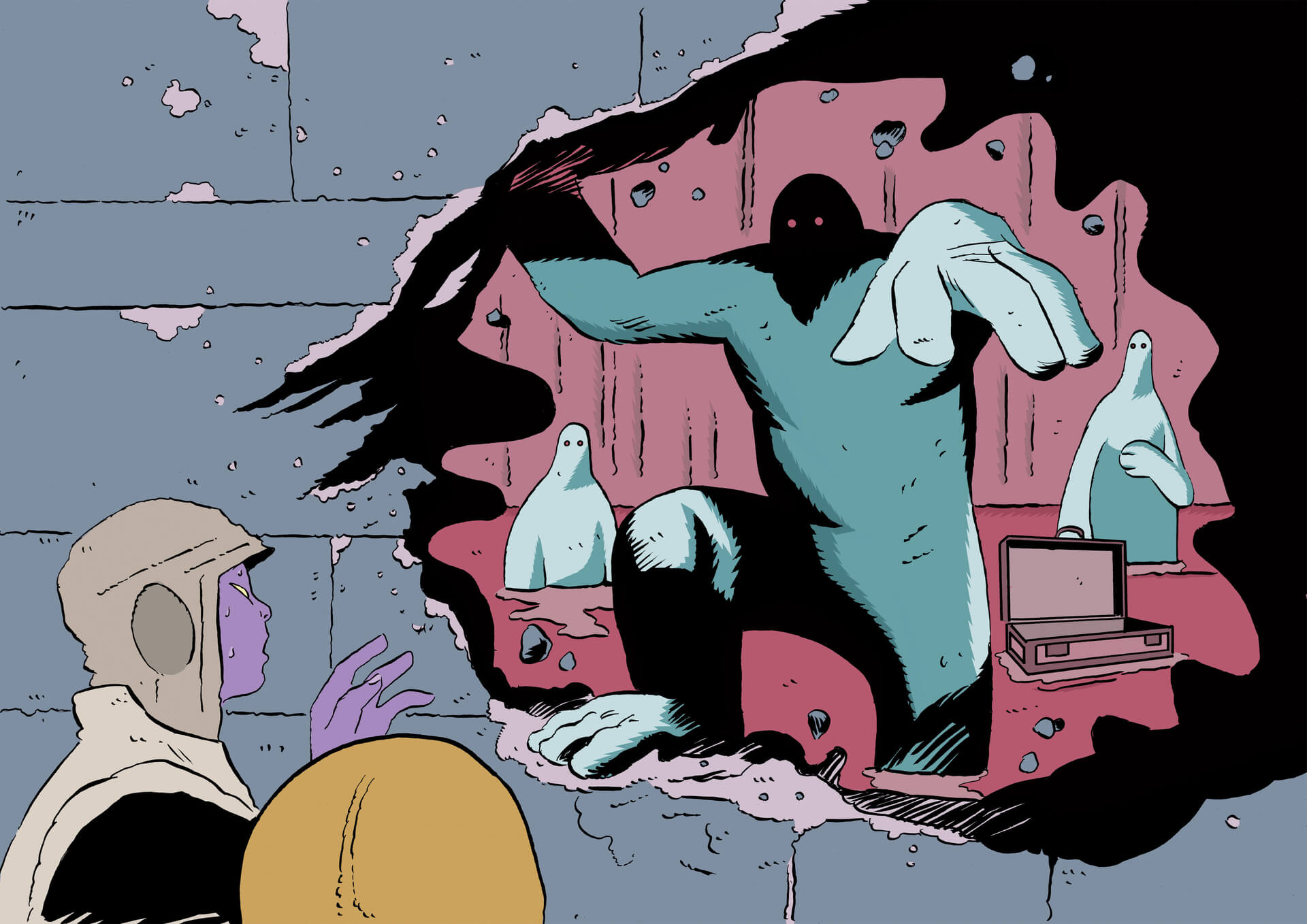NUOVI STUDI
In un caso su due l’Alzheimer si potrebbe prevenire, modificando gli stili di vita

di Agnese Codignola
Negli ultimi trent’anni la ricerca ha permesso di fare passi in avanti molto rilevanti per curare alcune delle patologie più diffuse e in crescita, come quelle cardiovascolari e quelle oncologiche. Lo stesso non è accaduto nel caso di quelle neurodegenerative e, in primo luogo, dell’Alzheimer.
Sui meccanismi molecolari che avviano e poi sostengono nel tempo la neurodegenerazione, infatti, le idee sono ancora confuse, anche perché sono state quasi tutte incentrate su un’unica teoria - quella del ruolo predominante della proteina chiamata beta amiloide - che si è capito essere stata non dimostrata in modo convincente (alcuni degli studi più importanti che l’avevano proposta sono stati addirittura ritirati dalle riviste scientifiche che li avevano pubblicati, perché basati su frodi scientifiche). In realtà, non si sa ancora esattamente che cosa succeda, e perché, né, quindi, come cercare di intervenire efficacemente.
Tutt’altra storia è invece quella dei fattori di rischio, cioè di ciò che innesca i fenomeni neurodegenerativi ancora poco chiari, come detto, e che non dipende dal corredo genetico. In questo ambito da molti anni sono note associazioni tra la demenza e abitudini o condizioni quali, per esempio, il fumo, l’isolamento, il basso livello di istruzione, i traumi cranici, alcune altre malattie, come quelle infettive. Nel tempo, l’insieme delle ricerche epidemiologiche (e non solo) ha permesso di concludere che lo stile di vita è responsabile di una porzione rilevante di casi di Alzheimer. Di conseguenza, adottando abitudini corrette, il rischio si può diminuire, quando non scongiurare. E negli utlimi anni la percentuale di questi casi, e quindi l’importanza dello stile di vita, ha assunto dimensioni sempre maggiori.
Oggi si sa che in un caso su due la demenza di Alzheimer si può prevenire o, quantomeno, se ne può ritardare l’insorgenza, e rallentare la progressione. Lo ha appena ribadito una commissione formata dalla rivista scientifica Lancet, composta da 27 esperti internazionali, che avevano già affrontato il tema nel 2017, dopo aver analizzato centinaia di studi di vario tipo, epidemiologici, ma anche incentrati su singoli interventi. In quella prima fase la commissione aveva individuato nove fattori di rischio che, se corretti, avrebbero potuto far diminuire molto la probabilità di ammalarsi: un basso livello di scolarizzazione, l’ipertensione, la perdita di udito, il fumo, l’obesità, la depressione, l’inattività fisica, il diabete e la scarsa socialità.
Poi, nel 2020, dopo un’analisi ulteriore di ciò che era stato pubblicato nel frattempo, aveva aggiunto alla lista il consumo di alcol, i traumi alla testa e l’inquinamento. Nel loro insieme, secondo gli esperti, questi 12 elementi potevano prevenire fino al 40% dei casi.
E ora è arrivato il nuovo aggiornamento, che aggiunge due ulteriori fattori di rischio, e che fa balzare a circa il 50% la percentuale di demenze che potrebbero essere evitate: un numero davvero sorprendente per una malattia considerata da molti, a torto, ineluttabile.
IL NUOVO ELENCO - A tutti gli altri possibili fattori di rischio, secondo gli esperti di Lancet vanno aggiunti sia i deficit di tipo visivo, sia gli squilibri nei livelli dei grassi del sangue e, in particolare, del colesterolo cosiddetto cattivo, le LDL.
Insieme, i due nuovi elementi sono responsabili di circa il 9% dei casi, un numero composto dal 7% del colesterolo cattivo fuori norma a partire dai 40 anni, e da un 2% associato alla perdita della vista non contrastabile, condizione tipica dell’invecchiamento. Evitando o tenendo sotto controllo entrambi, il rischio cala in proporzione.
LE AUTORITÀ SANITARIE- La Commissione, come aveva fatto nelle edizioni precedenti, ha poi fornito la versione aggiornata di una serie di consigli per le autorità sanitarie, affinché facciano il possibile per promuovere gli stili di vita migliori, perché la prevenzione è qualcosa che deve iniziare fino dall’infanzia, ed essere portata avanti per tutta la vita. Oltretutto, anche solo allontanare il momento della manifestazione dei primi sintomi significa far vivere le persone per meno tempo nella condizione di malato di Alzheimer, con enormi benefici per i potenziali pazienti, e grandi risparmi per i sistemi sanitari.
Tra i consigli vi sono:
- la prevenzione e il trattamento della perdita di udito e di quella della vista (per esempio, con visite regolari e poi con la fornitura gratuita o quasi di apparecchi acustici, che oggi molte persone non si possono permettere, e di occhiali adeguati);
- la prevenzione e il trattamento della depressione;
- la protezione del cranio per chi pratica sport di contatto e per chi va in moto, bicicletta o monopattino;
- la rinuncia o la forte limitazione dei quantitativi di alcol consumati;
- la prevenzione e la riduzione di tutti gli indici di rischio cardiovascolari quali i grassi nel sangue, il diabete, l’obesità, l’ipertensione;
- il miglioramento della qualità dell’aria;
- il supporto a tutto ciò che può promuovere la socialità e allontanare il pericolo di isolamento degli anziani;
- la diminuzione della quantità di zucchero e sale nei prodotti pronti e nei pasti servirti dalla ristorazione;
- un buon livello di istruzione fino dai primi anni;
- l’abbandono del fumo di sigarette e di e-cig.
SEMPRE PIÙ CASI DI ALZHEIMER NEL MONDO - Anche se in molti Paesi l’incidenza (cioè il numero di casi relativi a una certa popolazione) è in diminuzione, proprio a causa della migliore comprensione dei fattori di rischio e delle politiche associate, il numero assoluto di casi nel mondo è in aumento, a causa dell’invecchiamento della popolazione e della situazione dei Paesi più poveri, dove diagnosi e terapie sono molto indietro. Secondo le ultime stime, nel 2050 si arriverà a 153 milioni di malati, contro gli attuali 57, con un costo stimato di un trilione di dollari all’anno.
Modificare queste previsioni è possibile, ma è necessario un impegno molto superiore a quello attuale, da parte delle autorità sanitarie. Oggi, infatti - sottolineano gli autori del rapporto - pochissime raccomandano specifiche azioni sullo stile vita, nei loro piani nazionali. E invece tutte dovrebbero farlo, perché l’efficacia, come viene ulteriormente ribadito nel nuovo documento, è più che dimostrata. A maggior ragione, il discorso è valido per i Paesi a medio e basso reddito, ancora più assenti sulle politiche di prevenzione, con meno fondi a disposizione, e flagellati Da un continuo aumento dei casi.
Solo applicando i consigli alla Gran Bretagna – hanno poi spiegato gli autori – si avrebbero risparmi per quattro miliardi di sterline all’anno.
LA DIAGNOSI - Uno dei punti deboli di tutto ciò che riguarda una demenza è da sempre la diagnosi. Ancora oggi, e solo nei Paesi più avanzati, oltre ai test cognitivi ci sono solo le punture lombari e le indagini di imaging della PET (tomografia a emissione di positroni), che però possono aiutare nella diagnosi solo quando la malattia è in stadio relativamente avanzato, non sono disponibili ovunque, non sono del tutto sicure e non sono accessibili a tutti perché molto costose.
La situazione, però, potrebbe presto cambiare, e in meglio. Un insieme di tre studi pubblicati su JAMA candida infatti uno specifico tipo di analisi, da effettuare nel sangue, al ruolo di test per la diagnosi precoce. Se i dati fossero confermati e la tecnologia ottimizzata e applicata, si tratterebbe di una rivoluzione.
I ricercatori e neurologi dell’Ospedale universitario di Malmö, in Svezia, hanno infatti pubblicato quanto ottenuto misurando alcuni parametri e il loro andamento nel tempo. In particolare, hanno controllato alcune forme delle proteine più coinvolte nell’Alzheimer, e cioè le beta amiloidi e le proteine tau. Si tratta di proteine che, nella demenza, hanno un avvolgimento anomalo e precipitano, dando luogo a placche, fibrille e formazioni di vario tipo che finiscono per uccidere la cellula nervosa. Le loro peculiarità sono note da tempo, ma finora nessuno era riuscito a utilizzarle come marcatori. Ora, forse, ci siamo. I neurologi hanno infatti dimostrato che, se le proporzioni reciproche tra le forme di amiloide chiamate 40 e 42 hanno un certo andamento nel tempo, e se contemporaneamente la forma delle proteine tau chiamata p-tau217 ne ha un altro, l’attendibilità del test può superare il 90%: un risultato mai raggiunto con tutti gli altri tentativi fatti finora. E l’aspetto fondamentale è che l’andamento nel tempo di questi due parametri permette di diagnosticare la malattia nelle fasi molto precoci, quando è ancora difficilmente distinguibile dal normale decadimento cognitivo dovuto all’età.
Nei lavori pubblicati, i parametri sono stati provati su oltre 1.200 pazienti potenziali in strutture sanitarie di alta specializzazione, ma anche in un normale ambulatorio del medico di base, e hanno comunque avuto una sensibilità superiore al 90%, mentre con i metodi tradizionali la stessa era stata, rispettivamente, del 73 e del 61%. Quindi, in un altro lavoro, i ricercatori hanno mostrato i dati della stessa tecnologia applicata a circa mille persone che avevano già avuto una diagnosi di deficit cognitivo, e hanno ottenuto risultati simili. Infine, hanno verificato il metodo in campioni provenienti dagli Stati Uniti, relativi a oltre 1.500 persone, raccolti a partire dal 1993 (di cui erano disponibili dati anche clinici fino al 2019), e anche in quel caso l’affidabilità del test è stata confermata, ed è emerso anche che questi parametri possono permettere di distinguere tra Alzheimer e demenze di altro tipo.
Come sottolineato anche nell’editoriale di commento pubblicato sullo stesso numero di JAMA, tutto autorizza a sperare di essere vicini a una svolta. Un cambiamento tanto più necessario in questo momento, in cui iniziano a essere approvati, a scopo terapeutico, anticorpi monoclonaliGli anticorpi monoclonali sono anticorpi del tutto simili a quelli che il sistema immunitario produce contro i “nemici” (batteri, virus e altro ancora), ma non sono presenti in modo naturale nel nostro organismo. Vengono creati in laboratorio, grazie a tecniche di ingegneria genetica, e sono mirati contro un preciso bersaglio della malattia, identificato dai ricercatori: per esempio, nel caso del Covid, contro la proteina Spike, utilizzata dal coronavirus per entrare nelle cellule e infettarle. Una volta prodotti, vengono fatti moltiplicare in laboratorio, identici, in un numero grandissimo di copie, o di cloni (per questo vengono chiamati monoclonali), e poi immessi nell’organismo del paziente, in genere tramite infusione (endovena). diretti contro la proteina amiloide, non privi di rischi e sulla cui efficacia permangono dubbi rilevanti, al punto che i pronunciamenti delle agenzie regolatorie sono molto eterogenei (in alcuni casi sono arrivati dei no all’autorizzazione). Questi anticorpi devono essere dati prima possibile, ma finora non c’erano molti metodi applicabili su larga scala per giungere a una diagnosi certa della malattia in fase precoce. La proposta svedese potrebbe cambiare tutto, anche dal punto di vista terapeutico.
Data ultimo aggiornamento 20 settembre 2024
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco