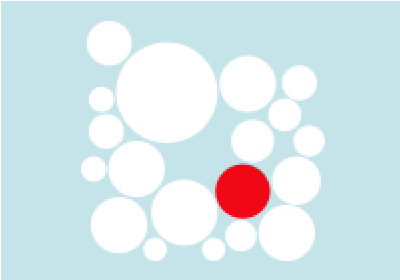SUZETRIGINA
Dopo il disastro degli oppioidi, via libera
negli USA a un antidolorifico "diverso"

di Agnese Codignola
Il suo nome è suzetrigina (quello commerciale, per il mercato nordamericano, è Journavx), e la sua approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense, avvenuta pochi giorni fa, è senza dubbio un momento importante. Perché per la prima volta da oltre 20 anni l’agenzia regolatoria autorizza l’impiego di un antidolorifico efficace contro il dolore acuto di entità media o grave che non ha alcun tipo di legame con il sistema degli oppioidi e con i derivati della morfina, a differenza dei farmaci, come l’ossicodone e il fentanyl, che negli ultimi tre decenni hanno causato milioni di decessi negli Stati Uniti (non meno di 80.000 all’anno), e gettato ancor più persone nella dipendenza, fino a diventare un’emergenza nazionale.
Il nuovo medicinale, che va assunto per via orale due volte al giorno per qualche giorno, non arriva al cervello, e non può dunque interagire con i recettori degli oppioidi, né con altri, e indurre dipendenza. Piuttosto, agisce sulle fibre nervose periferiche che conducono gli stimoli dolorosi, attenuandone l’attività. Ma vediamo meglio come agisce.
I canali del sodio: un target difficile, ma quasi perfetto
Le cellule nervose riescono a trasmettere gli impulsi grazie a diverse proteine che fanno entrare o uscire gli ioni come quelli del calcio o del sodio in risposta allo stimolo elettrico. Queste proteine, poste sulla membrana delle cellule, si chiamano canali ionici voltaggio-dipendenti, e funzionano come un cancello: si aprono e si chiudono a seconda delle variazioni di potenziale, lasciando entrare o uscire ioni carichi elettricamente che, essendo tali, modificano il potenziale della cellula, e trasmettono così gli impulsi. Una delle famiglie più importanti è quella dei canali del sodio, di cui, però, esistono ben nove sottotipi, localizzati in diversi tessuti e organi. Per tale motivo, i primi farmaci che hanno preso di mira questi canali, scoperti più di cinquant’anni fa, come la lidocaina e la procaina, sono diventati anestetici locali: la loro azione è troppo aspecifica, e un loro utilizzo sistemico avrebbe effetti letali. Basti pensare alla specialità culinaria giapponese chiamata fugu, e ottenuta dal pesce palla, ricco di una tossina chiamata tetrodotossina (TTX), che blocca i canali del sodio. Piccolissime dosi di TTX, e una speciale lavorazione, rendono il fugu una prelibatezza, ma il piatto è così pericoloso che solo pochi cuochi sono autorizzati a prepararlo. Oltretutto, uno dei problemi, con questi canali, è che la loro apertura/chiusura è rapidissima, nell’ordine di millisecondi, ed è quindi stato molto difficile trovare molecole capaci di agire con quei tempi.
Ciononostante, la ricerca sui canali del sodio e i possibili bloccanti non si è mai fermata, e nel 1990 è stato dimostrato che tre di essi, in particolare, erano cruciali per il dolore: Nav (cioè canali del sodio voltaggio dipendenti) 1.7, 1.8 e 1.9. Ciascuno di essi ha un ruolo differente. Il primo, 1.7, è stato paragonato alla miccia di un petardo: è quello che dà il via alla sensazione dolorosa, trasmettendola a 1.8. Il quale agisce come un propellente sul fuoco, intensificando il segnale e trasmettendolo, in impulsi ripetitivi, al terzo (1.9) che, a sua volta, modula intensità e durata del segnale.
Studi genetici dei primi anni duemila, insieme a quelli su una malattia rara, chiamata sindrome dell’uomo in fiamme o eritermalgia - nella quale si sentono dolori improvvisi e senso di calore alle estremità, provocato da una mutazione in una porzione (subunità) dei canali del sodio - e a quelli su un’altra condizione rara e pericolosa, che impedisce di sentire qualunque tipo di dolore, hanno portato a capire che il sottotipo che per primo percepisce il dolore è Nav 1.7. A quel punto tutte le ricerche si sono concentrate su questo canale. Ma, a sorpresa, i risultati dei primi farmaci identificati sono stati deludenti. Di Nav 1.9 si è presto capito che sarebbe stato estremamente improbabile trovare un farmaco capace di inibirlo. Per questi motivi, l’attenzione si è rivolta a Nav 1.8, che non è presente nel cervello e neppure nel cuore, fatto che esclude qualunque possibilità che si instauri una dipendenza.
In particolare, si è mossa in questa direzione un’azienda farmaceutica di Boston (Stati Uniti), la Vertex, che ha cercato, tra migliaia di possibili molecole, quella giusta. E l’ha trovata, al terzo tentativo. Era quella chiamata inizialmente VX-548, capace di bloccare il suo bersaglio con una potenza pari a 30.000 volte quella degli inibitori studiati prima di lei. Ci sono voluti quindi molti anni, ma alla fine il risultato sperato è arrivato, a riprova del fatto che le scoperte rilevanti sono sempre il frutto di un lavoro lungo, costellato anche di fallimenti. Ma che, se ben impostato, porta frutti.
I dati delle sperimentazioni
Dopo aver effettuato i primi test in vitro e poi quelli sui modelli animali, i ricercatori sono passati alle sperimentazioni sui volontari umani, e hanno confermato sia la sicurezza che l’efficacia della molecola. Per quanto riguarda quest’ultima, ci sono stati due trial, uno in pazienti che avevano subito un intervento all’addome (addominoplastica, che genera dolore nei tessuti molli), e un altro in persone che avevano subito un intervento ai piedi (per la rimozione dell’alluce valgo, nota per generare molto dolore alle ossa), per un totale di circa mille partecipanti, trattati nelle 48 ore successive all’anestesia con un composto oppioide (idrocodone) più il paracetamolo, per confronto, oppure con un placebo, mentre per la sicurezza, ai dati raccolti nelle due sperimentazioni indicate, ne sono stati aggiunti quelli di più di altre 250 persone con dolore di origine varia.
Il risultato è stato che chi era stato trattato con suzetrigina aveva avuto una diminuzione del dolore più efficace e più rapida rispetto agli altri. Nello specifico, il 61% di chi era stato sottoposto ad addominoplastica aveva avuto una riduzione (di almeno il 30%), rispetto al 48% delle persone che avevano assunto un placebo. Tra chi aveva subito l’asportazione dell’alluce valgo, invece, i valori sono stati pari, rispettivamente, all’83 e al 68%. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, i principali sono stati nausea, mal di testa, stitichezza, e poi (più raramente) prurito, spasmi muscolari, lieve innalzamento delle transaminasi epatiche: il farmaco è stato considerato sicuro.
L’inizio di una nuova era?
Anche se il controllo del dolore è apparso migliore con il paracetamolo e con l’idrocodone, la potenza dell’effetto, il fatto che non sia possibile indurre dipendenza e gli effetti collaterali del tutto sopportabili e gestibili fanno sperare molto che farmaci come la suzetrigina possano presto sostituire gli oppioidi, almeno in parte, anche se resta da verificare se, per assunzioni più lunghe, l’efficacia sia o meno conservata.
Per il momento, l’azienda ha presentato i primi dati, di fase II, ottenuti su circa 200 pazienti con un dolore indotto da infiammazione del nervo sciatico, trattati per 12 settimane, e sono positivi. Tuttavia, altri dati mettono in dubbio quei risultati, e bisognerà dunque attendere, anche perché sono in corso studi sui diversi tipi di dolore (i due principali sono quello muscolo-scheletrico, come quello tipico dell’artrosi, e quello che origina dai nervi come, per esempio, dai nervi lesionati nel diabete). Inoltre, per ora la maggior parte dei dati di Vertex sono stati esposti in congressi internazionali, e non pubblicati su riviste scientifiche, e anche questo ha un suo peso: a prescindere dalla FDA, per essere considerati attendibili, quei numeri dovranno essere vagliati da tutta la comunità scientifica internazionale, e questo richiede la loro pubblicazione completa.
Per quanto riguarda il costo, per il momento una singola pillola costa 15,50 dollari, cioè più di un oppioide medio, di cui, in molti casi, è ormai disponibile il farmaco generico. Tuttavia, il prezzo è molto conveniente, se si considerano i costi associati alla dipendenza da oppiacei, come è stato fatto in un’analisi economica indipendente resa nota nelle scorse settimane dall’ICER, l’Institute for Clinical and Economic Review, molto attendibile in questo genere di indagini e raffronti.
Vertex non è l’unica azienda a lavorare su questi farmaci: molte altre stanno sperimentando proprie molecole con lo stesso meccanismo d’azione. Una di queste è la californiana Latigo Biotherapeutics di Thousand Oaks, che ha una molecola chiamata per ora LTG-001, che sembrerebbe raggiungere il massimo dell’efficacia più velocemente della suzetrigina, che necessita di due-quattro ore. La stessa Vertex sta studiando altri composti. Secondo molti espetti, tra i quali quelli interpellati da Nature, la suzetrigina potrebbe trovare un impiego in molte procedure minori che provocano dolore come quelle dentistiche, o i piccoli interventi o, ancora, essere consigliata a chi, per vari motivi, non può assumere altri farmaci, e agire anche in sinergia con altri antidolorifici più tossici come il paracetamolo, essendo più sicura per reni e fegato.
Data ultimo aggiornamento 14 febbraio 2025
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco