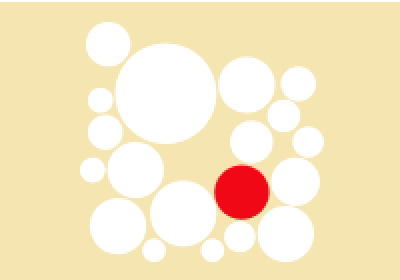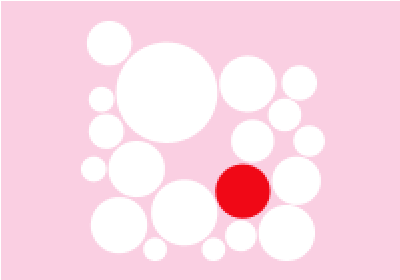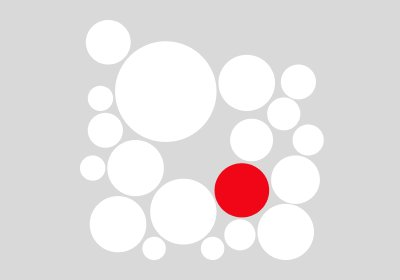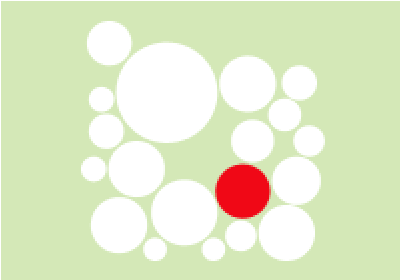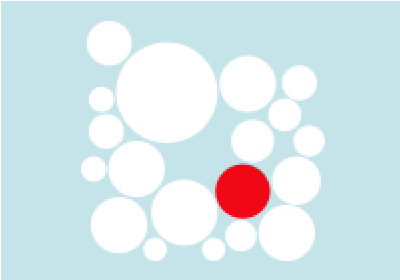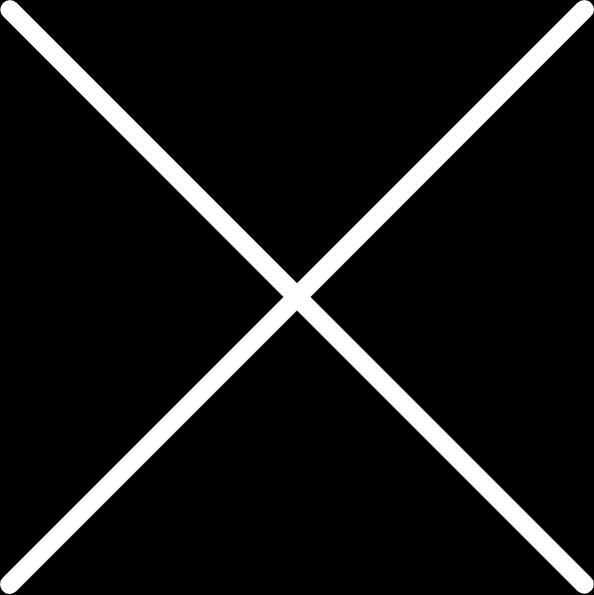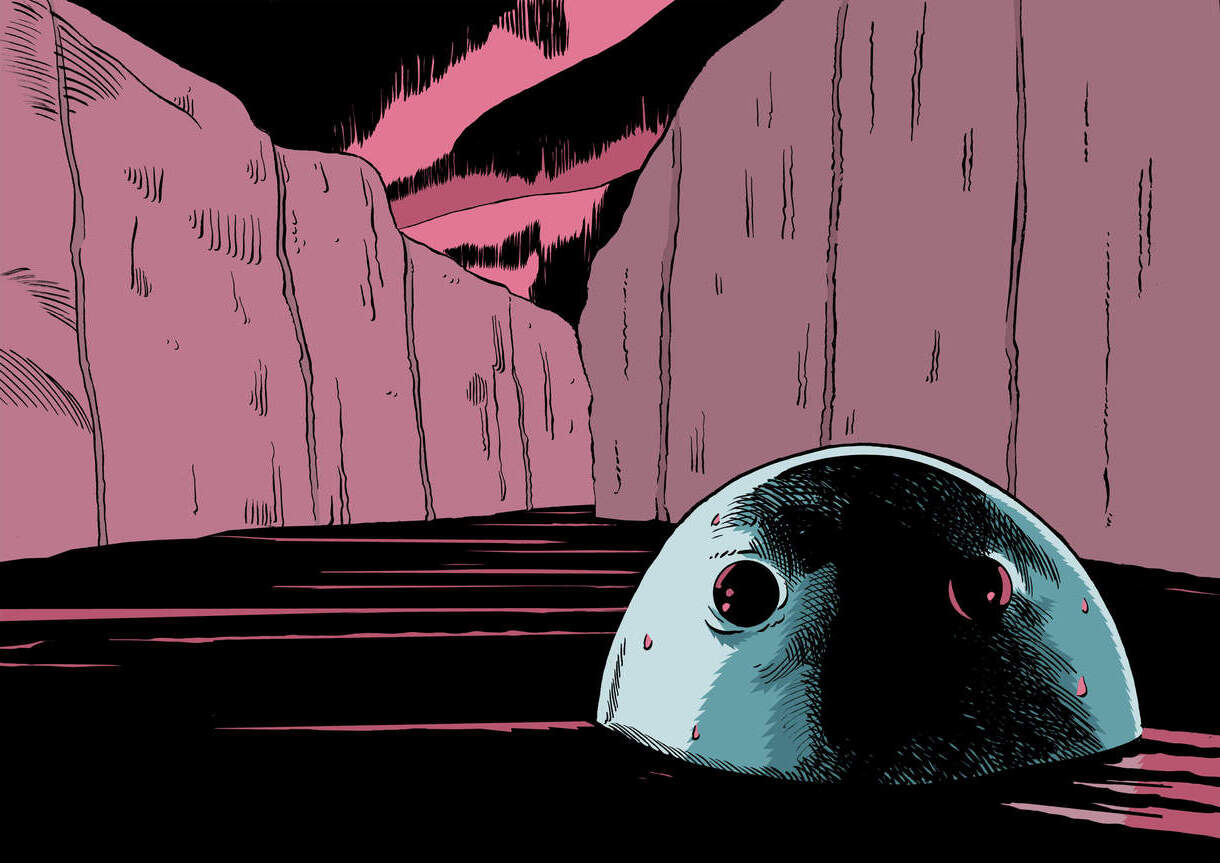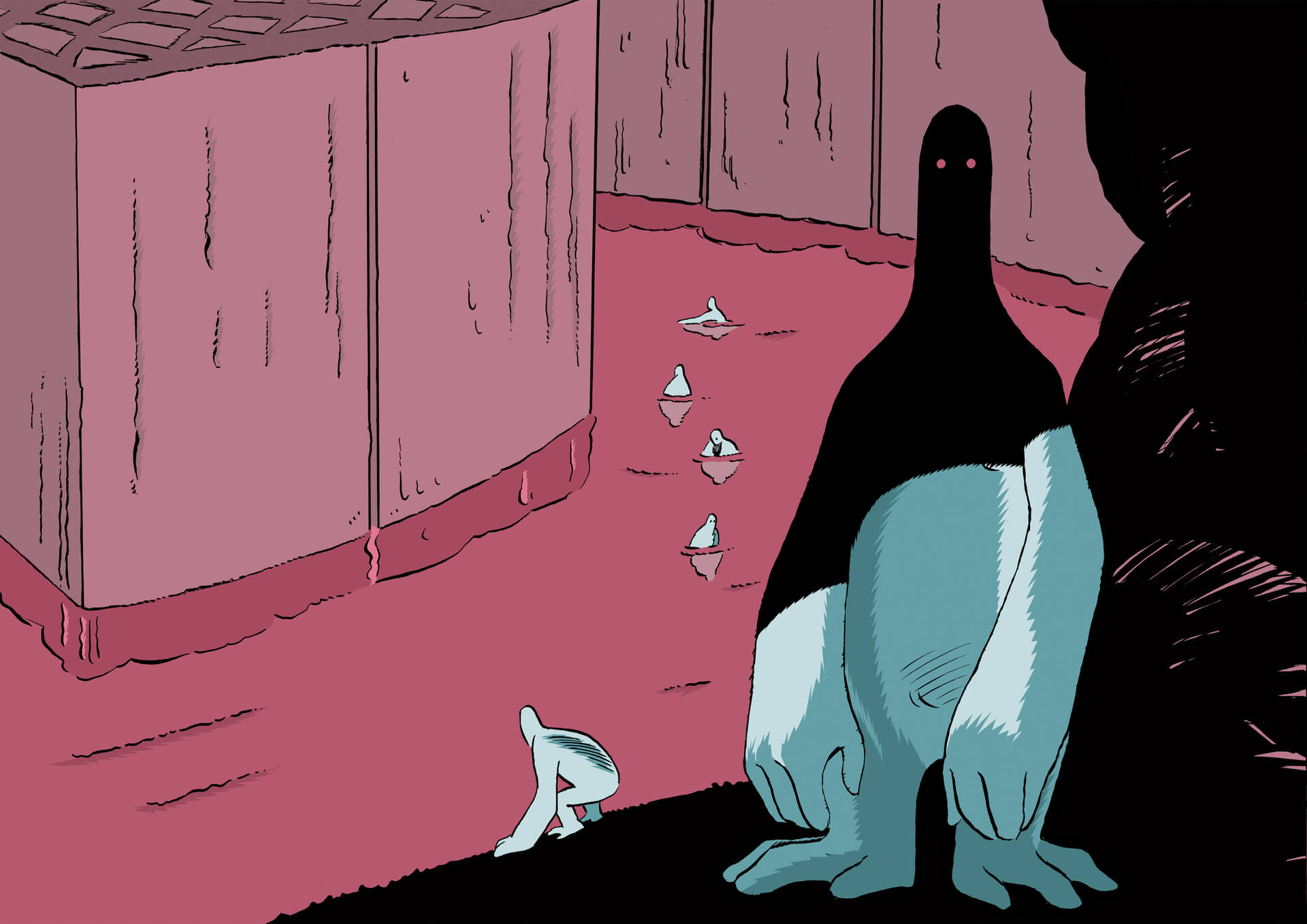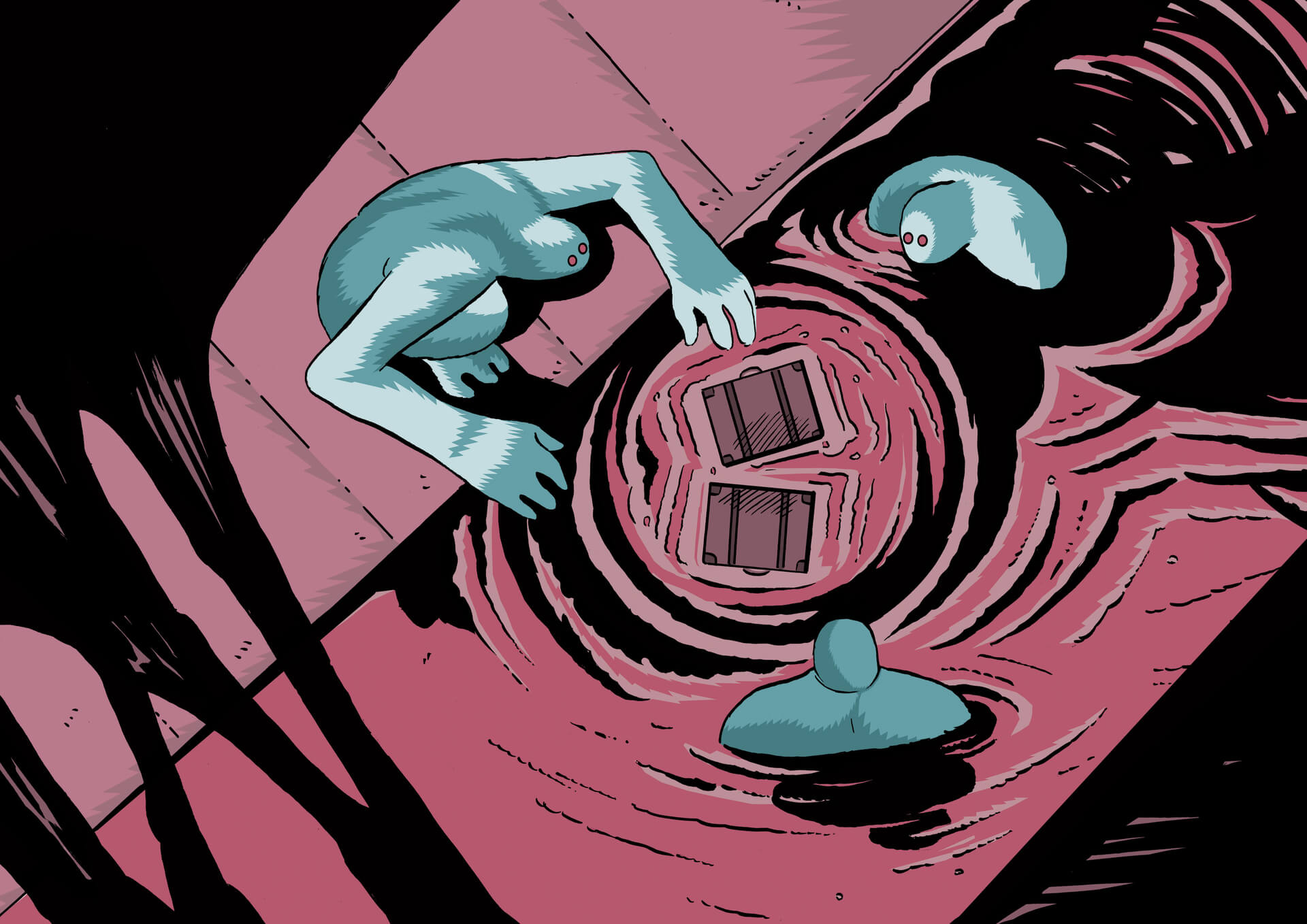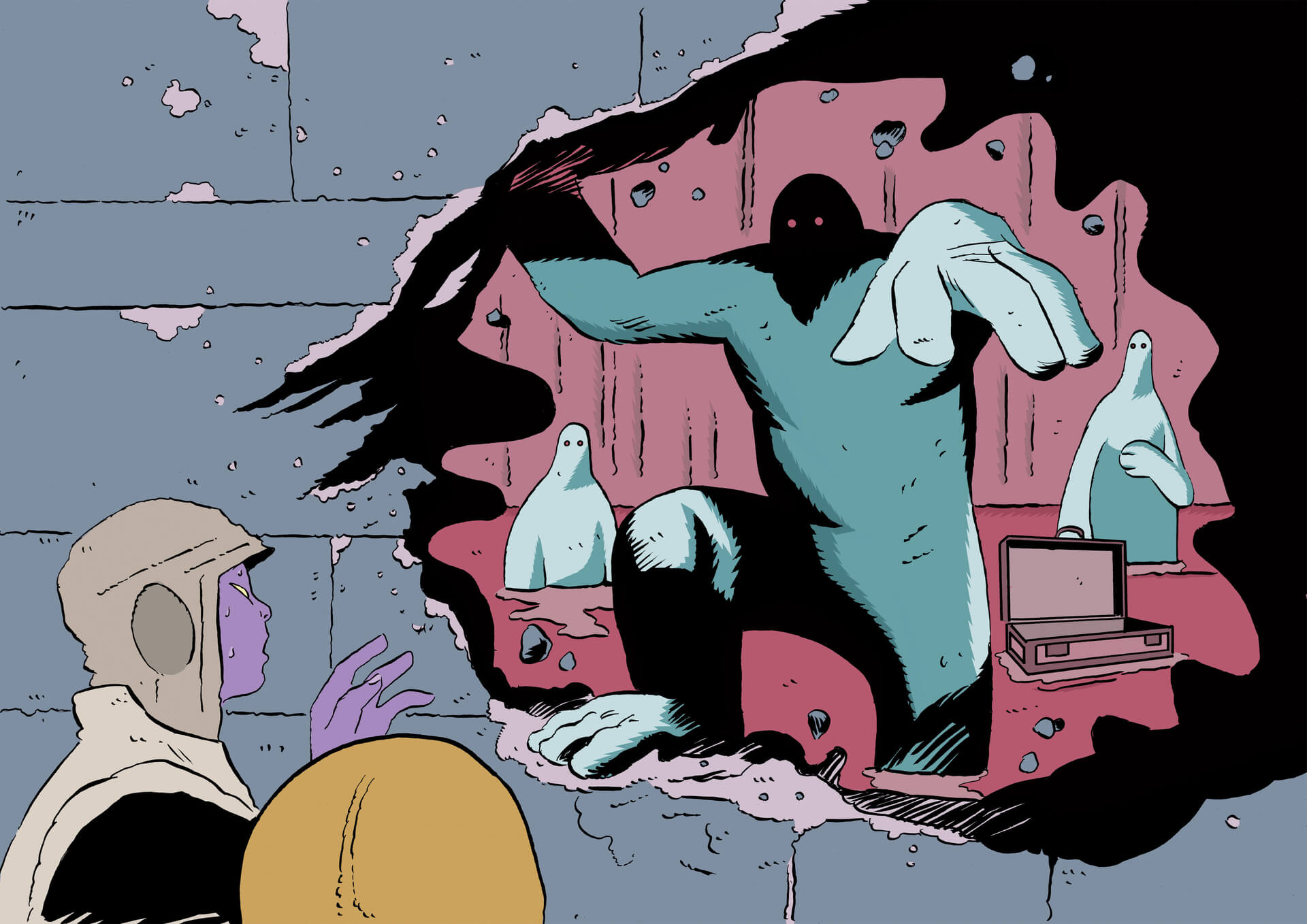ESPERTI USA
Celiachia: inutili gli screening
a tappeto della popolazione
Non esiste un test validato e con un buon rapporto costi-benefici che possa essere indistintamente utilizzato per pazienti sintomatici e non. Questa è la conclusione di uno studio della US Preventive Services Task Force pubblicato sul Journal of the American Medical Association, cui ha dedicato un approfodimento Corriere Salute. L’esame del sangue attraverso il quale oggi viene diagnosticata la celiachia (la ricerca degli anticorpi anti-transglutaminasi) funziona per pazienti sintomatici (ed è caldeggiato per soggetti a rischio), mentre appare del tutto inadeguato e fuorviante se applicato al resto della popolazione. Anche il consumo di alimenti gluten free tra i non celiaci è considerato inappropriato, poichè impedisce il naturale riconoscimento della patologia. I dettagli nel servizio di Alice Vigna.

È una tipica “malattia-iceberg”: la celiachia riguarda circa una persona su cento, ma le diagnosi sono molte meno. I pazienti italiani noti sono 180mila, oltre 400mila però mancano ancora all’appello e restano inconsapevoli della loro condizione. Come trovarli? Alcuni si sono chiesti se la risposta possa essere lo screening generalizzato della popolazione, ma uno studio pubblicato di recente sul Journal of the American Medical Association smentisce con forza questa possibilità: il rapporto della US Preventive Services Task Force ha infatti concluso che a oggi non ci sono prove scientifiche sufficienti per ipotizzare un buon rapporto costo/beneficio degli esami a tappeto in chi non ha sintomi.
È d’accordo Marco Silano, direttore del Reparto alimentazione, nutrizione e salute dell’Istituto Superiore di Sanità ed esperto di celiachia, che spiega: «I motivi sono vari, il primo è senz’altro il momento di insorgenza del problema, molto variabile. Il disturbo può comparire a qualsiasi età: ci sono casi diagnosticati a settant’anni ed è verosimile che costoro abbiano sviluppato un’intolleranza tardiva. Un vero screening di popolazione andrebbe fatto sui bambini entro i dieci anni, ma la possibilità che la malattia si manifesti successivamente renderebbe il risultato “temporaneo” e quindi di relativo significato. Il secondo ostacolo è la mancanza di un esame approvato per lo screening — prosegue Silano. — Il test attuale per la diagnosi di celiachia è la ricerca degli anticorpi anti-transglutaminasi nel sangue: funziona benissimo per riconoscere i pazienti già sintomatici, ma non abbiamo la certezza che abbia sensibilità e specificità adeguate per essere usato in chi non ha segni della malattia, quindi a oggi non è indicato per lo screening».
Va detto che non mancano i tentativi per individuare metodi adeguati, soprattutto nei bambini: un’intolleranza non diagnosticata in fase di sviluppo può compromettere la crescita ed è quindi indispensabile che non sfugga, così si sta, per esempio, valutando la possibilità di impiegare test della saliva negli alunni delle primarie, per identificare i soggetti “sospetti” e poi confermare la diagnosi con l’esame del sangue. Non c’è però ancora un percorso validato. «Lo screening di popolazione, oltre che essere costoso senza avere la certezza di un risultato affidabile, non è proponibile anche perché farebbe emergere pazienti non sintomatici che faticherebbero molto a seguire la dieta di esclusione, non traendone un giovamento evidente — osserva Silano. — In più sappiamo che eliminare il glutine riduce il rischio di complicanze della malattia in chi ne ha i segni, ma non c’è altrettanta certezza che sia così in chi non ha sintomi. A oggi quindi uno screening di popolazione per la celiachia non è pensabile, mentre è invece opportuno in soggetti ad alto rischio, come i parenti di primo grado dei celiaci: in genitori, figli, fratelli di pazienti la probabilità di essere intolleranti sale dall’1 al 15%. I test vanno eseguiti indipendentemente dalla presenza di sintomi anche in chi ha una patologia autoimmune di altro tipo, dal diabete di tipo 1 alla tiroidite autoimmune, perché la celiachia spesso vi si associa; infine, sì agli esami in persone con patologie genetiche come la sindrome di Down o la sindrome di Turner, in cui l’intolleranza al glutine è più frequente. Per tutti gli altri, i test vanno presi in considerazione solo se ci sono i sintomi».
Dolori o crampi addominali, diarrea e vomito, stanchezza, irritabilità, anemia, perdita di peso, un ritardo di crescita nei bambini sono alcuni dei segni che non andrebbero sottovalutati. «Purtroppo tuttora passano in media sei anni prima di arrivare alla diagnosi — ammette Giuseppe Di Fabio, presidente dell’Associazione Italiana Celiachia. — Intercettare i pazienti è importante perché una malattia non riconosciuta, e quindi non trattata con l’unica terapia possibile, la dieta di esclusione, può provocare conseguenze serie. Nelle donne, che sono colpite dalla celiachia, il doppio rispetto agli uomini, si associa per esempio a infertilità e a un maggior rischio di complicanze in eventuali gravidanze». Tutto dipende dall’infiammazione intestinale scatenata dal glutine in chi è intollerante: per evitarla occorre mangiare cibi che ne sono naturalmente privi (come riso o mais) e sostituire i derivati del frumento con prodotti analoghi senza glutine, alimenti in media più costosi degli altri che nonostante ciò stanno entrando sempre più spesso anche nei carrelli di chi non è celiaco.
Un terzo dei prodotti gluten free venduti in Italia è acquistato da chi non è intollerante perché togliere il grano “va di moda”, come sottolinea Di Fabio. «Tanti pensano che non mangiare glutine faccia dimagrire, ma gli studi scientifici mostrano chiaramente che non è così. L’equivoco rischia di banalizzare una patologia che ha nella dieta di esclusione l’unica terapia: eliminare il glutine non è una scelta alimentare come un’altra, ma una necessità per chi è celiaco. Peraltro scegliere il gluten free senza una diagnosi rischia di “nascondere” alcuni casi di celiachia, esponendo al rischio di mancato riconoscimento della malattia».
Data ultimo aggiornamento 15 maggio 2017
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco