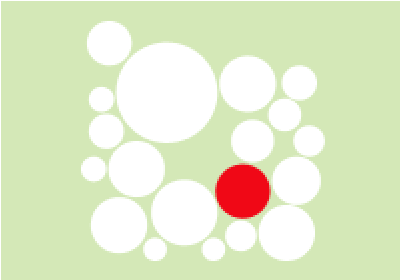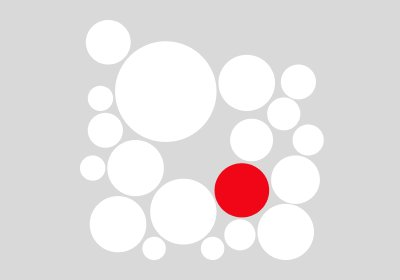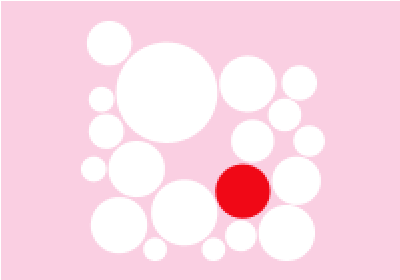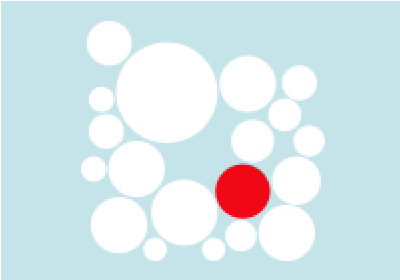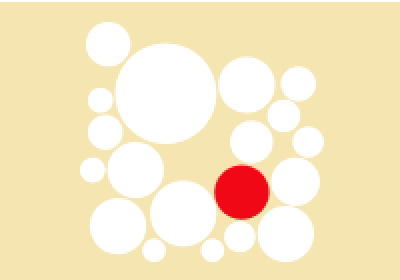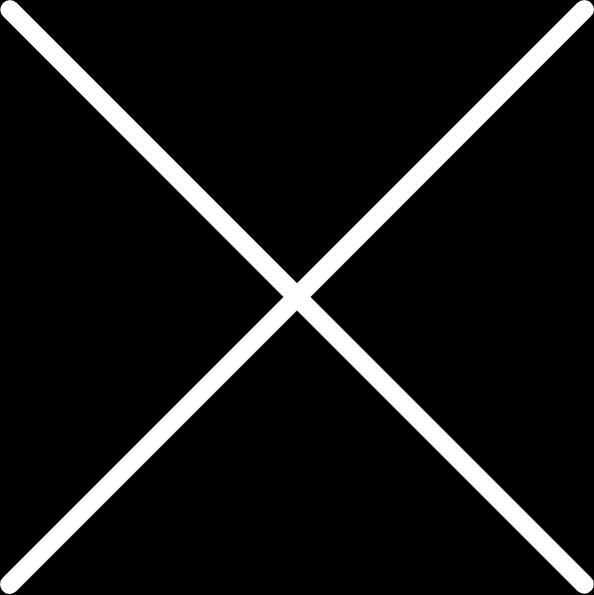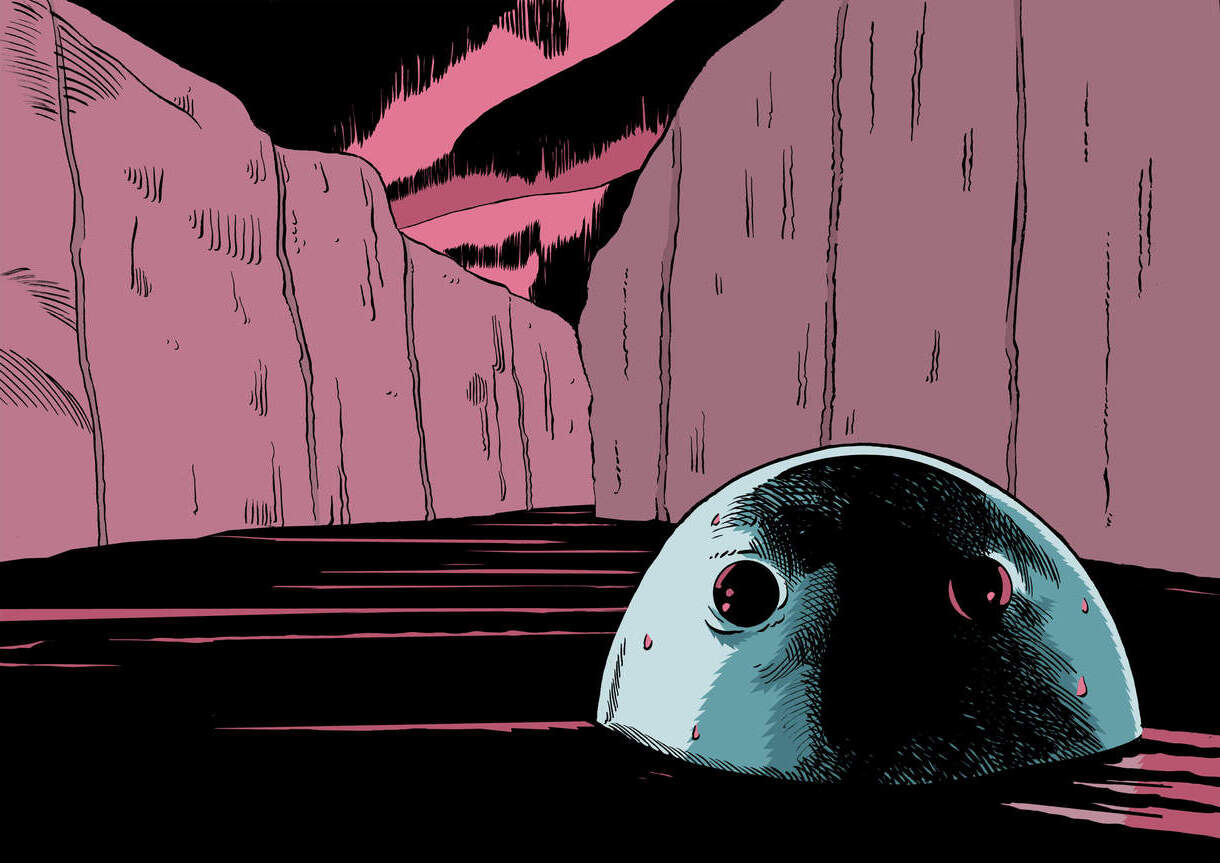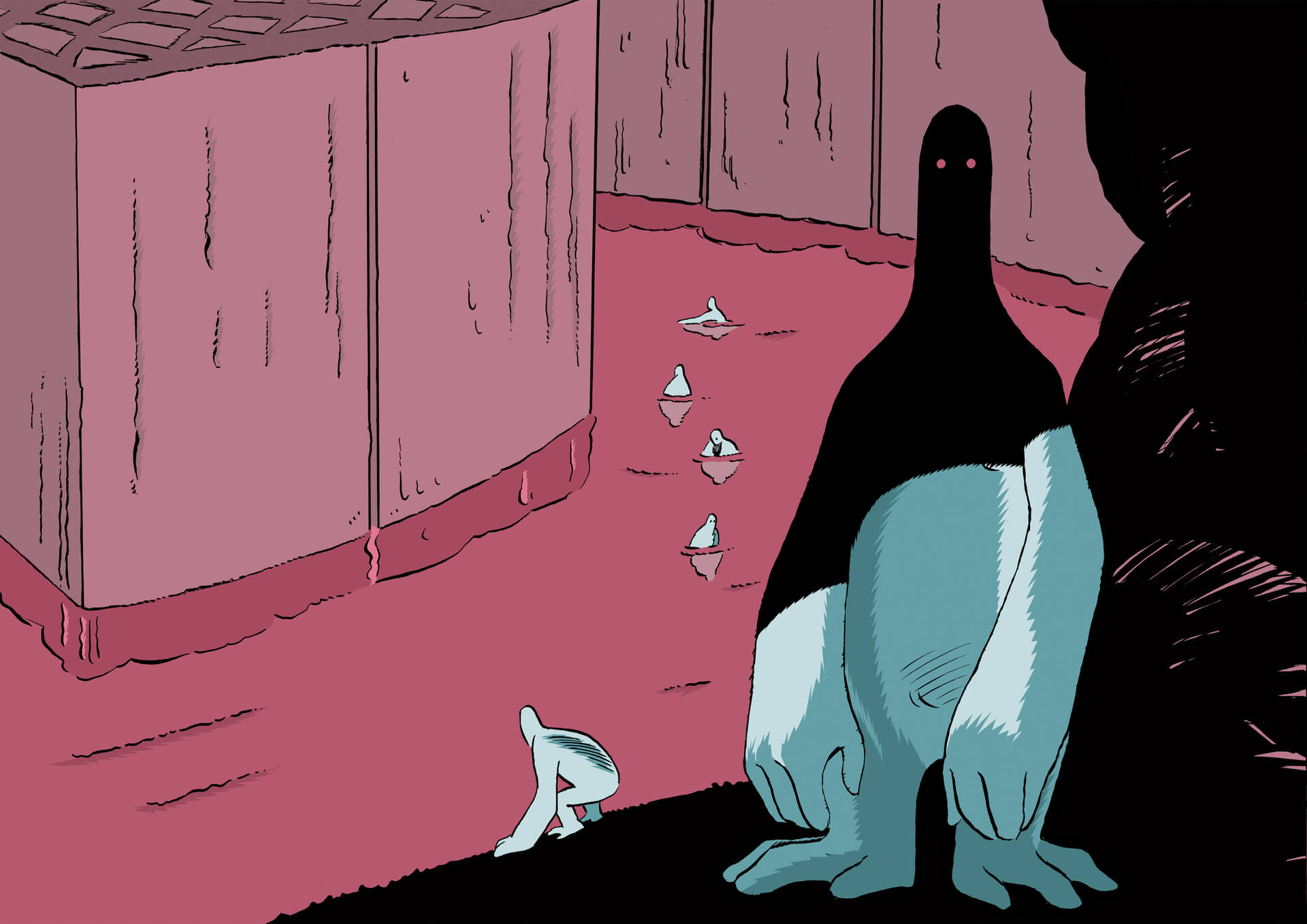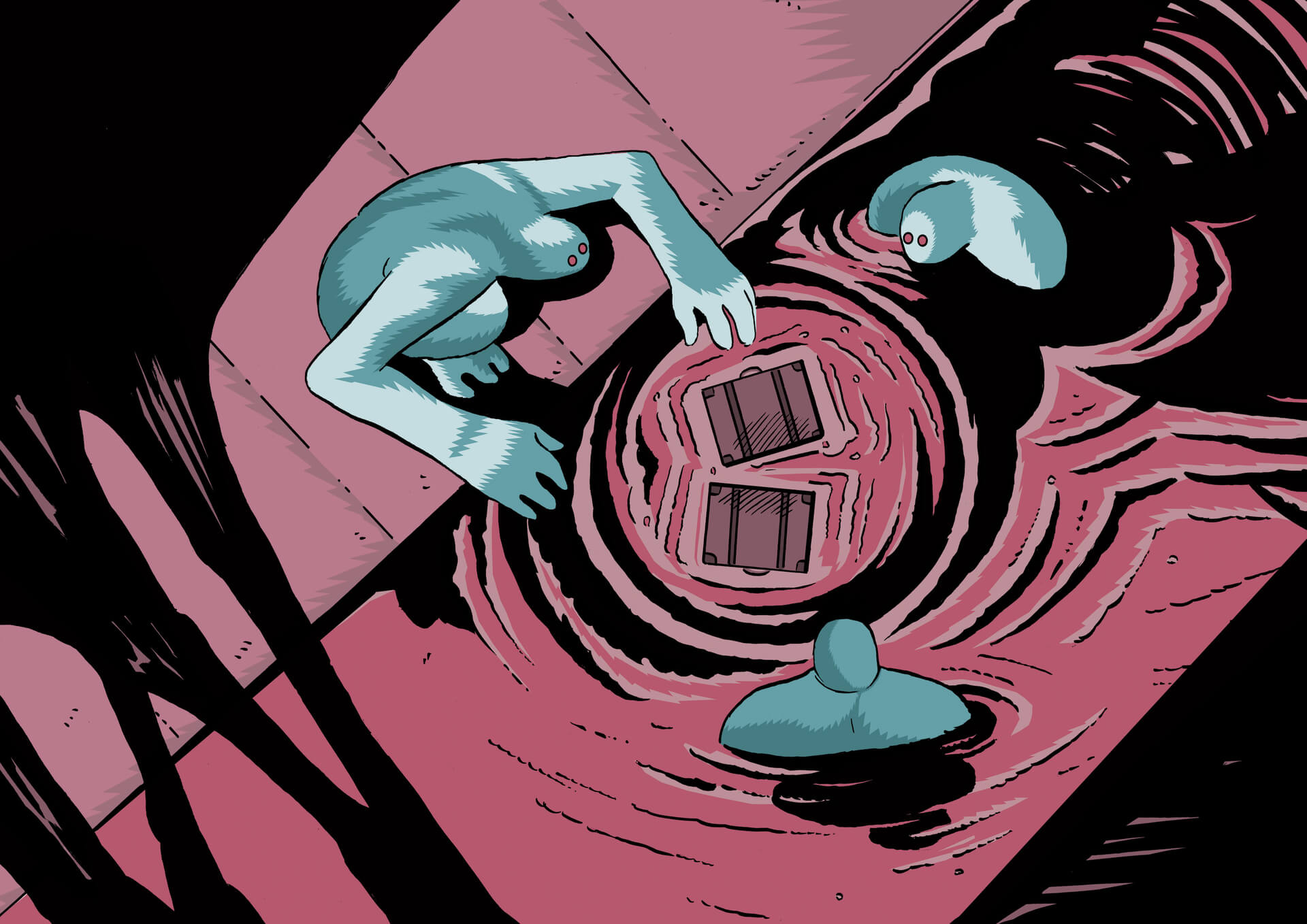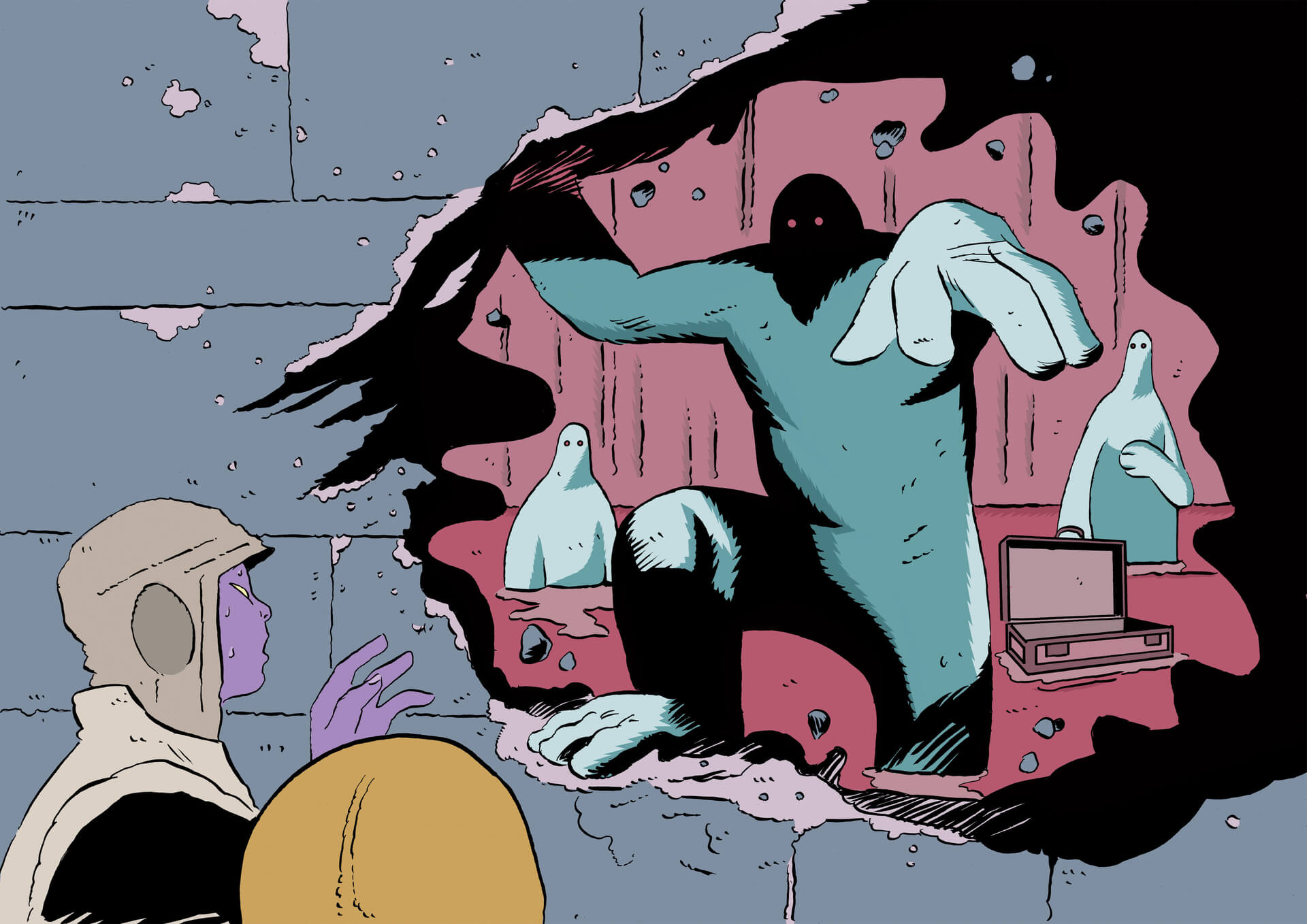VIRUS
Pochi i farmaci per curare il Covid
(e poco utilizzati): ecco perché

Notice: Undefined variable: dizionario in /var/www/nuevo.assediobianco.ch/htdocs/story.php on line 255
di Agnese Codignola
La pandemia di Covid 19, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è finita nel maggio 2023, ma tuttora causa, nel mondo, migliaia di decessi a settimana, stando alle cifre ufficiali. Tra le cause, oltre alla comparsa di varianti sempre molto contagiose, c’è la scarsità di terapie farmacologiche efficaci: di fatto, l’unica realmente utilizzata è il paxlovid di Pfizer, una combinazione di due farmaci, nirmatrelvir e ritonavir, uno dei quali già in uso contro i virus HIV, che va assunto due volte al giorno per una settimana, entro cinque giorni dalla prima diagnosi.
Nei mesi, però, è apparso sempre più chiaro che il farmaco non ha avuto la diffusione prevista, neppure quando è arrivato in farmacia; i motivi sono di vario tipo.
Innanzitutto, il farmaco può interagire con altre terapie, e non è quindi indicato per molti pazienti anziani, che però sarebbero anche i destinatari preferenziali di una terapia antivirale. In realtà, può essere assunto soltanto dopo aver verificato la situazione del malato e le altre cure prescritte, con un protocollo che spesso allunga i tempi anche oltre i cinque giorni, fino a renderne inutile o impossibile la somministrazione.
In alcuni Paesi come l’Italia, poi, la diffusione è stata rallentata a causa del bilancio tra i costi elevati (il prezzo originario era di circa 700 dollari a ciclo) e i benefici, che appaiono netti - e questo è un dato molto importante - per quanto riguarda la riduzione dei decessi (-89%) e l’evoluzione verso forme molto gravi della malattia, ma meno palesi per tutte le altre possibili manifestazioni del Covid. A questo vanno aggiunti i possibili effetti collaterali (che prevedono nausea, alterazioni del gusto e sapore metallico in bocca, diarrea e altro), e il fatto che la sua prescrizione è limitata a persone particolarmente a rischio, come i grandi obesi o i pazienti oncologici. In altre parole, il paxlovid non può essere prescritto a chiunque si ammali di Covid, e anche questo ne ha limitato l’utilizzo da parte dei medici, sia di base che ospedalieri. I quali spesso preferiscono attendere per vedere come evolve la malattia, lasciando involontariamente chiudere la finestra dei cinque giorni utili per somministrare la cura: un vicolo cieco. Secondo un rapporto della società di analisi sanitarie britannica Airfinity, nel Regno Unito i medici hanno prescritto il farmaco solo nello 0,5% dei nuovi casi di Covid. Questa percentuale sale al 13%, per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma è comunque bassa.
Come ricorda la rivista scientifica Nature in un articolo dedicato a questa sotto-utilizzazione, inoltre, c’è un effetto che non è stato ancora del tutto chiarito, ma che è ormai documentato, e si è presentato anche in due malati eccellenti (il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il virologo Anthony Fauci): l’effetto rebound (rimbalzo).
In sintesi, il Covid a volte si ripresenta, spesso più aggressivo di prima, qualche giorno dopo essere scomparso grazie all’antivirale. Secondo la maggior parte dei virologi che stanno cercando di capire che cosa succeda, il motivo è relativamente chiaro. La combinazione dei due antivirali non uccide il virus SARS-CoV-2, responsabile della malattia, ma ne blocca la replicazione, in atto soprattutto nei primi giorni, attraverso l’inibizione di un enzima specifico, una proteasi. Il virus resta dormiente, ma in alcune persone, quando cessa l’assunzione del farmaco, si risveglia, e riprende a replicarsi. Del resto, questo è il motivo per cui la stessa molecola, in funzione anti-AIDS, deve essere assunta per tutta la vita, e non solo per qualche giorno o settimana. Ma i dati sono tuttora contraddittori.
In realtà, secondo Davey Smith, infettivologo dell’Università della California citato da Nature, il paxlovid è attualmente uno dei pochi strumenti per prevenire la morte in persone ad alto rischio e «ha una buona efficacia, anche nel contesto della variante Omicron. Ma il "rimbalzo" - aggiunge Smith - è stato etichettato come un motivo per non assumere il farmaco, il che è un peccato».
Di recente, uno studio pubblicato sul Journal of Medical Virology dagli specialisti dell’Università della California, sede di San Francisco, e focalizzato sul rischio di sviluppare il Long Covid collegato alla terapia, ha fornito una versione del quadro associato a questo farmaco basata su ciò che riferivano i pazienti che hanno preso parte al Covid Citizen Science (CCS) study. In base alle risposte date a specifici questionari online da oltre 4.600 persone, tutte vaccinate, non ricoverate e non in gravidanza se donne, 3.600 delle quali trattate e circa 1.000 no, nei cinque mesi successivi alla cura con paxlovid il 16% aveva sviluppato una forma di Long Covid, contro il 14% di chi non era stato trattato con l’antiviurale.
Per quanto riguarda l’effetto rebound, invece, il 26% circa dei trattati ne aveva avuto uno o comunque un ritorno della positività dei tamponi che, secondo gli autori, non è stato superiore rispetto a quello emerso nelle persone che non avevano assunto paxlovid.
In un altro studio uscito solo poche settimane prima sugli Annals of Internal Medicine, invece, la situazione è sembrata molto diversa. Gli infettivologi del Massachusetts General Hospital di Boston hanno seguito da vicini 142 pazienti trattati e no, e hanno visto che l’incidenza di rebound tra i primi era circa del 20% (in linea, quindi, con i dati dell’altro studio), ma tra i non trattati solo dell’1,8%, un valore che poi è salito a oltre il 2% in seguito ad alcune correzioni. Si tratta di studi molto diversi, che non possono essere confrontati direttamente, e che evidenziano quanto resti ancora da capire.
Inoltre, non ci sono ancora prove definitive sulle cause delle recidive a breve termine che, come già dimostrato in uno studio precedente, possono avvenire anche in persone non curate con l’antivirale. Ma tanto basta a scoraggiare ulteriormente sia i medici che i pazienti. Anche perché non è andata meglio con la molecola che aveva preceduto paxlovid, il molnupiravir dell’azienda Merck, che agisce in modo diverso, ossia generando mutazioni multiple nell’RNA (codice genetico) del virus che, messo a dura prova dai troppi cambiamenti, non riesce a riprodursi. In questo caso, l’efficacia si è rivelata assai scarsa, sui grandi numeri (in alcuni studi quasi nulla), e le difficoltà logistiche del tutto simili.
Ricordiamo anche che nel novembre 2022 il Giappone aveva approvato un altro antivirale, l’ensitrelvir dell’azienda di Osaka Shionogi, da assumere una volta al giorno, ma i dati sono tuttora in attesa di conferme.
Altri farmaci stanno affrontando le sperimentazioni cliniche, e la speranza è che qualcuno di essi abbia successo, visto anche il fallimento di quasi tutti gli anticorpi monoclonaliGli anticorpi monoclonali sono anticorpi del tutto simili a quelli che il sistema immunitario produce contro i “nemici” (batteri, virus e altro ancora), ma non sono presenti in modo naturale nel nostro organismo. Vengono creati in laboratorio, grazie a tecniche di ingegneria genetica, e sono mirati contro un preciso bersaglio della malattia, identificato dai ricercatori: per esempio, nel caso del Covid, contro la proteina Spike, utilizzata dal coronavirus per entrare nelle cellule e infettarle. Una volta prodotti, vengono fatti moltiplicare in laboratorio, identici, in un numero grandissimo di copie, o di cloni (per questo vengono chiamati monoclonali), e poi immessi nell’organismo del paziente, in genere tramite infusione (endovena)., già evidente fino dal secondo anno di pandemia, e poi con la comparsa di Omicron, e reso ufficiale dal ritiro di molte autorizzazioni. Il fatto, del resto, non stupisce, perché l’altissima specificità degli anticorpi monoclonali mal si concilia con l’estrema variabilità dei virus in generale e di SARS-CoV-2 in particolare. Un anticorpo monoclonale, infatti, è una molecola indirizzata contro un preciso bersaglio, in questo caso contro alcune parti della proteina spike. Ma se il bersaglio cambia, cioè muta, è destinato a non essere più riconoscibile, se non parzialmente, dal monoclonale. E la rincorsa alle varianti attraverso la messa a punto di nuovi anticorpi è quasi inutile, perché i tempi necessari per sviluppare e produrre monoclonali aggiornati non coincidono con quelli di un virus che muta continuamente come SARS-CoV-2.
Anche il sotrovimab, "identificato" nel Canton Ticino e poi sviluppato in California dalla Vir Biotechnology, ha mantenuto qualche efficacia contro le varianti di Omicron (dimezza la carica virale), ma a dosaggi tripli rispetto a quelli efficaci con le varianti precedenti, e contro le nuove varianti ha mostrato qualche difficoltà.
In ogni caso, i ricercatori e le aziende che hanno creduto nei monoclonali non si sono dati per vinti, e circa un anno fa hanno chiesto alla Food and Drug Administratio (FDA, l’ente che regola la commercializzazione dei farmaci negli Stati Uniti) e alla European Medicines Agency (EMA) di ammettere un protocollo accelerato rispetto a quello classico per le approvazioni, adottando un approccio chiamato immunobridging. In esso si effettuano test in laboratorio senza più sperimentazioni di grandi dimensioni nell’uomo, dando per scontato che i nuovi anticorpi monoclonali siano poco diversi da quelli tradizionali, e non richiedano ulteriori analisi se non su piccoli campioni per valutarne la sicurezza, e calcoli al computer per i dosaggi. La procedura, già usata per alcuni vaccini come quello antinfluenzale o per i richiami di quelli contro il Covid, permette di arrivare a nuovi anticorpi in soli 3-5 mesi, anche se non modifica i possibili limiti di questi strumenti terapeutici contro i virus nè, tantomeno, i costi elevati.
Anche se le opinioni pubbliche di molti Paesi sono preda di quella che è stata chiamata Pandemic fatigue, e prestano meno attenzione all’andamento della pandemia, il pericolo non è ancora passato, e la ricerca di nuovi strumenti terapeutici resta necessaria, e urgente.
Data ultimo aggiornamento 13 gennaio 2024
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco