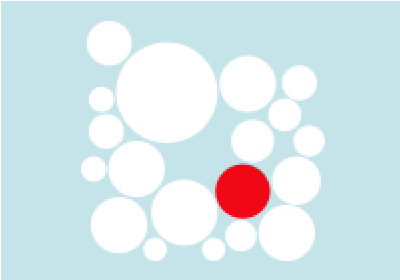CONTRASTI CON LA UE
Fondi europei: in un “limbo”
i ricercatori svizzeri e GB

di Agnese Codignola
I ricercatori svizzeri che speravano di conquistare un bando europeo e di portare avanti, grazie a esso, importanti progetti di ricerca, mettendo insieme un gruppo internazionale del tutto nuovo attorno a un quesito da risolvere, al momento sono in una sorta di limbo. E lo stesso, sia pure con caratteristiche un po’ diverse, accade ad alcuni ricercatori britannici del dopo Brexit. Il 10 gennaio, infatti, l’Unione Europea ha annunciato i nomi dei 397 giovani ricercatori di 22 Paesi cui assegnare 619 milioni di euro per progetti ritenuti particolarmente innovativi dallo European Research Council (ERC), nell’ambito del programma Horizon Europe. Tra i prescelti c’erano anche 28 ricercatori elvetici e 46 britannici che però, per ora, non riceveranno nessuno dei complessivi 95,5 milioni di euro previsti, a meno che non cambino Paese.
Lo stallo non ha nulla a che vedere con la ricerca, e dipende invece dalla politica, dalla diplomazia, dagli accordi economici e commerciali tra gli stati, passati e presenti.
A fare il punto della situazione è la rivista Science, che ricostruisce come si sia arrivati a un’impasse che, al momento, nessuno sa se, come e quando potrà essere superata. Nello scorso mese di giugno, l’Unione Europa ha infatti varato una nuova norma, in base alla quale chi vuole accedere ai bandi del programma Horizon Europe e non è cittadino della UE deve necessariamente lavorare in uno stato-membro o assimilato come Israele, Turchia e Norvegia. Anche la Svizzera lo era, ma è stata esclusa dopo l’annullamento dei colloqui, da parte del governo di Berna, su un trattato generale con l’Unione europea che avrebbe dovuto sostituire più di 120 accordi bilaterali obsoleti su commercio, immigrazione e altri problemi (il governo ha preso questa decisione in seguito alle polemiche che avevano attraversato il parlamento e il mondo politico svizzero, relativamente a questi temi). Lo stop ha suscitato grandi polemiche perché, a detta di molti, a rimetterci sono tutti, e la ricerca è stata trattata come merce di scambio senza nessuna considerazione delle conseguenze.
In prima fila tra gli scontenti, ovviamente, ci sono i ricercatori penalizzati, di cui Science ha raccolto i commenti. Per esempio Heli Huhtamaa, storica del clima dell’Università di Berna, che ha (avrebbe) vinto un finanziamento per studiare in che modo le eruzioni vulcaniche influenzano il clima e la storia delle popolazioni coinvolte, ha fatto notare che trasferirsi a vivere in un altro Paese significherebbe ricominciare tutto daccapo, partendo dalla costruzione di un team di ricerca, impresa che non si realizza certo in poche settimane.
Il governo elvetico ha proposto una soluzione alternativa: si è detto disponibile a finanziare con fondi propri gli studi promossi, a patto che i ricercatori, a loro volta, rimangano in Svizzera. Neppure questo atteggiamento, ovviamente, soddisfa i (mancati) borsisti UE, perché la mobilità, nella ricerca, è fondamentale. Inoltre, per molti si tratterebbe comunque di un ripiego poco attraente, perché borse nazionali, destinate a scienziati che restino rigidamente sul suolo elvetico, non sono paragonabili a borse europee che, per loro natura, spingono alla collaborazione tra gruppi di tutto il mondo, sono considerate molto prestigiose, a livello internazionale e quindi aiutano la carriera anche nei passaggi successivi. Così la pensa, per esempio, Elliott Ash, economista del Politecnico federale (ETH) di Zurigo, vincitore di un finanziamento per sviluppare un programma di intelligenza artificiale che analizzi le decisioni dei giudici. E così la pensa anche Marcel Tanner, presidente delle Accademie svizzere delle Scienze, citando un precedente significativo: nel 2014, in seguito a una serie di restrizioni decise dal popolo svizzero con un referendum (per una manciata di voti) in materia di immigrazione, l’Unione europea ha escluso gli studiosi elvetici da altri bandi dedicati alla ricerca. Il risultato, numeri alla mano, è stata una chiara diminuzione dei progetti di ricerca europei aventi come group-leader uno svizzero, rientrata solo in seguito a una successiva riapertura europea, datata 2017.
Uno dei problemi della situazione attuale è che ci vorranno anni per recuperare i danni prodotti, e non è detto che ci si riesca, come ha sottolineato anche Stefanie Walter, esperta di politiche internazionali dell’Università di Zurigo. Una conferma, del resto, arriva proprio da quanto si è visto in Gran Bretagna, oggetto di uno studio di Benedetto Lepori, esperto in istruzione superiore dell’Università della Svizzera italiana: da quando, nel 2016, è stata decisa la Brexit, la ricerca è diventata rapidamente meno attrattiva, e il Paese, dopo pochissimi anni, ha già perso posizioni nelle classifiche internazionali.
Anche in questa situazione gli ostacoli e i problemi non mancano, nonostante la Gran Bretagna, a differenza della Svizzera, nel 2020 abbia siglato accordi specifici per partecipare a Horizon Europe. Ma per ora si è deciso di rimandare ogni decisione definitiva (e quindi di non erogare i fondi) fino a quando non sarà risolta la questione del confine con l’Irlanda, tuttora oggetto di discussioni molto accese, con posizioni che non sembra facile conciliare.
Se non si riuscirà a trovare un accordo, ai britannici sarà prospettata la soluzione imposta alla Svizzera: l’accesso ai fondi dell’ERC solo per coloro che lavoreranno in un Paese EU. Anche il Governo britannico ha già annunciato di voler agire come quello elvetico, e cioè di concedere lo stesso denaro ai vincitori affinché restino sull’isola, ma i borsisti britannici non sono più soddisfatti di quelli elvetici di una soluzione di questo tipo, per gli stessi motivi. Tutti quelli contattati da Science (sette, tra i quali Marcelo Lozada-Hidalgo, fisico dell’Università di Manchester, che studia setacci di dimensioni nano per separare le molecole) hanno affermato che non pensano di trasferire il loro laboratorio nell’Unione europea a breve termine, ma alcuni hanno affermato che potrebbero farlo in futuro se l’incertezza si trascinerà. Nello stesso tempo hanno ribadito che l’idea di replicare un programma come Horizon Europe su scala nazionale è di per se stessa assurda, e destinata al fallimento, almeno per i prossimi anni.
Mentre si cerca di capire come sbloccare la situazione, i ricercatori sospesi devono ricominciare tutto da capo, e trovare nuovi finanziamenti per svolgere i loro studi dove ritengono più opportuno. Intanto i colleghi europei vanno avanti, reclutando giovani promesse della scienza, acquistando strumenti, stabilendo network internazionali per lavorare in modo più efficiente, rapido e completo.
-----
Nella foto in alto (agenzia iStock), la sede dell’Università di Zurigo
Data ultimo aggiornamento 6 febbraio 2022
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco