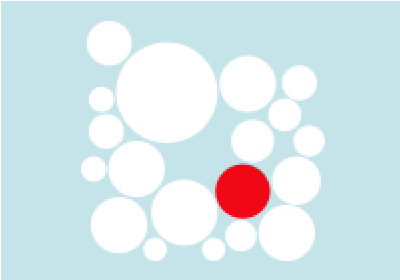TECNICHE D’AVANGUARDIA
A caccia delle cellule rare, che ci salvano la vita
Sono pochissime, una ogni mille, fra quelle che circolano nel sangue, ma forniscono risposte preziose per scoprire malattie come i tumori
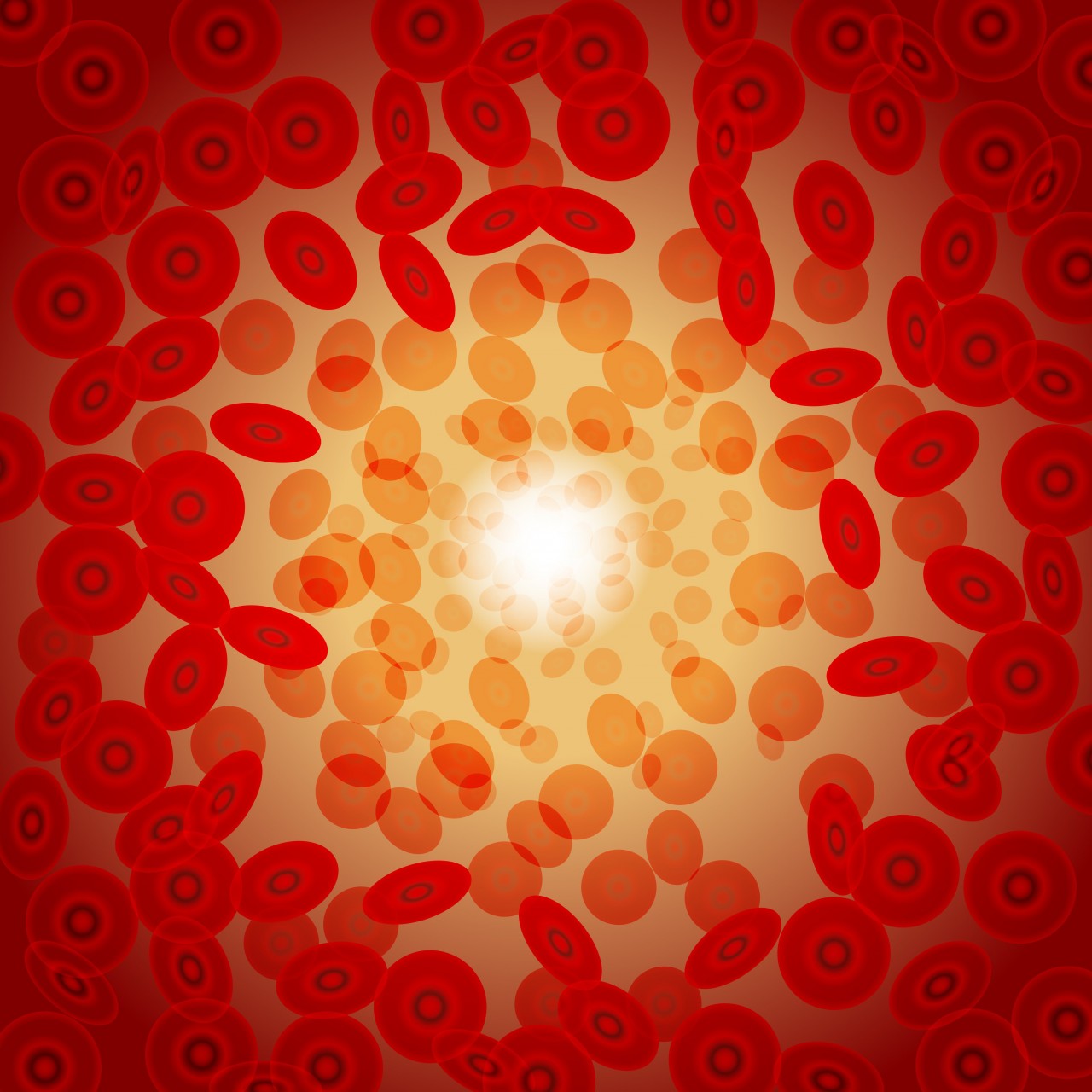
di Giovanni Sabato
Fino a pochi anni fa erano il classico ago nel pagliaio. Ma negli ultimi tempi le tecnologie hanno fatto passi da gigante e adesso studiarle non è più impensabile: anche quelle cellule che circolano nel sangue in quantità minime, disperse fra altre cellule migliaia di volte più abbondanti, si possono isolare e analizzare. E possono dire molto sull’organismo e sulle sue malattie, anche in campo immunitario.
Uno degli artefici di questo salto di qualità è Andrea Cossarizza, docente di patologia generale e immunologia all’Università di Modena e Reggio Emilia, che non a caso a gennaio è stato, con David Cousins dell’Università di Leicester (Gran Bretagna), uno dei due relatori invitati dalla prestigiosa rivista Science a tenere un webinar (cioè un seminario via web) sulla materia.
In letteratura si considerano "rari” i tipi di cellule la cui frequenza nel sangue non supera una su 1.000, ma alcune raggiungono frequenze anche molto inferiori. E alcune sono particolarmente importanti per capire cosa succede nel corpo sano o malato.
«Un esempio importante è quello delle cellule tumorali circolanti, spesso presenti nei pazienti con neoplasie, la cui frequenza molto spesso è proporzionale all’entità del tumore presente - spiega Cossarizza. - Conoscerla, quindi, contribuisce a stabilire la diagnosi, la stadiazione o la prognosi, oppure la malattia minima residua. Quando un malato, per esempio di leucemia, riceve una terapia che pulisce quasi del tutto l’organismo, il problema è il “quasi”: una cellula su 50mila o su 100mila circolanti è ancora una cellula leucemica. È quindi molto utile identificarla, anche per decidere come proseguire la terapia. O ancora ci sono le cellule endoteliali circolanti e i loro precursori, che si modificano in seguito alle lesioni di un ictus o di un infarto».
Innumerevoli sono poi le applicazioni nella ricerca: nel campo delle staminali, ad esempio, per studiare come sono fatte e come funzionano i vari tipi di cellule emopoietiche. O nell’autoimmunità, per studiarne i meccanismi e in prospettiva cercare le cure. «Qualunque cellula immunitaria - continua Cossarizza - che riconosca specificamente un antigene è una cellula rara: i linfociti che ci difendono dal tetano, per fare un esempio, sono molto pochi sul totale delle cellule circolanti. E riconoscerli è importante, perché ci danno un’idea di come funzioni la risposta immunitaria».
Questi studi si facevano anche in passato, ma con una differenza cruciale. Il modo più semplice è sempre stato quello di isolare un piccolo numero delle cellule desiderate (per esempio quelle che riconoscono un certo antigene, una certa molecola) e farle crescere in coltura per una o più settimane, per averne a sufficienza e analizzare le loro funzioni. «Così, però, le cellule cambiano, e quel che trovi alla fine non rispecchia bene quanto succede davvero all’interno dell’organismo - spiega Cossarizza. - Oggi, invece, abbiamo nuovi strumenti che permettono di acquisire un enorme numero di cellule in un tempo ragionevole (noi ne abbiamo uno che ne analizza oltre 35mila al secondo!), e così riusciamo a raccogliere i milioni di cellule che servono per isolare un numero sufficiente della rara popolazione che vogliamo studiare. In questo modo, gli studi funzionali puoi farli subito: raccogli le cellule, dai loro uno stimolo, aspetti qualche ora e vai a vedere cosa fanno. O puoi anche fare studi direttamente sul prelievo ottenuto dal paziente».
I risultati iniziano ad arrivare solo ora e molti sono ancora in via di pubblicazione, vista la novità delle tecniche e i pochi gruppi di ricerca che ancora le padroneggiano. «Siamo rari anche noi - scherza Cossarizza. - D’altronde servono strumenti particolari, e bisogna saperli usare: niente di trascendentale, ma bisogna imparare bene, altrimenti capita di leggere lavori che, per dirla con un eufemismo, lasciano un po’ perplessi. D’altronde il webinar di Science lo hanno seguito più di mille persone, moltissime per un evento simile, a riprova di quanto interesse susciti il tema, e quindi confido che le ricerche in questo campo, e soprattutto la loro qualità, possano aumentare presto».
Un assaggio di quel che si può fare sono gli studi del team di Cossarizza sui cosiddetti linfociti polifunzionali, pubblicati su importanti riviste internazionali. «È una cosa emersa negli ultimi anni: quando un linfocita viene attivato non è detto che abbia una reazione unica e uguale per tutti. Infatti, può produrre più molecole con azioni differenti: per esempio può secernere diverse citochine che stimolano l’attività di altre cellule quali l’interleuchina-2, oppure l’interferone gamma che contrasta i virus, o molecole citotossiche come il fattore di necrosi tumorale, e via dicendo. I nostri lavori, condotti insieme ad altri gruppi, mostrano che nelle persone con infezione da HIV la risposta antivirale è molto più forte quando c’è una buona polifunzionalità: i pazienti che controllano meglio il virus sono quelli che hanno più linfociti polifunzionali. E quindi la prognosi è migliore. Altri hanno visto la stessa cosa per il citomegalovirus. E ora stiamo studiando il fenomeno nel processo di invecchiamento, nei cosiddetti grandi vecchi. E anche qui pare che la polifunzionalità dei linfociti sia una delle armi vincenti dell’organismo».
Data ultimo aggiornamento 26 marzo 2015
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco
Tags: Andrea Cossarizza, autoimmunità, tumori