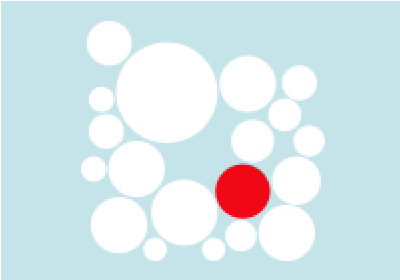SPERIMENTAZIONE
Psoriasi, terapie più mirate con i monoclonali
Gli studi sull’anticorpo BI 655066, pubblicati negli Stati Uniti, stanno aprendo la strada a nuove molecole che, finalmente, sembrano avere un impatto "forte" sulle lesioni cutanee provocate dalla malattia, con pochi effetti collaterali.

di Emanuela Di Pasqua
Agnese Codignola
Se i risultati pubblicati alcune settimane fa sul Journal of Allergy and Clinical Immunology dai ricercatori della Rockfeller University di New York saranno confermati, la terapia della psoriasi potrebbe essere a una svolta importante. Un anticorpo monoclonale chiamato BI 655066, per ora sperimentale, somministrato a una trentina di pazienti con psoriasi da media a grave, in otto centri americani, si è infatti dimostrato in grado di far regredire le lesioni cutanee dell’80% circa: un effetto molto potente, e rimasto stabile nelle sei settimane successive.
L’anticorpo BI 655066 è diretto contro una delle molecole più coinvolte nella psoriasi, l’interleuchina 23, sulla quale i ricercatori di New York stavano lavorando da tempo. Tra i vari anticorpi studiati, il BI 655066 si è rivelato particolarmente efficace: basta una sola somministrazione per avere un’azione evidente, e di lunga durata. Al momento non sembrano esserci effetti collaterali gravi, peraltro spesso presenti, invece, nelle terapie convenzionali della malattia, basate sull’immunosoppressione. Gli studi proseguono, ma questi dati, se non altro, confermano che, molto probabilmente, l’interleuchina 23 è un bersaglio imprescindibile se si vuole trovare una cura definitiva per la malattia.
Le interleuchine sono proteine secrete da diversi tipi di cellule del nostro apparato diifensivo (linfociti, cellule NK, fagociti, cellule dendritiche), durante la risposta immunitaria. Ne esistono di vario tipo e l’interleuchina 23, in particolare, ha un ruolo nell’angiogenesi, ovvero nella creazione di nuovi vasi sanguigni.
BERSAGLI PRECISI - La ricerca si sta muovendo già da tempo nella direzione seguita dagli studiosi americani: produrre anticorpi monclonali, cioè, mirati verso molecole "peculiari" della psoriasi. Si era cominciato con un bersaglio - il TNF, cioè Tumor Necrosis Factor, fattore di necrosi tumorale - che è presente in molte forme di infiammazioni (anche se questo non significa assolutamente che sia presente un tumore: la molecola ha preso questo nome semplicemente perché, per la prima volta, è stata identificata dagli oncologi, però3 è presente in molti altri "eventi" biologici che con il tumore non hanno alcun legame). Ma l’interleuchina 23 è un bersaglio molto più "definito" e tipico della psoriasi. «Questa malattia chiama in causa sia l’immunità innata, cioè quella legata a meccanismi arcaici, sia quella acquisita, attraverso un sistema più raffinato che coinvolge linfociti e immunoglobine» - spiega Luigi Naldi, dermatologo dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ed proprio sulle sostanze prodotte dai linfociti che i ricercatori hanno puntato l’attenzione.
LE CAUSE DELLA MALATTIA - La psoriasi è una patologia dalle origini non perfettamente definite e, a causa delle conseguenze estetiche, può avere un forte impatto psicologico su chi ne soffre. A tutt’oggi non sono disponibili cure in grado di neutralizzarla, ma soltanto rimedi per attenuarne la sintomatologia. Le lesioni tipiche di questa malattia sono chiazze rosse ricoperte di squame bianche, che colpiscono in particolare gomiti, ginocchia e cuoio capelluto. Le forme lievi possono essere trattate con farmaci a uso topico e fototerapia (raggi ultravioletti). Il 30-35% dei pazienti soffre, invece, di forme moderate o gravi della malattia, che richiedono un approccio terapeutico più complesso.
Secondo alcuni studiosi, le prime descrizioni riguardanti la psoriasi comparirebbero già nei Codici Assiro Babilonesi (2000 a.C. circa), in alcuni papiri egiziani e in diversi libri dell’Antico Testamento, nei quali si parla di malattie cutanee squamo crostose.
LA "COMPONENTE" IMMUNITARIA - «Fino a una trentina di anni fa la psoriasi era considerata una malattia priva di interesse immunologico - spiega Paolo Pigatto, dermatologo del Policlinico di Milano e professore associato all’Università degli Studi del capoluogo lombardo. - Per molto tempo, infatti, veniva semplicemente vista come un disturbo dell’epidermide e dei cheratinociti (cellule specializzate della pelle, ndr). Solo recentemente si è iniziato a considerare l’eccessiva riproduzione delle cellule della pelle come risultato di fattori legati al sistema immunitario». In sostanza i linfociti T si attiverebbero e migrerebbero verso il derma, innescando - per motivi che ancora non conosciamo bene - il rilascio eccessivo di molecole chiamate citochine (in particolare il fattore di necrosi tumorale-alfa TNF-α), che a loro volta causerebbero infiammazione e riproduzione rapida di cellule della pelle stessa.
«In realtà - aggiunge Luigi Naldi - c’è ancora incertezza nel considerare la psoriasi come una malattia autoimmune (visto che fino a oggi non è stato ancora identificato con certezza un antigene esterno che agisca come elemento scatenante), oppure come una più generica disregolazione del sistema immunitario».
Oggi la teoria più accreditata descrive la psoriasi come una malattia multifattoriale, nella quale anomalie dell’apparato immunitario si sommano a fattori genetici e ambientali.
In alcuni casi la psoriasi si presenta insieme all’artrite, tanto che si parla di artrite psorisiaca. «In questi casi - spiega Pigatto - l’infiammazione non riguarda solo la pelle, ma anche le articolazioni. Si è calcolato che, nella malattia psorisiaca, esiste circa il 30 per cento delle possibilità di avere anche un’artrite».
I FARMACI - Al momento le più diffuse terapie per curare la psoriasi prevedono l’uso di pomate ad uso locale, a base di sostanze idratanti, acido acetilsalicilico e cortisonici. Ma, come dicevamo, si utilizza anche la fototerapia, praticata grazie all’uso di speciali lampade a raggi ultravioletti.
Quando questi trattamenti non sono sufficienti, si ricorre a farmaci immunosoppressori come la ciclosporina (lo stesso medicinale usato per ridurre il rigetto nei pazienti che hanno subitp un trapianto), o a farmaci cosiddetti target (ovvero mirati), che vengono prodotti attraverso le tecniche del DNA ricombinante e agiscono su specifiche molecole presenti nella psoriasi, quali - come si diceva - il TNF o diversi tipi di interleuchina. Anche l’anticorpo monoclonale BI 655066, attualmente in sperimentazione, appartiene a questa categoria.
FATTORI DI RISCHIO – Nell’ambito di uno studio da poco pubblicato sulla rivista JAMA Dermatology, i ricercatori hanno identificato, fra 80mila donne coinvolte, circa 850 casi di psoriasi, rilevando un’incidenza maggiore in quante soffrivano d’ipertensione da sei anni o più, rispetto alle altre. È stata poi individuata una probabilità maggiore di sviluppare la psoriasi fra le pazienti curate da oltre sei anni con i betabloccanti (queste donne hanno mostrato una propensione a sviluppare la malattia in modo più severo). Il solito fumo e il solito alcol, così come l’obesità e la familiarità, rappresentano altri fattori di rischio importanti. Infine situazioni stressanti o malattie infettive possono rappresentare fattori scatenanti. ’
Data ultimo aggiornamento 19 aprile 2015
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco