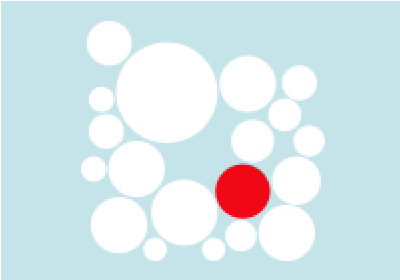NATURE
“Misurare” il sistema immunitario
per capire come evolve la SLA
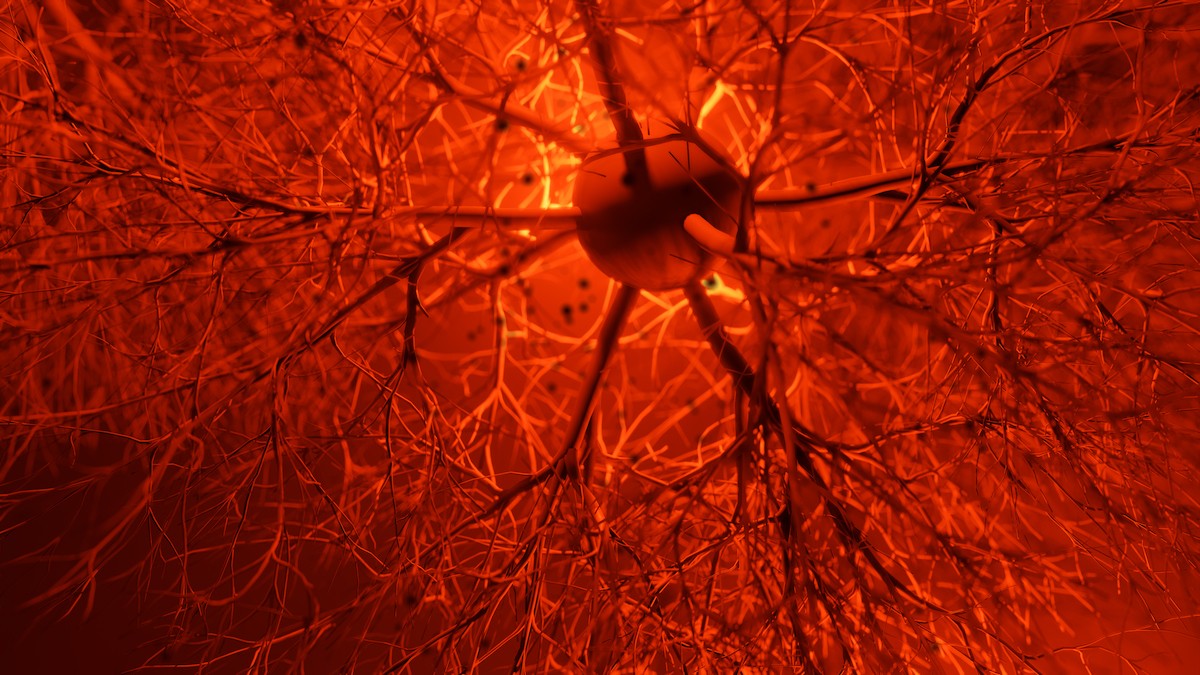
di Agnese Codignola
La sclerosi laterale amiotrofica o SLA, malattia neurodegenerativa che danneggia le cellule nervose coinvolte nella trasmissione degli stimoli alla muscolatura, potrebbe avere anche una componente immunitaria. La conferma arriva da un team coordinato da Ivan Marazzi, originario della provincia di Pavia, spostatosi nel Canton Ticino, all’Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) di Bellinzona, dopo la laurea in biologia in Italia, per il dottorato, e ora professore associato di microbiologia presso la Icahn School of Medicine del Mount Sinai Hospital di New York, dove ha già ricevuto significativi riconoscimenti per i suoi studi sulle malattie neurodegenerative, e dove ha pubblicato gli ultimi, importanti risultati sulla rivista scientifica Nature.
Invece che concentrarsi esclusivamente sugli aspetti neurologici della SLA, Marazzi e il suo team hanno provato a guardare altrove (al di là, quindi, del sistema nervoso) e, in particolare, al sistema immunitario adattativo (la parte più “specializzata” del nostro apparato difensivo) e ai diversti tipi di linfociti T, cellule fondamentali. Per capire se ci fosse un tipo (o più) particolarmente importante, i ricercatori hanno lavorato con animali da laboratorio che presentavano una delle possibili forme della SLA, la 4, caratterizzata dalla mutazione di un gene che codifica per una proteina chiamata senataxina (SETX). Chi soffre della SLA di tipo 4 inizia a mostrare i primi sintomi attorno ai trent’anni (è una forma giovanile) e la malattia progredisce lentamente. Questo “percorso” è presente sia negli uomini, che negli animali da laboratorio.
Studiando il sangue degli animali, i ricercatori hanno visto che presentava alte concentrazioni di un particolare tipo di linfociti T, i CD8 TEMRA, da terminally differentiated effector memory. Anche nelle persone malate di SLA di tipo 4 la concentrazione la concentrazione dei CD8 TEMRA è risultata particolarmente elevata, e proporzionale alla progressione della malattia.
Il risultato di Marazzi ha diverse implicazioni. Innanzitutto, porta nuova luce sul coinvolgimento del sistema immunitario nella SLA (è già stato dimostrato che diversi geni associati alla malattia influenzano le funzioni immunitarie, ma ancora molti aspetti sono da chiarire). In secondo luogo, suggerisce che sia possibile tracciare un profilo immunologico per ogni paziente e per ogni fase della malattia, in base alla caratterizzazione delle sottopopolazioni di linfociti, e che questo permetta, in un certo modo, di misurare l’andamento della patologia stessa.
Inoltre, autorizza a cercare nuovi approcci terapeutici, che partano appunto dalla specificità immunitaria, per una malattia contro la quale, al momento, ve ne sono pochissimi, e tutti incentrati sul tentativo di fermare la neurodegenerazione.
Infine, c’è un ulteriore aspetto degno di approfondimenti. I linfociti CD8 TEMRA hanno una spiccata attività antitumorale (come tutti i CD8), particolarmente evidente contro una forma di tumore cerebrale molto difficile da curare, il glioma. Bisognerà comprendere meglio a che cosa sia dovuta, ma i ricercatori già ipotizzano di sfruttarla in chiave antitumorale, appunto.
NUOVO FARMACO APPROVATO IN CANADA - Per quanto riguarda i farmaci contro la SLA, nei giorni scorsi, l’agenzia sanitaria canadese Health Canada ha approvato un medicinale dell’azienda statunitense Amylyx Pharmaceuticals, suscitando sia speranze che polemiche. Si tratta della combinazione di due molecole, il sodio fenilbutirrato e il taurursodiolo, che dovrebbero proteggere i neuroni. Il nuovo farmaco ha mostrato una modesta efficacia (riduzione di 2 punti su una scala di 48) in uno studio condotto contro un placebo su 137 pazienti. La Food and Drug Administration statunitense (FDA, l’ente che controlla i farmaci) nella sua valutazione di qualche mese fa aveva rimandato a fine settembre la decisione su Albrioza (questo il nome commerciale del farmaco), perché nonostante non fossero emersi motivi di preoccupazione in merito alla sicurezza, l’efficacia sembrava ancora tutta da dimostrare.
Nonostante le polemiche che alcuni mesi fa hanno accompagnato l’approvazione di un anticorpo monoclonale molto discusso contro l’Alzheimer e di altri farmaci autorizzati troppo frettolosamente negli ultimi anni, la tendenza a concedere il via libera a terapie costose (per Albrioza il prezzo non è ancora noto, ma si parla di 180.000 dollari all’anno, come minimo), in base a effetti tutto fuorché netti, ottenuti su poche decine di pazienti, non sembra conoscere ostacoli, soprattutto quando i malati hanno a disposizione poche alternative.
-----
Nella foto in alto, dell’agenzia iStock, una ricostruzione al computer dei neuroni (le cellule nervose del cervello)
Data ultimo aggiornamento 30 giugno 2022
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco