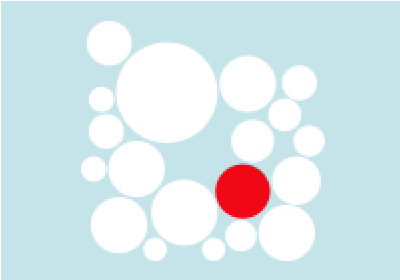RICHARD HORTON
«Collaborazione sul Covid?
Bilancio di un fallimento»

di Paola Scaccabarozzi
Richard Horton, il direttore di The Lancet, una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo, nel suo ultimo libro "Covid-19. La catastrofe. Cosa non ha funzionato e come evitare che si ripeta", Il Pensiero Scientifico Editore, ha analizzato ciò che è accaduto e, per certi versi sta ancora accadendo, riguardo alla risposta globale nei confronti della pandemia di Covid-19. Ciò che ne è emerso è un fallimento di collaborazione internazionale, l’acuirsi di sovranismi imperanti, la rivalità di potere che ha accecato i Paesi di fronte al comune obiettivo di salvaguardia della salute dei cittadini di tutto il mondo.
Dall’analisi di Horton risultano evidenti anche le ripercussioni legate allo smantellamento dei sistemi sanitari, avvenuto in numerosi stati nel corso dei decenni passati, così come emergono grossi problemi comunicativi, sia a livello scientifico, sia a livello mediatico. In ultima analisi ciò che scaturisce dalla disamina lucida e attenta del direttore di “The Lancet” è un pregiudizio cognitivo legato alla presunzione degli esseri umani, che continuano a ignorare gli insegnamenti precedenti.
Horton in particolare punta il dito sulla gestione politica (oltre che su grossi errori scientifici e di comunicazione) in relazione alla pandemia e non esita a definire la risposta dei governi al Covid il più grande fallimento politico delle democrazie occidentali dopo la seconda guerra mondiale. “I fallimenti sono stati molti - scrive. - Prima di tutto, c’è il fallimento da parte dei consulenti tecnici. Nonostante avessero a disposizione alcuni degli scienziati più competenti al mondo, Paesi come Stati Uniti, Italia, Spagna e Regno Unito non sono stati in grado di sfruttare le proprie conoscenze e competenze per fornire le opportune raccomandazioni per prevenire i terribili impatti della pandemia”.
La ragione? “L’Occidente - continua Horton - si aspettava che questa pandemia infettiva fosse un nuovo ceppo di influenza. L’idea che un virus simile alla Sars, più grave, potesse esistere non è stata nemmeno presa in considerazione. La piccola élite di scienziati governativi non ha considerato nessuna alternativa a ciò che si aspettava: il pensiero di gruppo era palesemente errato. Davvero questi scienziati hanno letto e preso sul serio i primi rapporti del Covid-19 provenienti dalla Cina, rapporti che mettevano in guardia in modo chiaro e inequivocabile sulla gravità e potenzialità del nuovo virus? Hanno seguito le indicazioni di medici e scienziati di Paesi che, per primi, hanno sperimentato i disastrosi effetti del Covid-19? Se la risposta è no, perché non lo hanno fatto?”.
Horton prosegue mettendo in luce un secondo fallimento, ossia quello relativo al processo politico decisionale: “il compito della politica - scrive - non è solo quello di accettare passivamente i consigli ricevuti [dagli scienziati], ma anche di esaminare, valutare e mettere in discussione le informazioni”.
Il terzo punto è quello che riguarda le gravi falle nella leadership politica. I governi di vari Paesi, sottolinea Horton, non sono cioè stati in grado di creare gruppi d’azione per sviluppare una visione comune e informazioni univoche e utili alla gestione della pandemia. Non hanno inoltre instillato senso di fiducia e sicurezza fra i cittadini.
Il quarto aspetto è quello relativo al ritardo della fornitura di indispensabili dispositivi di protezione individuale come mascherine e disinfettanti, nonostante l’avvertimento di Wuhan. A ciò si aggiunge la difficoltà da parte dei governi di tenere il passo del virus con un tracciamento efficiente dei contatti. Non da poco i problemi di comunicazione: messaggi confusi e contraddittori sono stati fuorvianti e si sono rivelati pericolosi. In sostanza, scrive letteralmente Horton, “i governi sono stati complici e responsabili di questo disastro”.
Alla base di tutto una grave negligenza che parte da lontano, non troppo in realtà, ossia dall’insegnamento ignorato dell’epidemia di Sars 2002-3. “Alla fine del 2002 nella provincia del Guangdong nella Cina meridionale - ricorda Horton - un nuovo coronavirus fu trasmesso da un animale all’uomo”. Il contagio si verificò molto probabilmente in un mercato di animali vivi. Altri focolai furono segnalati subito dopo e, nel gennaio 2003, un team di ricercatori cinesi concluse che la causa fosse proprio un nuovo coronavirus. Complice il Capodanno cinese, il virus si diffuse e, con l’aumento dei contagi, la notizia arrivò all’OMS. I funzionari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità chiesero informazioni al governo cinese, che fece presente il diffondersi di una malattia respiratoria grave che aveva colpito circa 305 persone. Anche Hong Hong fu colpita da un’epidemia generata da questo nuovo virus. Ci furono anche casi in Vietnam, Canada, Singapore, Irlanda e Stati Uniti, tanto che il 12 marzo 2003, l’OMS lanciò l’allarme mondiale. “Il severo contenimento portò allo spegnimento dell’epidemia nel maggio 2003 - scrive Horton - e questo particolare coronavirus da allora non si è più ripresentato. Ma le sue conseguenze furono enormi”.
Si verificò a seguire un grosso crack economico che colpì in particolar modo la Cina e Hong Kong, ma SARS-CoV-1 avrebbe dovuto anche impartirci un’importante lezione: “la risposta a un virus in grado di diffondersi così velocemente e in modo così irruente non può essere casuale, ma dev’essere coordinata” - suggerisce Horton.
In buona sostanza, la comparsa della Sars ha evidenziato che sarebbe stata necessaria una costante serie di investimenti per rispondere con solerzia all’evento di una prossima e pressoché certa malattia emergente, come è avvenuto proprio proprio con SARS-CoV-2 (il virus che ha determinato la malattia Covid-19), a distanza di meno di un ventennio. Il rischio di emergenze umanitarie mondiali causate da virus era stato infatti identificato, successivamente alla Sars, come un pericolo reale e attuale, ma è stato totalmente ignorato.
Non ci si può dunque giustificare dando la colpa a una mancata consapevolezza, come sottolineò nel 1994 anche la giornalista scientifica americana, Laurie Garrett, vincitrice del Premio Pulitzer per le sue inchieste sui virus e autrice di The coming plague: negli emerging diseases in a world out of balance (Harmondsworth, Penguin 1994). Laurie Garrett scrisse: “Alla fine, l’essere umano dovrà cambiare mentalità rispetto al proprio posizionamento nella catena trofica terrestre se vuole evitare una prossima pandemia o se vuole sopravvivere… nel mondo dei microbi la guerra è una costante… Abbiamo poco tempo”.
Nel 2004 l’Institute of medicine (ora chiamato National Academy of Medicine) degli Stati Uniti dichiarò che “il rapido contenimento della Sars ha rappresentato una vittoria della salute pubblica, ma anche un avvertimento”. Quello che è emerso dalle risposte mondiali alla pandemia è, in ultima analisi, un mondo sempre più frammentato e confuso, in cui si è scatenato uno tsunami misto di odio, negazione e allarmismo.
Un fatto, secondo Horton, è pressoché certo: ne usciremo diversi, e le ricadute della pandemia avverranno a tutti i livelli, sociale, economico, scientifico, medico, psicologico e culturale. Una lezione epocale che ha cambiato il mondo. Probabilmente - sottolinea in più occasioni Horton - non si tornerà completamente alla normalità, anche in presenza di un vaccino, “perché un vaccino purtroppo non è una bacchetta magica". Non è detto, poi - continua il direttore di Lancet - che ogni cittadino si sottoporrà al vaccino, né che questo sarà infallibile. Forse il Covid-19 rappresenta un confine invalicabile tra due ere della nostra esistenza, dal quale non è più possibile tornare indietro”.
Un’occasione che ha messo, dunque, in evidenza non solo la nostra fragilità, la nostra scarsa attenzione all’ambiente e ai più fragili, ma la necessità di ricordarci di essere un’identità umana globale in cui la libertà individuale è strettamente connessa a quella degli altri esseri umani. “Il Covid-19 - conclude Horton - ci ha insegnato che siamo anche esseri reciproci”.
---
Nella foto, Richard Horton, ritratto da Manuel Vazquez (agenzia Getty Images)
Data ultimo aggiornamento 27 marzo 2021
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco
Tags: coronavirus, Covid-19, recensioni