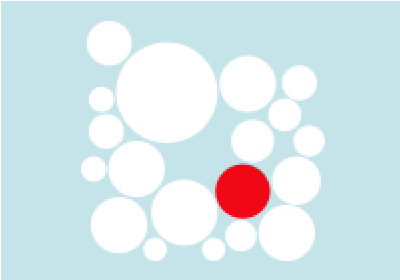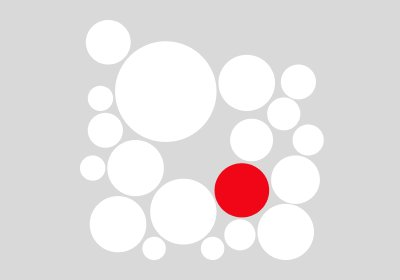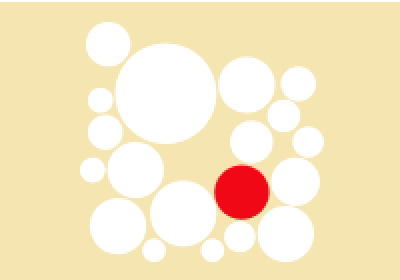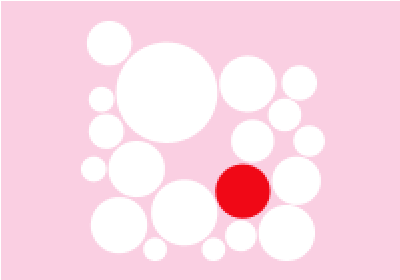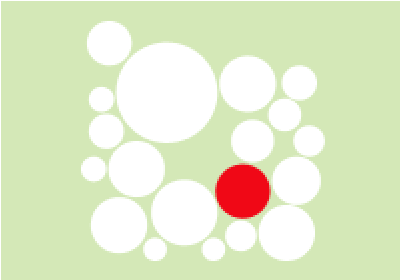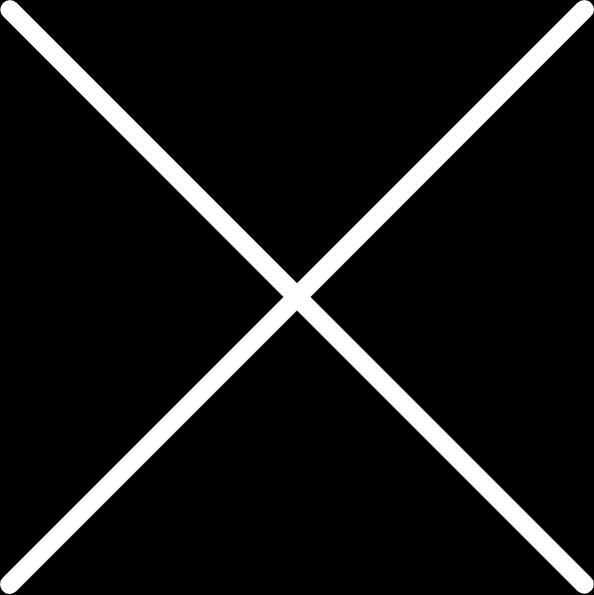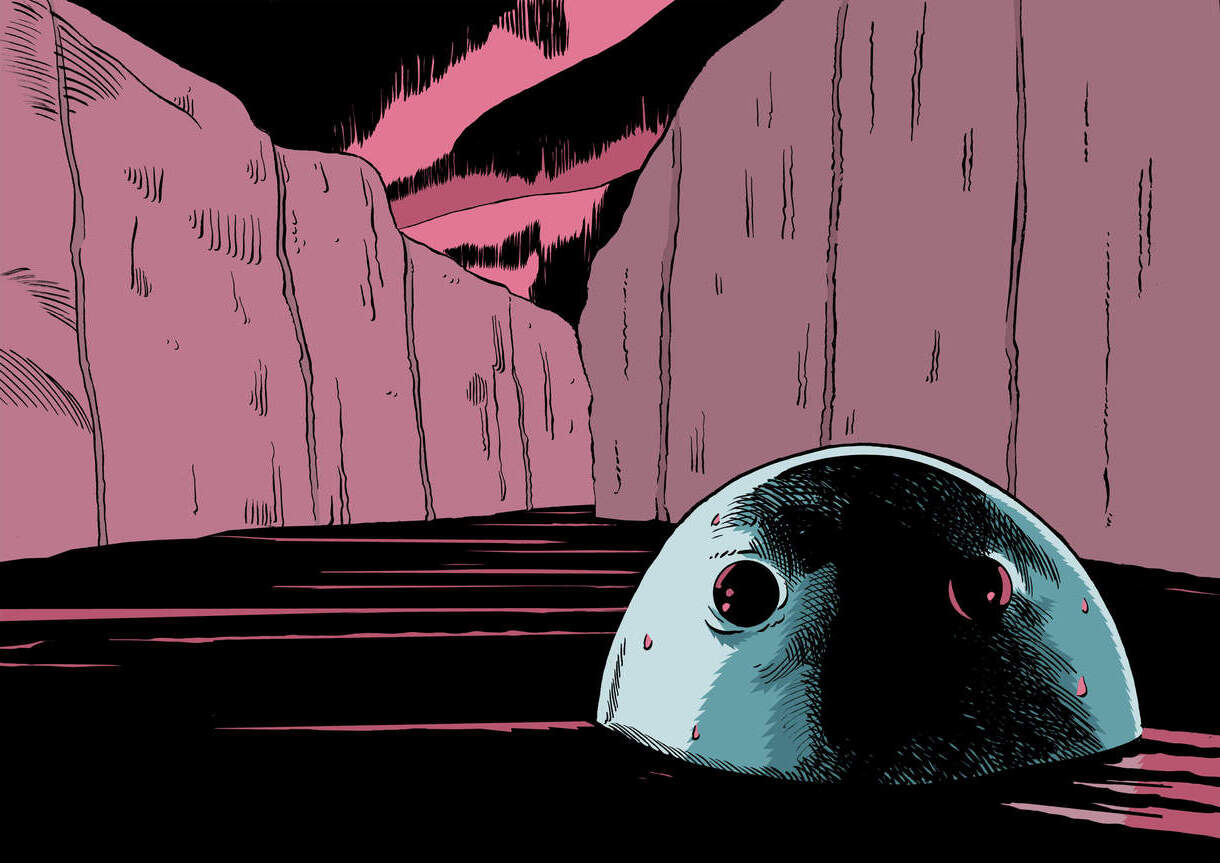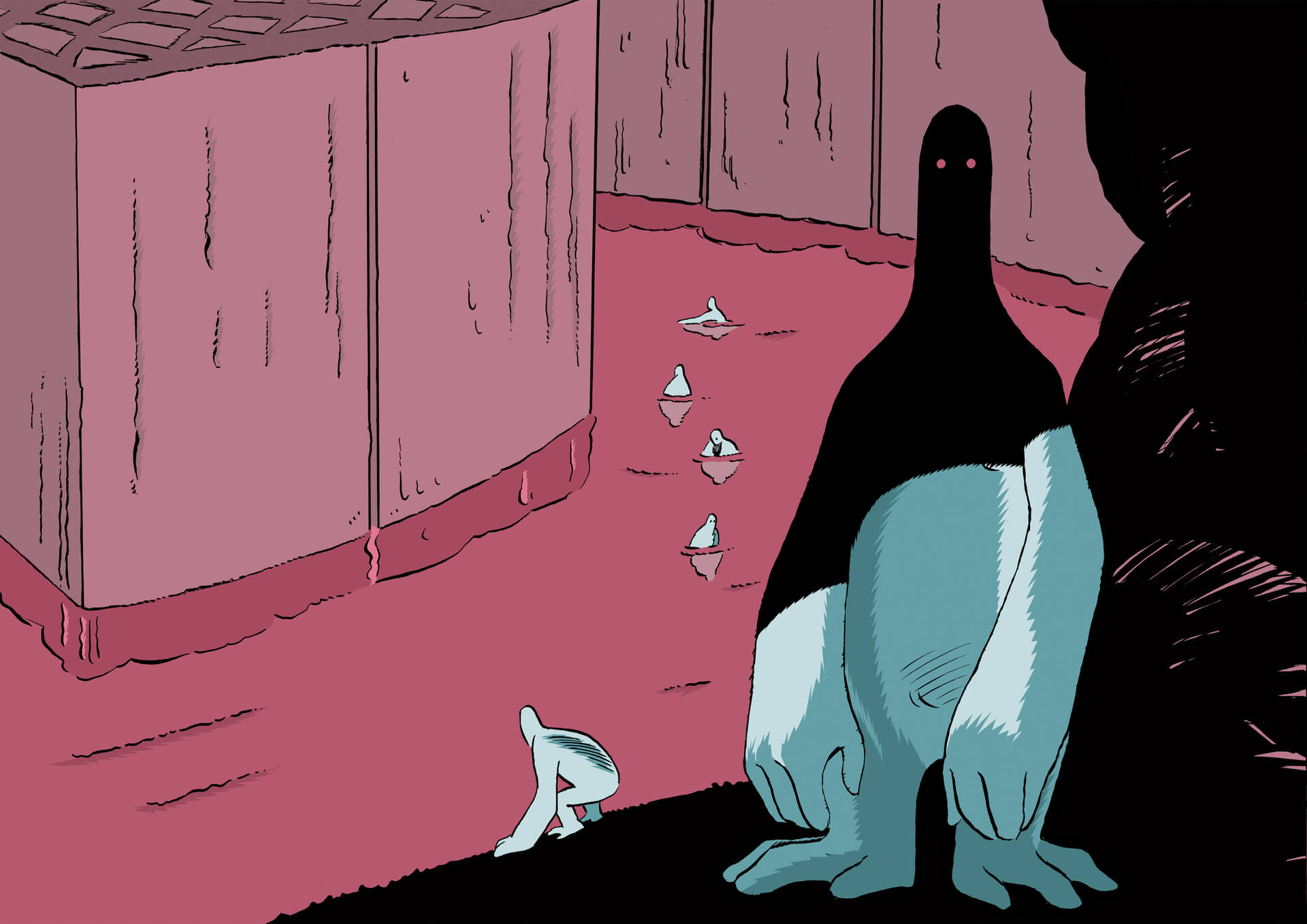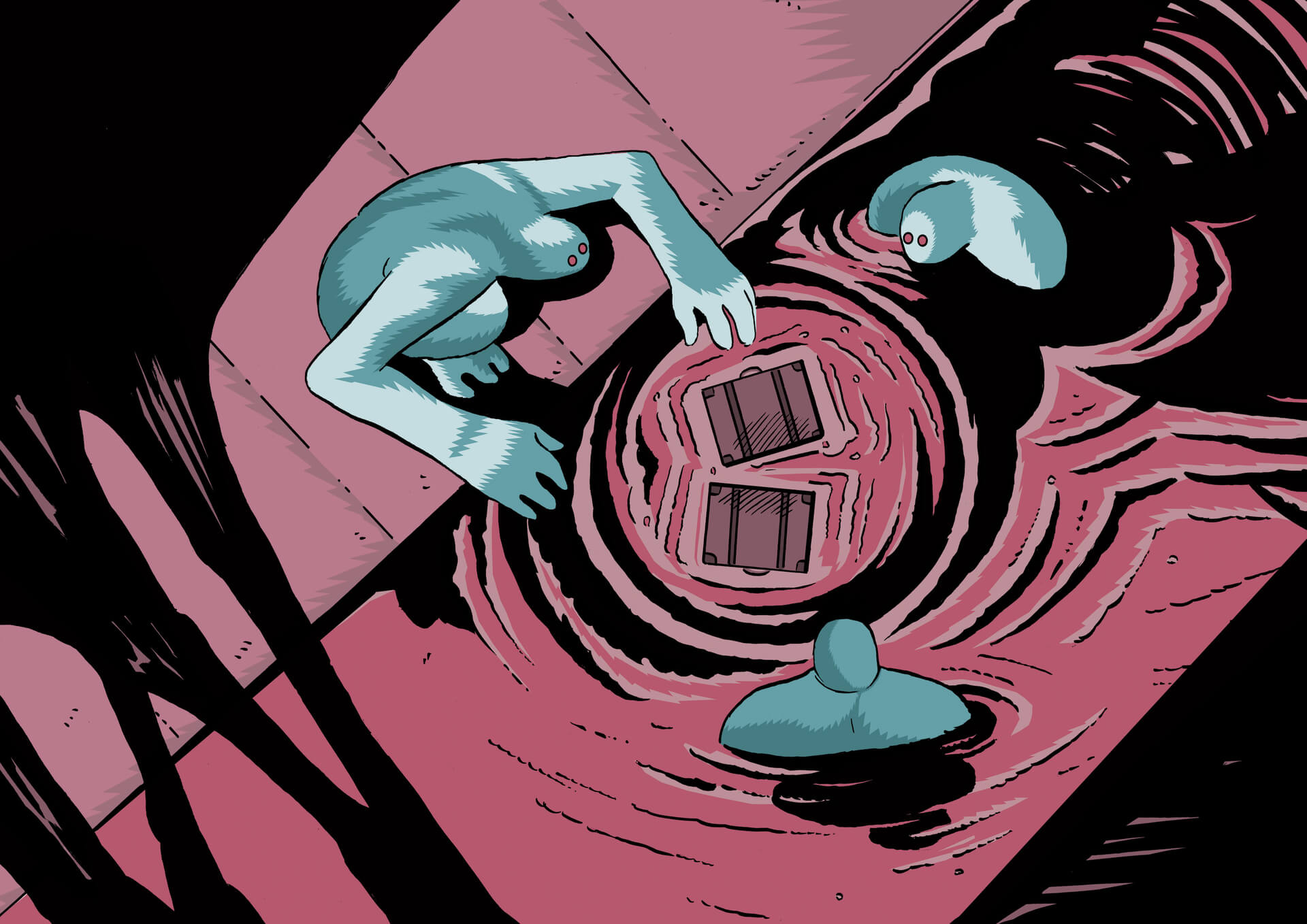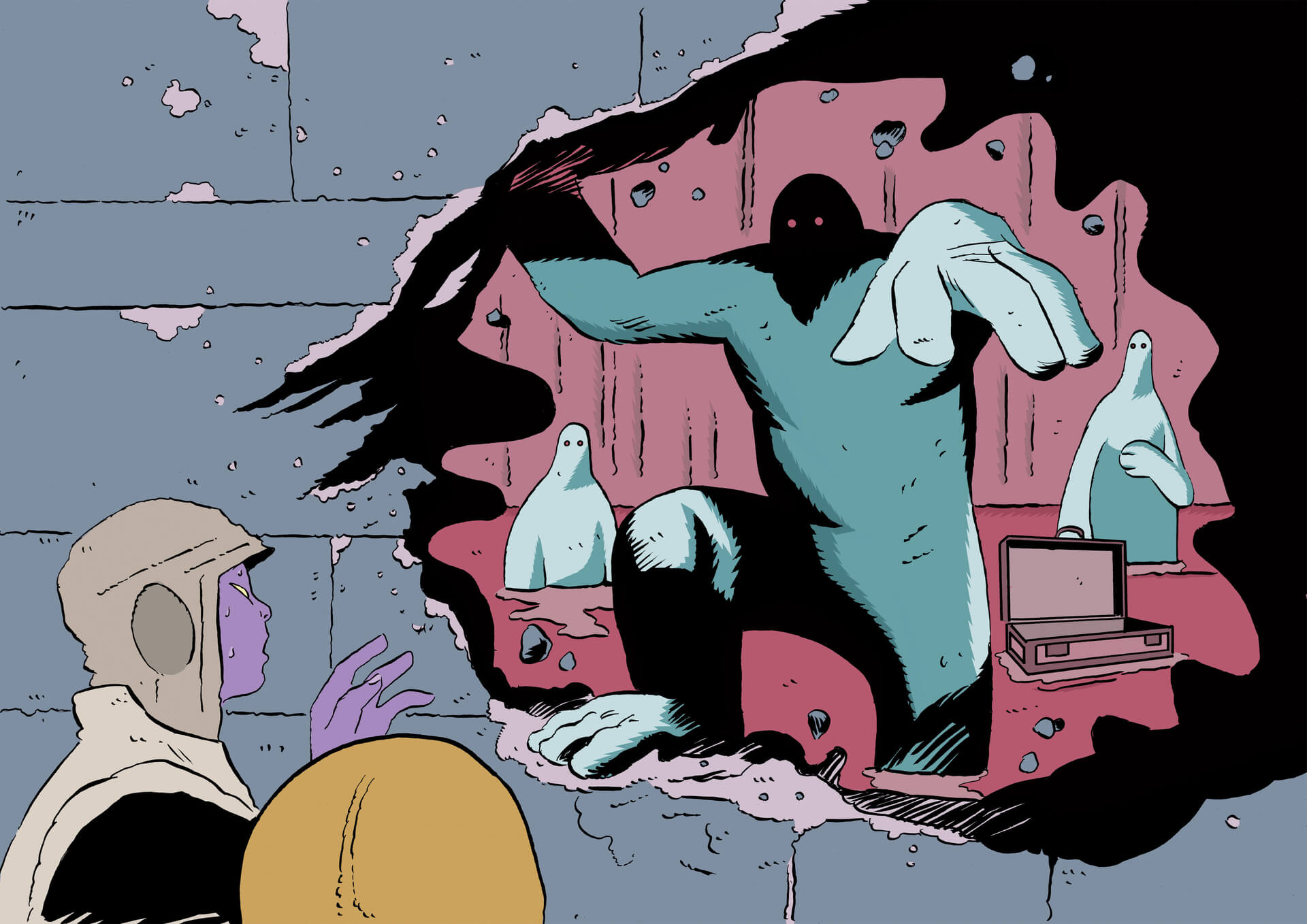NUOVI STUDI
Tempestività della cura e dieta "giusta":
così è possibile frenare la psoriasi

di Agnese Codignola
Da una quindicina di anni la vita di chi soffre di psoriasi – non meno di cento milioni di persone nel mondo - è cambiata molto: in meglio. Con l’arrivo delle terapie biologiche, costituite da anticorpi monoclonaliGli anticorpi monoclonali sono anticorpi del tutto simili a quelli che il sistema immunitario produce contro i “nemici” (batteri, virus e altro ancora), ma non sono presenti in modo naturale nel nostro organismo. Vengono creati in laboratorio, grazie a tecniche di ingegneria genetica, e sono mirati contro un preciso bersaglio della malattia, identificato dai ricercatori: per esempio, nel caso del Covid, contro la proteina Spike, utilizzata dal coronavirus per entrare nelle cellule e infettarle. Una volta prodotti, vengono fatti moltiplicare in laboratorio, identici, in un numero grandissimo di copie, o di cloni (per questo vengono chiamati monoclonali), e poi immessi nell’organismo del paziente, in genere tramite infusione (endovena). diretti contro mediatori tipici dell’infiammazione e dell’autoimmunità come le interleuchine (nello specifico quelle chiamate 23 e la 17, IL23 e IL17) e il fattore di necrosi tumorale alfa (TNF alfa), le crisi possono essere controllate, il loro numero e la loro intensità fatte decrescere fino quasi a scomparire. C’è però un prezzo da pagare: per mantenere la malattia silente o quantomeno non troppo attiva, è necessario assumere queste terapie per tutta la vita, e rischiare così effetti negativi derivanti da un’azione cronica sui delicati equilibri del sistema immunitario. Eliminare o ridurre molto le interleuchine può rendere infatti la risposta agli agenti patogeni meno efficiente, far aumentare in certi casi (tenuti sotto stretto controllo dagli immunologi) il rischio di alcuni tipi di tumori e scatenare malattie infiammatorie dell’intestino, per citare solo alcuni degli effetti già noti. Inoltre, quella contro le citochine è un’azione a valle, che interviene sugli effetti della malattia, e non sulle sue cause, che restano in gran parte misteriose.
Questo accade perché è molto difficile cogliere la prima manifestazione della psoriasi, che spesso non viene riconosciuta, e finora non sono mai stati identificati una proteina o un suo frammento (peptide) che possano dare il via al fenomeno autoimmune e, di conseguenza, non è stato possibile arrivare a una vera e propria cura.
Da qualche tempo, però, alcuni dei ricercatori che lavorano nel settore si stanno concentrando su quel 10-20% di pazienti che ha una reazione inattesa alle terapie biologiche, particolarmente positiva: dopo un primo ciclo di anticorpi monoclonali non hanno più ricadute e, apparentemente, sono guariti. Perché? Che cosa accade in queste persone? Possono evitare di assumere le terapie? E che cosa si può capire dalla loro condizione per estenderne i benefici a tutti?
A queste domande la rivista Nature ha dedicato un articolo, nel quale fa il punto sulle sperimentazioni al momento in corso con le terapie disponibili: il secukinumab (di Novartis), diretto contro l’interleuchina 17 (IL17), e il guselkumab (di Johnson & Johnson), specifico contro IL23.
In uno degli studi citati, pubblicato nel 2024, sono stati analizzati i dati di due gruppi di persone che avevano preso parte ad altrettante sperimentazioni cliniche (per un totale di circa 220 pazienti). I partecipanti avevano assunto il secukinumab per un anno, e poi erano stati seguiti nei mesi seguenti. Nel primo studio il 20 e il 10% dei partecipanti non aveva avuto bisogno di ulteriori somministrazioni dopo, rispettivamente, uno e due anni. Nel secondo, nel quale l’anticorpo era a un dosaggio dimezzato, le percentuali equivalenti erano risultate essere del 14 e del 6%.
Fino dai primi risultati, però, è emerso subito il ruolo chiave del fattore-tempo: più breve era stata la fase acuta della malattia, perché diagnosticata in tempo e trattata tempestivamente, maggiori erano state le probabilità di rientrare in quel 10-20%. Coloro che avevano avuto una malattia non curata per almeno cinque anni, invece, non ricadevano quasi mai nella categoria di chi “guariva”, e gli altri erano in situazioni intermedie. Come fa notare Curdin Conrad, dermatologo dell’Università di Basilea ed esperto di psoriasi, sembra esistere una finestra di tempo che rende gli interventi particolarmente efficaci. Quando questa si chiude, è molto più improbabile tenere sotto controllo la malattia. Conrad ne è così convinto che ha lanciato uno studio chiamato STEPIn, nel quale lo scopo era verificare che cosa accadeva a pazienti la cui psoriasi era diventata grave entro un anno dalla diagnosi, ed erano stati trattati per un anno con secukinumab. Dopo i 12 mesi, più del 90% dei pazienti aveva avuto una riduzione del 90% della gravità e della diffusione della malattia. Ciò che è successo nei due anni successivi, e cioè qual è la stata la percentuale di remissioni in questi pazienti trattati precocemente, vero scopo del trial, dovrebbe essere reso noto nei prossimi mesi. Se emergerà che la maggior parte delle persone è rimasta stabile, questo andrà a sostenere l’idea che l’intervento debba il più precoce possibile.
Un altro trial clinico, chiamato GUIDE, nel frattempo, sta valutando l’effetto di una riduzione graduale del dosaggio di guselkumab. L’intervento sull’IL23, tra l’altro, sembra anche più potete di quello sull’IL17 del secukinumab. Secondo i primi risultati resi noti, coloro che hanno risposto meglio alla terapia possono dimezzare la dose. Nella fase finale dello studio si valuterà anche la totale sospensione, almeno nei soggetti che hanno avuto le risposte migliori.
LE CONSEGUENZE CLINICHE - Anche se non ci sono ancora certezze o indicazioni, i risultati di queste sperimentazioni in parte sono già stati recepiti dalla comunità dei dermatologi, che stanno iniziando a offrire le terapie molto presto, ai pazienti che hanno un esordio di malattia grave, o che evolvono rapidamente dopo la diagnosi. Finora, di solito si attendeva qualche mese, verificando l’efficacia di terapie topiche a base di cortisonici e comunque non sistemiche.
Inoltre, si inizia a pensare che anche le persone con le forme lievi potrebbero trarre giovamento da un’azione molto più precoce di quella attuale. Lo si è visto, per esempio, in uno studio del 2022 in persone con psoriasi cosiddetta guttata, cioè con lesioni limitate, che di solito si risolve rapidamente, ma che nel 30% dei casi si aggrava e diventa cronica, a placche. La terapia precoce permette a una parte di costoro di avere una malattia molto attenuata.
Tra l’altro, prevenire l’aggravamento potrebbe avere anche altri effetti positivi, perché la psoriasi, già associata a un aumento del rischio di malattie reumatiche, diabete, infarti e altro, sarebbe anche responsabile di un aumento rilevante del rischio di sviluppare una maculopatia in età senile. Lo suggerisce uno studio appena presentato al congresso della European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) svoltosi a Parigi. I ricercatori dell’Università di Rochester (Minnesota) hanno lavorato su 15 anni di dati di oltre 22.000 persone con psoriasi e dell’età media di 55 anni al momento dell’inclusione. Confrontando la situazione di costoro con quella di persone a rischio di maculopatia per altri motivi, e cioè la presenza di una depressione clinica o la comparsa di nevi melanocitici, è emerso che chi aveva la psoriasi aveva un rischio maggiore rispettivamente del 56 e del 21% di avere la maculopatia nei dieci anni successivi. Il legame sarebbe dovuto ad alterazioni nel metabolismo dei grassi, che hanno conseguenze sulla macula. Ma il trattamento con anticorpi sarebbe risultato associato a una diminuzione del rischio del 27% rispetto a nessun trattamento.
MISTERI MOLECOLARI - Il meccanismo per ora non è noto. Nella psoriasi, come in tutte le malattie autoimmuni, le protagoniste sono le cellule T, i linfociti che reagiscono contro qualche proteina o peptide dell’organismo come farebbero contro quello di un invasore. Nel caso della psoriasi, non è ancora stato identificato il frammento di proteina che confonde i linfociti T. In molti li stanno cercando perché, qualora fossero identificati, si potrebbe studiare una sorta di vaccinazione che riprogrammi il sistema immunitario affinché non reagisca più a essi.
Intanto, però, si è capito che una sottoclasse di linfociti è particolarmente coinvolta: quella delle cellule chiamate Tissue resident memory o TRM, molto abbondanti nella cute. In tutti gli studi clinici con terapie specifiche, uno degli effetti che si nota è la diminuzione di questi specifici linfociti. E quando la cura viene interrotta, di solito il loro numero torna a salire, così come accade durante le crisi o la formazione o l’estensione delle placche, tutti segni evidenti del loro coinvolgimento.
Tuttavia, finora non sono mai state progettate terapie che abbassino sistematicamente il numero dei linfociti TRM,, perché la loro funzione è proteggere la cute da tutti i patogeni, e si pensa che un intervento sistemico di quel tipo potrebbe comportare rischi troppo grandi. Piuttosto, ci sono studi su possibili interventi locali sui TRM, pensati per le forme lievi, che restano stabili.
In alternativa, Conrad studia il sistema immunitario innato, che non utilizza i linfociti, e che ha una sua memoria, al contrario di quanto si è pensato per lungo tempo. Nel 2017, per esempio, si è scoperto che, nella simil-psoriasi dei topi, le cellule fondamentali sono quelle della memoria innata dei cheratinociti, le cellule della cute dalle quali si formano le placche. Secondo quanto osservato, alla base della malattia c’è una riprogrammazione di quelle cellule di tipo epigenetico, che interviene quindi sull’espressione di certi geni. L’attivazione o spegnimento di alcuni geni è innescato da una risposta allo stress cronico, che induce un’infiammazione anch’essa cronica. La psoriasi potrebbe quindi avere una sua firma epigenetica, che sarebbe facilmente individuabile e che rappresenterebbe una sorta di cicatrice immunitaria epigenetica: chiusa nei momenti di quiescenza, ma pronta a riaprirsi nelle riacutizzazioni. Ma c’è di più. La presenza di queste cicatrici spiegherebbe anche la finestra temporale utile per gli interventi sulle interleuchine. Secondo Conrad, agire precocemente potrebbe infatti contribuire a diminuire il numero di cicatrici epigenetiche, fino a eliminarle del tutto, correggendo i difetti epigenetici, almeno in alcune persone. Questa ipotesi è stata confermata da alcuni dati dello studio STEPIN presentati a un congresso: i pazienti che hanno risposto meglio, dopo 12 mesi di terapia avevano meno cicatrici epigenetiche rispetto a prima del trattamento. Al contrario, che era malato da almeno cinque anni aveva un numero di cicatrici molto più elevato della media, e ne aveva ancora numerose dopo le cure (anche se il loro numero era diminuito rispetto a prima). Può essere quindi che prolungando la terapia le cicatrici spariscano del tutto, ma potrebbe essere utile anche disporre di terapie che intervengano direttamente su di esse, cioè sull’espressione dei geni coinvolti. Se si mettessero a punto farmaci di questo tipo, spiega infine Conrad, si potrebbe forse rinunciare agli interventi con gli anticorpi più a valle, sulle interleuchine.
Gli studi sono dunque in corso su molteplici fronti, e secondo Conrad entro al massimo dieci anni i pazienti avranno finalmente a disposizione vere e proprie cure, efficaci e specifiche.
IL RUOLO DELLA DIETA - In attesa di nuovi test e terapie, anche la dieta può avere un ruolo importante. Lo ha dimostrato uno studio pubblicato su JAMA Dermatology nell’ambito del quale 37 pazienti sono stati invitati a seguire una dieta mediterranea per 16 settimane oppure una genericamente a basso contenuto di grassi. Alla fine i primi avevano avuto una riduzione media delle crisi di 3,4 punti, mentre i controlli non avevano avuto nessun beneficio. Circa metà di chi aveva seguito la dieta mediterramnea ha avuto una riduzione del 75% delle lesioni, parametro considerato limite per definire una cura efficace. La dieta mediterranea, grazie all’elevato contenuto in antiossidanti, esercita una significativa azione antinfiammatoria che, a sua volta, aiuta a prevenire e attenuare le riacutizzazioni. Scegliere attentamente che cosa mangiare può quindi fare la differenza.
Data ultimo aggiornamento 9 gennaio 2026
© Riproduzione riservata | Assedio Bianco